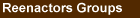
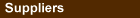
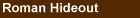

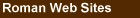

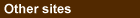
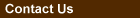

|
|
De Bello Gallico
Caius Iulius Caesar
La guerra in Gallia di Gaio Giulio Cesare
| Latino |
Italiano |
C. IULI CAESARIS COMMENTARIORUM DE BELLO GALLICO
LIBER PRIMUS
[1] Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Eorum una, pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit a flumine Rhodano, continetur Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum, attingit etiam ab Sequanis et Helvetiis flumen Rhenum, vergit ad septentriones. Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni, spectant in septentrionem et orientem solem. Aquitania a Garumna flumine ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani quae est ad Hispaniam pertinet; spectat inter occasum solis et septentriones.
[2] Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. Is M. Messala, [et P.] M. Pisone consulibus regni cupiditate inductus coniurationem nobilitatis fecit et civitati persuasit ut de finibus suis cum omnibus copiis exirent: perfacile esse, cum virtute omnibus praestarent, totius Galliae imperio potiri. Id hoc facilius iis persuasit, quod undique loci natura Helvetii continentur: una ex parte flumine Rheno latissimo atque altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis dividit; altera ex parte monte Iura altissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios; tertia lacu Lemanno et flumine Rhodano, qui provinciam nostram ab Helvetiis dividit. His rebus fiebat ut et minus late vagarentur et minus facile finitimis bellum inferre possent; qua ex parte homines bellandi cupidi magno dolore adficiebantur. Pro multitudine autem hominum et pro gloria belli atque fortitudinis angustos se fines habere arbitrabantur, qui in longitudinem milia passuum CCXL, in latitudinem CLXXX patebant.
[3] His rebus adducti et auctoritate Orgetorigis permoti constituerunt ea quae ad proficiscendum pertinerent comparare, iumentorum et carrorum quam maximum numerum coemere, sementes quam maximas facere, ut in itinere copia frumenti suppeteret, cum proximis civitatibus pacem et amicitiam confirmare. Ad eas res conficiendas biennium sibi satis esse duxerunt; in tertium annum profectionem lege confirmant. Ad eas res conficiendas Orgetorix deligitur. Is sibi legationem ad civitates suscipit. In eo itinere persuadet Castico, Catamantaloedis filio, Sequano, cuius pater regnum in Sequanis multos annos obtinuerat et a senatu populi Romani amicus appellatus erat, ut regnum in civitate sua occuparet, quod pater ante habuerit; itemque Dumnorigi Haeduo, fratri Diviciaci, qui eo tempore principatum in civitate obtinebat ac maxime plebi acceptus erat, ut idem conaretur persuadet eique filiam suam in matrimonium dat. Perfacile factu esse illis probat conata perficere, propterea quod ipse suae civitatis imperium obtenturus esset: non esse dubium quin totius Galliae plurimum Helvetii possent; se suis copiis suoque exercitu illis regna conciliaturum confirmat. Hac oratione adducti inter se fidem et ius iurandum dant et regno occupato per tres potentissimos ac firmissimos populos totius Galliae sese potiri posse sperant.
[4] Ea res est Helvetiis per indicium enuntiata. Moribus suis Orgetoricem ex vinculis causam dicere coegerunt; damnatum poenam sequi oportebat, ut igni cremaretur. Die constituta causae dictionis Orgetorix ad iudicium omnem suam familiam, ad hominum milia decem, undique coegit, et omnes clientes obaeratosque suos, quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit; per eos ne causam diceret se eripuit. Cum civitas ob eam rem incitata armis ius suum exequi conaretur multitudinemque hominum ex agris magistratus cogerent, Orgetorix mortuus est; neque abest suspicio, ut Helvetii arbitrantur, quin ipse sibi mortem consciverit.
[5] Post eius mortem nihilo minus Helvetii id quod constituerant facere conantur, ut e finibus suis exeant. Ubi iam se ad eam rem paratos esse arbitrati sunt, oppida sua omnia, numero ad duodecim, vicos ad quadringentos, reliqua privata aedificia incendunt; frumentum omne, praeter quod secum portaturi erant, comburunt, ut domum reditionis spe sublata paratiores ad omnia pericula subeunda essent; trium mensum molita cibaria sibi quemque domo efferre iubent. Persuadent Rauracis et Tulingis et Latobrigis finitimis, uti eodem usi consilio oppidis suis vicisque exustis una cum iis proficiscantur, Boiosque, qui trans Rhenum incoluerant et in agrum Noricum transierant Noreiamque oppugnabant, receptos ad se socios sibi adsciscunt.
[6] Erant omnino itinera duo, quibus itineribus domo exire possent: unum per Sequanos, angustum et difficile, inter montem Iuram et flumen Rhodanum, vix qua singuli carri ducerentur, mons autem altissimus impendebat, ut facile perpauci prohibere possent; alterum per provinciam nostram, multo facilius atque expeditius, propterea quod inter fines Helvetiorum et Allobrogum, qui nuper pacati erant, Rhodanus fluit isque non nullis locis vado transitur. Extremum oppidum Allobrogum est proximumque Helvetiorum finibus Genava. Ex eo oppido pons ad Helvetios pertinet. Allobrogibus sese vel persuasuros, quod nondum bono animo in populum Romanum viderentur, existimabant vel vi coacturos ut per suos fines eos ire paterentur. Omnibus rebus ad profectionem comparatis diem dicunt, qua die ad ripam Rhodani omnes conveniant. Is dies erat a. d. V. Kal. Apr. L. Pisone, A. Gabinio consulibus.
[7] Caesari cum id nuntiatum esset, eos per provinciam nostram iter facere conari, maturat ab urbe proficisci et quam maximis potest itineribus in Galliam ulteriorem contendit et ad Genavam pervenit. Provinciae toti quam maximum potest militum numerum imperat (erat omnino in Gallia ulteriore legio una), pontem, qui erat ad Genavam, iubet rescindi. Ubi de eius adventu Helvetii certiores facti sunt, legatos ad eum mittunt nobilissimos civitatis, cuius legationis Nammeius et Verucloetius principem locum obtinebant, qui dicerent sibi esse in animo sine ullo maleficio iter per provinciam facere, propterea quod aliud iter haberent nullum: rogare ut eius voluntate id sibi facere liceat. Caesar, quod memoria tenebat L. Cassium consulem occisum exercitumque eius ab Helvetiis pulsum et sub iugum missum, concedendum non putabat; neque homines inimico animo, data facultate per provinciam itineris faciundi, temperaturos ab iniuria et maleficio existimabat. Tamen, ut spatium intercedere posset dum milites quos imperaverat convenirent, legatis respondit diem se ad deliberandum sumpturum: si quid vellent, ad Id. April. reverterentur.
[8] Interea ea legione quam secum habebat militibusque, qui ex provincia convenerant, a lacu Lemanno, qui in flumen Rhodanum influit, ad montem Iuram, qui fines Sequanorum ab Helvetiis dividit, milia passuum XVIIII murum in altitudinem pedum sedecim fossamque perducit. Eo opere perfecto praesidia disponit, castella communit, quo facilius, si se invito transire conentur, prohibere possit. Ubi ea dies quam constituerat cum legatis venit et legati ad eum reverterunt, negat se more et exemplo populi Romani posse iter ulli per provinciam dare et, si vim facere conentur, prohibiturum ostendit. Helvetii ea spe deiecti navibus iunctis ratibusque compluribus factis, alii vadis Rhodani, qua minima altitudo fluminis erat, non numquam interdiu, saepius noctu si perrumpere possent conati, operis munitione et militum concursu et telis repulsi, hoc conatu destiterunt.
[9] Relinquebatur una per Sequanos via, qua Sequanis invitis propter angustias ire non poterant. His cum sua sponte persuadere non possent, legatos ad Dumnorigem Haeduum mittunt, ut eo deprecatore a Sequanis impetrarent. Dumnorix gratia et largitione apud Sequanos plurimum poterat et Helvetiis erat amicus, quod ex ea civitate Orgetorigis filiam in matrimonium duxerat, et cupiditate regni adductus novis rebus studebat et quam plurimas civitates suo beneficio habere obstrictas volebat. Itaque rem suscipit et a Sequanis impetrat ut per fines suos Helvetios ire patiantur, obsidesque uti inter sese dent perficit: Sequani, ne itinere Helvetios prohibeant, Helvetii, ut sine maleficio et iniuria transeant.
[10] Caesari renuntiatur Helvetiis esse in animo per agrum Sequanorum et Haeduorum iter in Santonum fines facere, qui non longe a Tolosatium finibus absunt, quae civitas est in provincia. Id si fieret, intellegebat magno cum periculo provinciae futurum ut homines bellicosos, populi Romani inimicos, locis patentibus maximeque frumentariis finitimos haberet. Ob eas causas ei munitioni quam fecerat T. Labienum legatum praeficit; ipse in Italiam magnis itineribus contendit duasque ibi legiones conscribit et tres, quae circum Aquileiam hiemabant, ex hibernis educit et, qua proximum iter in ulteriorem Galliam per Alpes erat, cum his quinque legionibus ire contendit. Ibi Ceutrones et Graioceli et Caturiges locis superioribus occupatis itinere exercitum prohibere conantur. Compluribus his proeliis pulsis ab Ocelo, quod est oppidum citerioris provinciae extremum, in fines Vocontiorum ulterioris provinciae die septimo pervenit; inde in Allobrogum fines, ab Allobrogibus in Segusiavos exercitum ducit. Hi sunt extra provinciam trans Rhodanum primi.
[11] Helvetii iam per angustias et fines Sequanorum suas copias traduxerant et in Haeduorum fines pervenerant eorumque agros populabantur. Haedui, cum se suaque ab iis defendere non possent, legatos ad Caesarem mittunt rogatum auxilium: ita se omni tempore de populo Romano meritos esse ut paene in conspectu exercitus nostri agri vastari, liberi
[eorum] in servitutem abduci, oppida expugnari non debuerint. Eodem tempore quo Haedui Ambarri, necessarii et consanguinei Haeduorum, Caesarem certiorem faciunt sese depopulatis agris non facile ab oppidis vim hostium prohibere. Item Allobroges, qui trans Rhodanum vicos possessionesque habebant, fuga se ad Caesarem recipiunt et demonstrant sibi praeter agri solum nihil esse reliqui. Quibus rebus adductus Caesar non expectandum sibi statuit dum, omnibus, fortunis sociorum consumptis, in Santonos Helvetii pervenirent.
[12] Flumen est Arar, quod per fines Haeduorum et Sequanorum in Rhodanum influit, incredibili lenitate, ita ut oculis in utram partem fluat iudicari non possit. Id Helvetii ratibus ac lintribus iunctis transibant. Ubi per exploratores Caesar certior factus est tres iam partes copiarum Helvetios id flumen traduxisse, quartam vero partem citra flumen Ararim reliquam esse, de tertia vigilia cum legionibus tribus e castris profectus ad eam partem pervenit quae nondum flumen transierat. Eos impeditos et inopinantes adgressus magnam partem eorum concidit; reliqui sese fugae mandarunt atque in proximas silvas abdiderunt. Is pagus appellabatur Tigurinus; nam omnis civitas Helvetia in quattuor pagos divisa est. Hic pagus unus, cum domo exisset, patrum nostrorum memoria L. Cassium consulem interfecerat et eius exercitum sub iugum miserat. Ita sive casu sive consilio deorum immortalium quae pars civitatis Helvetiae insignem calamitatem populo Romano intulerat, ea princeps poenam persolvit. Qua in re Caesar non solum publicas, sed etiam privatas iniurias ultus est, quod eius soceri L. Pisonis avum, L. Pisonem legatum, Tigurini eodem proelio quo Cassium interfecerant.
[13] Hoc proelio facto, reliquas copias Helvetiorum ut consequi posset, pontem in Arari faciendum curat atque ita exercitum traducit. Helvetii repentino eius adventu commoti cum id quod ipsi diebus XX aegerrime confecerant, ut flumen transirent, illum uno die fecisse intellegerent, legatos ad eum mittunt; cuius legationis Divico princeps fuit, qui bello Cassiano dux Helvetiorum fuerat. Is ita cum Caesare egit: si pacem populus Romanus cum Helvetiis faceret, in eam partem ituros atque ibi futuros Helvetios ubi eos Caesar constituisset atque esse voluisset; sin bello persequi perseveraret, reminisceretur et veteris incommodi populi Romani et pristinae virtutis Helvetiorum. Quod improviso unum pagum adortus esset, cum ii qui flumen transissent suis auxilium ferre non possent, ne ob eam rem aut suae magnopere virtuti tribueret aut ipsos despiceret. Se ita a patribus maioribusque suis didicisse, ut magis virtute contenderent quam dolo aut insidiis niterentur. Quare ne committeret ut is locus ubi constitissent ex calamitate populi Romani et internecione exercitus nomen caperet aut memoriam proderet.
[14] His Caesar ita respondit: eo sibi minus dubitationis dari, quod eas res quas legati Helvetii commemorassent memoria teneret, atque eo gravius ferre quo minus merito populi Romani accidissent; qui si alicuius iniuriae sibi conscius fuisset, non fuisse difficile cavere; sed eo deceptum, quod neque commissum a se intellegeret quare timeret neque sine causa timendum putaret. Quod si veteris contumeliae oblivisci vellet, num etiam recentium iniuriarum, quod eo invito iter per provinciam per vim temptassent, quod Haeduos, quod Ambarros, quod Allobrogas vexassent, memoriam deponere posse? Quod sua victoria tam insolenter gloriarentur quodque tam diu se impune iniurias tulisse admirarentur, eodem pertinere. Consuesse enim deos immortales, quo gravius homines ex commutatione rerum doleant, quos pro scelere eorum ulcisci velint, his secundiores interdum res et diuturniorem impunitatem concedere. Cum ea ita sint, tamen, si obsides ab iis sibi dentur, uti ea quae polliceantur facturos intellegat, et si Haeduis de iniuriis quas ipsis sociisque eorum intulerint, item si Allobrogibus satis faciunt, sese cum iis pacem esse facturum. Divico respondit: ita Helvetios a maioribus suis institutos esse uti obsides accipere, non dare, consuerint; eius rem populum Romanum esse testem. Hoc responso dato discessit.
[15] Postero die castra ex eo loco movent. Idem facit Caesar equitatumque omnem, ad numerum quattuor milium, quem ex omni provincia et Haeduis atque eorum sociis coactum habebat, praemittit, qui videant quas in partes hostes iter faciant. Qui cupidius novissimum agmen insecuti alieno loco cum equitatu Helvetiorum proelium committunt; et pauci de nostris cadunt. Quo proelio sublati Helvetii, quod quingentis equitibus tantam multitudinem equitum propulerant, audacius subsistere non numquam et novissimo agmine proelio nostros lacessere coeperunt. Caesar suos a proelio continebat, ac satis habebat in praesentia hostem rapinis, pabulationibus populationibusque prohibere. Ita dies circiter XV iter fecerunt uti inter novissimum hostium agmen et nostrum primum non amplius quinis aut senis milibus passuum interesset.
[16] Interim cotidie Caesar Haeduos frumentum, quod essent publice polliciti, flagitare. Nam propter frigora
[quod Gallia sub septentrionibus, ut ante dictum est, posita est,] non modo frumenta in agris matura non erant, sed ne pabuli quidem satis magna copia suppetebat; eo autem frumento quod flumine Arari navibus subvexerat propterea uti minus poterat quod iter ab Arari Helvetii averterant, a quibus discedere nolebat. Diem ex die ducere Haedui: conferri, comportari, adesse dicere. Ubi se diutius duci intellexit et diem instare quo die frumentum militibus metiri oporteret, convocatis eorum principibus, quorum magnam copiam in castris habebat, in his Diviciaco et Lisco, qui summo magistratui praeerat, quem vergobretum appellant Haedui, qui creatur annuus et vitae necisque in suos habet potestatem, graviter eos accusat, quod, cum neque emi neque ex agris sumi possit, tam necessario tempore, tam propinquis hostibus ab iis non sublevetur, praesertim cum magna ex parte eorum precibus adductus bellum susceperit; multo etiam gravius quod sit destitutus queritur.
[17] Tum demum Liscus oratione Caesaris adductus quod antea tacuerat proponit: esse non nullos, quorum auctoritas apud plebem plurimum valeat, qui privatim plus possint quam ipsi magistratus. Hos seditiosa atque improba oratione multitudinem deterrere, ne frumentum conferant quod debeant: praestare, si iam principatum Galliae obtinere non possint, Gallorum quam Romanorum imperia perferre, neque dubitare
[debeant] quin, si Helvetios superaverint Romani, una cum reliqua Gallia Haeduis libertatem sint erepturi. Ab isdem nostra consilia quaeque in castris gerantur hostibus enuntiari; hos a se coerceri non posse. Quin etiam, quod necessariam rem coactus Caesari enuntiarit, intellegere sese quanto id cum periculo fecerit, et ob eam causam quam diu potuerit tacuisse.
[18] Caesar hac oratione Lisci Dumnorigem, Diviciaci fratrem, designari sentiebat, sed, quod pluribus praesentibus eas res iactari nolebat, celeriter concilium dimittit, Liscum retinet. Quaerit ex solo ea quae in conventu dixerat. Dicit liberius atque audacius. Eadem secreto ab aliis quaerit; reperit esse vera: ipsum esse Dumnorigem, summa audacia, magna apud plebem propter liberalitatem gratia, cupidum rerum novarum. Complures annos portoria reliquaque omnia Haeduorum vectigalia parvo pretio redempta habere, propterea quod illo licente contra liceri audeat nemo. His rebus et suam rem familiarem auxisse et facultates ad largiendum magnas comparasse; magnum numerum equitatus suo sumptu semper alere et circum se habere, neque solum domi, sed etiam apud finitimas civitates largiter posse, atque huius potentiae causa matrem in Biturigibus homini illic nobilissimo ac potentissimo conlocasse; ipsum ex Helvetiis uxorem habere, sororum ex matre et propinquas suas nuptum in alias civitates conlocasse. Favere et cupere Helvetiis propter eam adfinitatem, odisse etiam suo nomine Caesarem et Romanos, quod eorum adventu potentia eius deminuta et Diviciacus frater in antiquum locum gratiae atque honoris sit restitutus. Si quid accidat Romanis, summam in spem per Helvetios regni obtinendi venire; imperio populi Romani non modo de regno, sed etiam de ea quam habeat gratia desperare. Reperiebat etiam in quaerendo Caesar, quod proelium equestre adversum paucis ante diebus esset factum, initium eius fugae factum a Dumnorige atque eius equitibus (nam equitatui, quem auxilio Caesari Haedui miserant, Dumnorix praeerat): eorum fuga reliquum esse equitatum perterritum.
[19] Quibus rebus cognitis, cum ad has suspiciones certissimae res accederent, quod per fines Sequanorum Helvetios traduxisset, quod obsides inter eos dandos curasset, quod ea omnia non modo iniussu suo et civitatis sed etiam inscientibus ipsis fecisset, quod a magistratu Haeduorum accusaretur, satis esse causae arbitrabatur quare in eum aut ipse animadverteret aut civitatem animadvertere iuberet. His omnibus rebus unum repugnabat, quod Diviciaci fratris summum in populum Romanum studium, summum in se voluntatem, egregiam fidem, iustitiam, temperantiam cognoverat; nam ne eius supplicio Diviciaci animum offenderet verebatur. Itaque prius quam quicquam conaretur, Diviciacum ad se vocari iubet et, cotidianis interpretibus remotis, per C. Valerium Troucillum, principem Galliae provinciae, familiarem suum, cui summam omnium rerum fidem habebat, cum eo conloquitur; simul commonefacit quae ipso praesente in concilio
[Gallorum] de Dumnorige sint dicta, et ostendit quae separatim quisque de eo apud se dixerit. Petit atque hortatur ut sine eius offensione animi vel ipse de eo causa cognita statuat vel civitatem statuere iubeat.
[20] Diviciacus multis cum lacrimis Caesarem complexus obsecrare coepit ne quid gravius in fratrem statueret: scire se illa esse vera, nec quemquam ex eo plus quam se doloris capere, propterea quod, cum ipse gratia plurimum domi atque in reliqua Gallia, ille minimum propter adulescentiam posset, per se crevisset; quibus opibus ac nervis non solum ad minuendam gratiam, sed paene ad perniciem suam uteretur. Sese tamen et amore fraterno et existimatione vulgi commoveri. Quod si quid ei a Caesare gravius accidisset, cum ipse eum locum amicitiae apud eum teneret, neminem existimaturum non sua voluntate factum; qua ex re futurum uti totius Galliae animi a se averterentur. Haec cum pluribus verbis flens a Caesare peteret, Caesar eius dextram prendit; consolatus rogat finem orandi faciat; tanti eius apud se gratiam esse ostendit uti et rei publicae iniuriam et suum dolorem eius voluntati ac precibus condonet. Dumnorigem ad se vocat, fratrem adhibet; quae in eo reprehendat ostendit; quae ipse intellegat, quae civitas queratur proponit; monet ut in reliquum tempus omnes suspiciones vitet; praeterita se Diviciaco fratri condonare dicit. Dumnorigi custodes ponit, ut quae agat, quibuscum loquatur scire possit.
[21] Eodem die ab exploratoribus certior factus hostes sub monte consedisse milia passuum ab ipsius castris octo, qualis esset natura montis et qualis in circuitu ascensus qui cognoscerent misit. Renuntiatum est facilem esse. De tertia vigilia T. Labienum, legatum pro praetore, cum duabus legionibus et iis ducibus qui iter cognoverant summum iugum montis ascendere iubet; quid sui consilii sit ostendit. Ipse de quarta vigilia eodem itinere quo hostes ierant ad eos contendit equitatumque omnem ante se mittit. P. Considius, qui rei militaris peritissimus habebatur et in exercitu L. Sullae et postea in M. Crassi fuerat, cum exploratoribus praemittitur.
[22] Prima luce, cum summus mons a
[Lucio] Labieno teneretur, ipse ab hostium castris non longius mille et quingentis passibus abesset neque, ut postea ex captivis comperit, aut ipsius adventus aut Labieni cognitus esset, Considius equo admisso ad eum accurrit, dicit montem, quem a Labieno occupari voluerit, ab hostibus teneri: id se a Gallicis armis atque insignibus cognovisse. Caesar suas copias in proximum collem subducit, aciem instruit. Labienus, ut erat ei praeceptum a Caesare ne proelium committeret, nisi ipsius copiae prope hostium castra visae essent, ut undique uno tempore in hostes impetus fieret, monte occupato nostros expectabat proelioque abstinebat. Multo denique die per exploratores Caesar cognovit et montem a suis teneri et Helvetios castra, movisse et Considium timore perterritum quod non vidisset pro viso sibi renuntiavisse. Eo die quo consuerat intervallo hostes sequitur et milia passuum tria ab eorum castris castra ponit.
[23] Postridie eius diei, quod omnino biduum supererat, cum exercitui frumentum metiri oporteret, et quod a Bibracte, oppido Haeduorum longe maximo et copiosissimo, non amplius milibus passuum XVIII aberat, rei frumentariae prospiciendum existimavit; itaque iter ab Helvetiis avertit ac Bibracte ire contendit. Ea res per fugitivos L. Aemilii, decurionis equitum Gallorum, hostibus nuntiatur. Helvetii, seu quod timore perterritos Romanos discedere a se existimarent, eo magis quod pridie superioribus locis occupatis proelium non commisissent, sive eo quod re frumentaria intercludi posse confiderent, commutato consilio atque itinere converso nostros a novissimo agmine insequi ac lacessere coeperunt.
[24] Postquam id animum advertit, copias suas Caesar in proximum collem subduxit equitatumque, qui sustineret hostium petum, misit. Ipse interim in colle medio triplicem aciem instruxit legionum quattuor veteranarum; in summo iugo duas legiones quas in Gallia citeriore proxime conscripserat et omnia auxilia conlocavit, ita ut supra se totum montem hominibus compleret; impedimenta sarcinasque in unum locum conferri et eum ab iis qui in superiore acie constiterant muniri iussit. Helvetii cum omnibus suis carris secuti impedimenta in unum locum contulerunt; ipsi confertissima acie, reiecto nostro equitatu, phalange facta sub primam nostram aciem successerunt.
[25] Caesar primum suo, deinde omnium ex conspectu remotis equis, ut aequato omnium periculo spem fugae tolleret, cohortatus suos proelium commisit. Milites loco superiore pilis missis facile hostium phalangem perfregerunt. Ea disiecta gladiis destrictis in eos impetum fecerunt. Gallis magno ad pugnam erat impedimento quod pluribus eorum scutis uno ictu pilorum transfixis et conligatis, cum ferrum se inflexisset, neque evellere neque sinistra impedita satis commode pugnare poterant, multi ut diu iactato bracchio praeoptarent scutum manu emittere et nudo corpore pugnare. Tandem vulneribus defessi et pedem referre et, quod mons suberit circiter mille passuum spatio, eo se recipere coeperunt. Capto monte et succedentibus nostris, Boi et Tulingi, qui hominum milibus circiter XV agmen hostium claudebant et novissimis praesidio erant, ex itinere nostros ab latere aperto adgressi circumvenire, et id conspicati Helvetii, qui in montem sese receperant, rursus instare et proelium redintegrare coeperunt. Romani conversa signa bipertito intulerunt: prima et secunda acies, ut victis ac submotis resisteret, tertia, ut venientes sustineret.
[26] Ita ancipiti proelio diu atque acriter pugnatum est. Diutius cum sustinere nostrorum impetus non possent, alteri se, ut coeperant, in montem receperunt, alteri ad impedimenta et carros suos se contulerunt. Nam hoc toto proelio, cum ab hora septima ad vesperum pugnatum sit, aversum hostem videre nemo potuit. Ad multam noctem etiam ad impedimenta pugnatum est, propterea quod pro vallo carros obiecerunt et e loco superiore in nostros venientes tela coiciebant et non nulli inter carros rotasque mataras ac tragulas subiciebant nostrosque vulnerabant. Diu cum esset pugnatum, impedimentis castrisque nostri potiti sunt. Ibi Orgetorigis filia atque unus e filiis captus est. Ex eo proelio circiter hominum milia CXXX superfuerunt eaque tota nocte continenter ierunt
[nullam partem noctis itinere intermisso]; in fines Lingonum die quarto pervenerunt, cum et propter vulnera militum et propter sepulturam occisorum nostri
[triduum morati] eos sequi non potuissent. Caesar ad Lingonas litteras nuntiosque misit, ne eos frumento neve alia re iuvarent: qui si iuvissent, se eodem loco quo Helvetios habiturum. Ipse triduo intermisso cum omnibus copiis eos sequi coepit.
[27] Helvetii omnium rerum inopia adducti legatos de deditione ad eum miserunt. Qui cum eum in itinere convenissent seque ad pedes proiecissent suppliciterque locuti flentes pacem petissent, atque eos in eo loco quo tum essent suum adventum expectare iussisset, paruerunt. Eo postquam Caesar pervenit, obsides, arma, servos qui ad eos perfugissent, poposcit. Dum ea conquiruntur et conferuntur,
[nocte intermissa] circiter hominum milia VI eius pagi qui Verbigenus appellatur, sive timore perterriti, ne armis traditis supplicio adficerentur, sive spe salutis inducti, quod in tanta multitudine dediticiorum suam fugam aut occultari aut omnino ignorari posse existimarent, prima nocte e castris Helvetiorum egressi ad Rhenum finesque Germanorum contenderunt.
[28] Quod ubi Caesar resciit, quorum per fines ierant his uti conquirerent et reducerent, si sibi purgati esse vellent, imperavit; reductos in hostium numero habuit; reliquos omnes obsidibus, armis, perfugis traditis in deditionem accepit. Helvetios, Tulingos, Latobrigos in fines suos, unde erant profecti, reverti iussit, et, quod omnibus frugibus amissis domi nihil erat quo famem tolerarent, Allobrogibus imperavit ut iis frumenti copiam facerent; ipsos oppida vicosque, quos incenderant, restituere iussit. Id ea maxime ratione fecit, quod noluit eum locum unde Helvetii discesserant vacare, ne propter bonitatem agrorum Germani, qui trans Rhenum incolunt, ex suis finibus in Helvetiorum fines transirent et finitimi Galliae provinciae Allobrogibusque essent. Boios petentibus Haeduis, quod egregia virtute erant cogniti, ut in finibus suis conlocarent, concessit; quibus illi agros dederunt quosque postea in parem iuris libertatisque condicionem atque ipsi erant receperunt.
[29] In castris Helvetiorum tabulae repertae sunt litteris Graecis confectae et ad Caesarem relatae, quibus in tabulis nominatim ratio confecta erat, qui numerus domo exisset eorum qui arma ferre possent, et item separatim, quot pueri, senes mulieresque.
[Quarum omnium rerum] summa erat capitum Helvetiorum milium CCLXIII, Tulingorum milium XXXVI, Latobrigorum XIIII, Rauracorum XXIII, Boiorum XXXII; ex his qui arma ferre possent ad milia nonaginta duo. Summa omnium fuerunt ad milia CCCLXVIII. Eorum qui domum redierunt censu habito, ut Caesar imperaverat, repertus est numerus milium C et X.
[30] Bello Helvetiorum confecto totius fere Galliae legati, principes civitatum, ad Caesarem gratulatum convenerunt: intellegere sese, tametsi pro veteribus Helvetiorum iniuriis populi Romani ab his poenas bello repetisset, tamen eam rem non minus ex usu
[terrae] Galliae quam populi Romani accidisse, propterea quod eo consilio florentissimis rebus domos suas Helvetii reliquissent uti toti Galliae bellum inferrent imperioque potirentur, locumque domicilio ex magna copia deligerent quem ex omni Gallia oportunissimum ac fructuosissimum iudicassent, reliquasque civitates stipendiarias haberent. Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere idque Caesaris facere voluntate liceret: sese habere quasdam res quas ex communi consensu ab eo petere vellent. Ea re permissa diem concilio constituerunt et iure iurando ne quis enuntiaret, nisi quibus communi consilio mandatum esset, inter se sanxerunt.
[31] Eo concilio dimisso, idem princeps civitatum qui ante fuerant ad Caesarem reverterunt petieruntque uti sibi secreto in occulto de sua omniumque salute cum eo agere liceret. Ea re impetrata sese omnes flentes Caesari ad pedes proiecerunt: non minus se id contendere et laborare ne ea quae dixissent enuntiarentur quam uti ea quae vellent impetrarent, propterea quod, si enuntiatum esset, summum in cruciatum se venturos viderent. Locutus est pro his Diviciacus Haeduus: Galliae totius factiones esse duas; harum alterius principatum tenere Haeduos, alterius Arvernos. Hi cum tantopere de potentatu inter se multos annos contenderent, factum esse uti ab Arvernis Sequanisque Germani mercede arcesserentur. Horum primo circiter milia XV Rhenum transisse; postea quam agros et cultum et copias Gallorum homines feri ac barbari adamassent, traductos plures; nunc esse in Gallia ad C et XX milium numerum. Cum his Haeduos eorumque clientes semel atque iterum armis contendisse; magnam calamitatem pulsos accepisse, omnem nobilitatem, omnem senatum, omnem equitatum amisisse. Quibus proeliis calamitatibusque fractos, qui et sua virtute et populi Romani hospitio atque amicitia plurimum ante in Gallia potuissent, coactos esse Sequanis obsides dare nobilissimos civitatis et iure iurando civitatem obstringere sese neque obsides repetituros neque auxilium a populo Romano imploraturos neque recusaturos quo minus perpetuo sub illorum dicione atque imperio essent. Unum se esse ex omni civitate Haeduorum qui adduci non potuerit ut iuraret aut liberos suos obsides daret. Ob eam rem se ex civitate profugisse et Romam ad senatum venisse auxilium postulatum, quod solus neque iure iurando neque obsidibus teneretur. Sed peius victoribus Sequanis quam Haeduis victis accidisse, propterea quod Ariovistus, rex Germanorum, in eorum finibus consedisset tertiamque partem agri Sequani, qui esset optimus totius Galliae, occupavisset et nunc de altera parte tertia Sequanos decedere iuberet, propterea quod paucis mensibus ante Harudum milia hominum XXIIII ad eum venissent, quibus locus ac sedes pararentur. Futurum esse paucis annis uti omnes ex Galliae finibus pellerentur atque omnes Germani Rhenum transirent; neque enim conferendum esse Gallicum cum Germanorum agro neque hanc consuetudinem victus cum illa comparandam. Ariovistum autem, ut semel Gallorum copias proelio vicerit, quod proelium factum sit ad Magetobrigam, superbe et crudeliter imperare, obsides nobilissimi cuiusque liberos poscere et in eos omnia exempla cruciatusque edere, si qua res non ad nutum aut ad voluntatem eius facta sit. Hominem esse barbarum, iracundum, temerarium: non posse eius imperia, diutius sustineri. Nisi quid in Caesare populoque Romano sit auxilii, omnibus Gallis idem esse faciendum quod Helvetii fecerint, ut domo emigrent, aliud domicilium, alias sedes, remotas a Germanis, petant fortunamque, quaecumque accidat, experiantur. Haec si enuntiata Ariovisto sint, non dubitare quin de omnibus obsidibus qui apud eum sint gravissimum supplicium sumat. Caesarem vel auctoritate sua atque exercitus vel recenti victoria vel nomine populi Romani deterrere posse ne maior multitudo Germanorum Rhenum traducatur, Galliamque omnem ab Ariovisti iniuria posse defendere.
[32] Hac oratione ab Diviciaco habita omnes qui aderant magno fletu auxilium a Caesare petere coeperunt. Animadvertit Caesar unos ex omnibus Sequanos nihil earum rerum facere quas ceteri facerent sed tristes capite demisso terram intueri. Eius rei quae causa esset miratus ex ipsis quaesiit. Nihil Sequani respondere, sed in eadem tristitia taciti permanere. Cum ab his saepius quaereret neque ullam omnino vocem exprimere posset, idem Diviacus Haeduus respondit: hoc esse miseriorem et graviorem fortunam Sequanorum quam reliquorum, quod soli ne in occulto quidem queri neque auxilium implorare auderent absentisque Ariovisti crudelitatem, velut si cora adesset, horrerent, propterea quod reliquis tamen fugae facultas daretur, Sequanis vero, qui intra fines suos Ariovistum recepissent, quorum oppida omnia in potestate eius essent, omnes cruciatus essent perferendi.
[33] His rebus cognitis Caesar Gallorum animos verbis confirmavit pollicitusque est sibi eam rem curae futuram; magnam se habere spem et beneficio suo et auctoritate adductum Ariovistum finem iniuriis facturum. Hac oratione habita, concilium dimisit. Et secundum ea multae res eum hortabantur quare sibi eam rem cogitandam et suscipiendam putaret, in primis quod Haeduos, fratres consanguineosque saepe numero a senatu appellatos, in servitute atque
[in] dicione videbat Germanorum teneri eorumque obsides esse apud Ariovistum ac Sequanos intellegebat; quod in tanto imperio populi Romani turpissimum sibi et rei publicae esse arbitrabatur. Paulatim autem Germanos consuescere Rhenum transire et in Galliam magnam eorum multitudinem venire populo Romano periculosum videbat, neque sibi homines feros ac barbaros temperaturos existimabat quin, cum omnem Galliam occupavissent, ut ante Cimbri Teutonique fecissent, in provinciam exirent atque inde in Italiam contenderent
[, praesertim cum Sequanos a provincia nostra Rhodanus divideret]; quibus rebus quam maturrime occurrendum putabat. Ipse autem Ariovistus tantos sibi spiritus, tantam arrogantiam sumpserat, ut ferendus non videretur.
[34] Quam ob rem placuit ei ut ad Ariovistum legatos mitteret, qui ab eo postularent uti aliquem locum medium utrisque conloquio deligeret: velle sese de re publica et summis utriusque rebus cum eo agere. Ei legationi Ariovistus respondit: si quid ipsi a Caesare opus esset, sese ad eum venturum fuisse; si quid ille se velit, illum ad se venire oportere. Praeterea se neque sine exercitu in eas partes Galliae venire audere quas Caesar possideret, neque exercitum sine magno commeatu atque molimento in unum locum contrahere posse. Sibi autem mirum videri quid in sua Gallia, quam bello vicisset, aut Caesari aut omnino populo Romano negotii esset.
[35] His responsis ad Caesarem relatis, iterum ad eum Caesar legatos cum his mandatis mittit: quoniam tanto suo populique Romani beneficio adtectus, cum in consulatu suo rex atque amicus a senatu appellatus esset, hanc sibi populoque Romano gratiam referret ut in conloquium venire invitatus gravaretur neque de communi re dicendum sibi et cognoscendum putaret, haec esse quae ab eo postularet: primum ne quam multitudinem hominum amplius trans Rhenum in Galliam traduceret; deinde obsides quos haberet ab Haeduis redderet Sequanisque permitteret ut quos illi haberent voluntate eius reddere illis liceret; neve Haeduos iniuria lacesseret neve his sociisque eorum bellum inferret. Si
[id] ita fecisset, sibi populoque Romano perpetuam gratiam atque amicitiam cum eo futuram; si non impetraret, sese, quoniam M. Messala, M. Pisone consulibus senatus censuisset uti quicumque Galliam provinciam obtineret, quod commodo rei publicae lacere posset, Haeduos ceterosque amicos populi Romani defenderet, se Haeduorum iniurias non neglecturum.
[36] Ad haec Ariovistus respondit: ius esse belli ut qui vicissent iis quos vicissent quem ad modum vellent imperarent. Item populum Romanum victis non ad alterius praescriptum, sed ad suum arbitrium imperare consuesse. Si ipse populo Romano non praescriberet quem ad modum suo iure uteretur, non oportere se a populo Romano in suo iure impediri. Haeduos sibi, quoniam belli fortunam temptassent et armis congressi ac superati essent, stipendiarios esse factos. Magnam Caesarem iniuriam facere, qui suo adventu vectigalia sibi deteriora faceret. Haeduis se obsides redditurum non esse neque his neque eorum sociis iniuria bellum inlaturum, si in eo manerent quod convenisset stipendiumque quotannis penderent; si id non fecissent, longe iis fraternum nomen populi Romani afuturum. Quod sibi Caesar denuntiaret se Haeduorum iniurias non neglecturum, neminem secum sine sua pernicie contendisse. Cum vellet, congrederetur: intellecturum quid invicti Germani, exercitatissimi in armis, qui inter annos XIIII tectum non subissent, virtute possent.
[37] Haec eodem tempore Caesari mandata referebantur et legati ab Haeduis et a Treveris veniebant: Haedui questum quod Harudes, qui nuper in Galliam transportati essent, fines eorum popularentur: sese ne obsidibus quidem datis pacem Ariovisti redimere potuisse; Treveri autem, pagos centum Sueborum ad ripas Rheni consedisse, qui Rhemum transire conarentur; his praeesse Nasuam et Cimberium fratres. Quibus rebus Caesar vehementer commotus maturandum sibi existimavit, ne, si nova manus Sueborum cum veteribus copiis Ariovisti sese coniunxisset, minus facile resisti posset. Itaque re frumentaria quam celerrime potuit comparata magnis itineribus ad Ariovistum contendit.
[38] Cum tridui viam processisset, nuntiatum est ei Ariovistum cum suis omnibus copiis ad occupandum Vesontionem, quod est oppidum maximum Sequanorum, contendere
[triduique viam a suis finibus processisse]. Id ne accideret, magnopere sibi praecavendum Caesar existimabat. Namque omnium rerum quae ad bellum usui erant summa erat in eo oppido facultas, idque natura loci sic muniebatur ut magnam ad ducendum bellum daret facultatem, propterea quod flumen
[alduas] Dubis ut circino circumductum paene totum oppidum cingit, reliquum spatium, quod est non amplius pedum MDC, qua flumen intermittit, mons continet magna altitudine, ita ut radices eius montis ex utraque parte ripae fluminis contingant, hunc murus circumdatus arcem efficit et cum oppido coniungit. Huc Caesar magnis nocturnis diurnisque itineribus contendit occupatoque oppido ibi praesidium conlocat.
[39] Dum paucos dies ad Vesontionem rei frumentariae commeatusque causa moratur, ex percontatione nostrorum vocibusque Gallorum ac mercatorum, qui ingenti magnitudine corporum Germanos, incredibili virtute atque exercitatione in armis esse praedicabant (saepe numero sese cum his congressos ne vultum quidem atque aciem oculorum dicebant ferre potuisse), tantus subito timor omnem exercitum occupavit ut non mediocriter omnium mentes animosque perturbaret. Hic primum ortus est a tribunis militum, praefectis, reliquisque qui ex urbe amicitiae causa Caesarem secuti non magnum in re militari usum habebant: quorum alius alia causa inlata, quam sibi ad proficiscendum necessariam esse diceret, petebat ut eius voluntate discedere liceret; non nulli pudore adducti, ut timoris suspicionem vitarent, remanebant. Hi neque vultum fingere neque interdum lacrimas tenere poterant: abditi in tabernaculis aut suum fatum querebantur aut cum familiaribus suis commune periculum miserabantur. Vulgo totis castris testamenta obsignabantur. Horum vocibus ac timore paulatim etiam ii qui magnum in castris usum habebant, milites centurionesque quique equitatui praeerant, perturbabantur. Qui se ex his minus timidos existimari volebant, non se hostem vereri, sed angustias itineris et magnitudinem silvarum quae intercederent inter ipsos atque Ariovistum, aut rem frumentariam, ut satis commode supportari posset, timere dicebant. Non nulli etiam Caesari nuntiabant, cum castra moveri ac signa ferri iussisset, non fore dicto audientes milites neque propter timorem signa laturos.
[40] Haec cum animadvertisset, convocato consilio omniumque ordinum ad id consilium adhibitis centurionibus, vehementer eos incusavit: primum, quod aut quam in partem aut quo consilio ducerentur sibi quaerendum aut cogitandum putarent. Ariovistum se consule cupidissime populi Romani amicitiam adpetisse; cur hunc tam temere quisquam ab officio discessurum iudicaret? Sibi quidem persuaderi cognitis suis poslulatis atque aequitate condicionum perspecta eum neque suam neque populi Romani gratiam repudiaturum. Quod si furore atque amentia impulsum bellum intulisset, quid tandem vererentur? Aut cur de sua virtute aut de ipsius diligentia desperarent? Factum eius hostis periculum patrum nostrorum memoria Cimbris et Teutonis a C. Mario pulsis
[cum non minorem laudem exercitus quam ipse imperator meritus videbatur]; factum etiam nuper in Italia servili tumultu, quos tamen aliquid usus ac disciplina, quam a nobis accepissent, sublevarint. Ex quo iudicari posse quantum haberet in se boni constantia, propterea quod quos aliquam diu inermes sine causa timuissent hos postea armatos ac victores superassent. Denique hos esse eosdem Germanos quibuscum saepe numero Helvetii congressi non solum in suis sed etiam in illorum finibus plerumque superarint, qui tamen pares esse nostro exercitui non potuerint. Si quos adversum proelium et fuga Gallorum commoveret, hos, si quaererent, reperire posse diuturnitate belli defatigatis Gallis Ariovistum, cum multos menses castris se ac paludibus tenuisset neque sui potestatem fecisset, desperantes iam de pugna et dispersos subito adortum magis ratione et consilio quam virtute vicisse. Cui rationi contra homines barbaros atque imperitos locus fuisset, hac ne ipsum quidem sperare nostros exercitus capi posse. Qui suum timorem in rei frumentariae simulationem angustiasque itineris conferrent, facere arroganter, cum aut de officio imperatoris desperare aut praescribere viderentur. Haec sibi esse curae; frumentum Sequanos, Leucos, Lingones subministrare, iamque esse in agris frumenta matura; de itinere ipsos brevi tempore iudicaturos. Quod non fore dicto audientes neque signa laturi dicantur, nihil se ea re commoveri: scire enim, quibuscumque exercitus dicto audiens non fuerit, aut male re gesta fortunam defuisse aut aliquo facinore comperto avaritiam esse convictam. Suam innocentiam perpetua vita, felicitatem Helvetiorum bello esse perspectam. Itaque se quod in longiorem diem conlaturus fuisset repraesentaturum et proxima nocte de quarta, vigilia castra moturum, ut quam primum intellegere posset utrum apud eos pudor atque officium an timor plus valeret. Quod si praeterea nemo sequatur, tamen se cum sola decima legione iturum, de qua non dubitet, sibique eam praetoriam cohortem futuram. Huic legioni Caesar et indulserat praecipue et propter virtutem confidebat maxime.
[41] Hac oratione habita mirum in modum conversae sunt omnium mentes summaque alacritas et cupiditas belli gerendi innata est, princepsque X. legio per tribunos militum ei gratias egit quod de se optimum iudicium fecisset, seque esse ad bellum gerendum paratissimam confirmavit. Deinde reliquae legiones cum tribunis militum et primorum ordinum centurionibus egerunt uti Caesari satis facerent: se neque umquam dubitasse neque timuisse neque de summa belli suum iudicium sed imperatoris esse existimavisse. Eorum satisfactione accepta et itinere exquisito per Diviciacum, quod ex Gallis ei maximam fidem habebat, ut milium amplius quinquaginta circuitu locis apertis exercitum duceret, de quarta vigilia, ut dixerat, profectus est. Septimo die, cum iter non intermitteret, ab exploratoribus certior factus est Ariovisti copias a nostris milia passuum IIII et XX abesse.
[42] Cognito Caesaris adventu Ariovistus legatos ad eum mittit: quod antea de conloquio postulasset, id per se fieri licere, quoniam propius accessisset seque id sine periculo facere posse existimaret. Non respuit condicionem Caesar iamque eum ad sanitatem reverti arbitrabatur, cum id quod antea petenti denegasset ultro polliceretur, magnamque in spem veniebat pro suis tantis populique Romani in eum beneficiis cognitis suis postulatis fore uti pertinacia desisteret. Dies conloquio dictus est ex eo die quintus. Interim saepe cum legati ultro citroque inter eos mitterentur, Ariovistus postulavit ne quem peditem ad conloquium Caesar adduceret: vereri se ne per insidias ab eo circumveniretur; uterque cum equitatu veniret: alia ratione sese non esse venturum. Caesar, quod neque conloquium interposita causa tolli volebat neque salutem suam Gallorum equitatui committere audebat, commodissimum esse statuit omnibus equis Gallis equitibus detractis eo legionarios milites legionis X., cui quam maxime confidebat, imponere, ut praesidium quam amicissimum, si quid opus facto esset, haberet. Quod cum fieret, non inridicule quidam ex militibus X. legionis dixit: plus quam pollicitus esset Caesarem facere; pollicitum se in cohortis praetoriae loco X. legionem habiturum ad equum rescribere.
[43] Planities erat magna et in ea tumulus terrenus satis grandis. Hic locus aequum fere spatium a castris Ariovisti et Caesaris aberat. Eo, ut erat dictum, ad conloquium venerunt. Legionem Caesar, quam equis devexerat, passibus CC ab eo tumulo constituit. Item equites Ariovisti pari intervallo constiterunt. Ariovistus ex equis ut conloquerentur et praeter se denos ad conloquium adducerent postulavit. Ubi eo ventum est, Caesar initio orationis sua senatusque in eum beneficia commemoravit, quod rex appellatus esset a senatu, quod amicus, quod munera amplissime missa; quam rem et paucis contigisse et pro magnis hominum officiis consuesse tribui docebat; illum, cum neque aditum neque causam postulandi iustam haberet, beneficio ac liberalitate sua ac senatus ea praemia consecutum. Docebat etiam quam veteres quamque iustae causae necessitudinis ipsis cum Haeduis intercederent, quae senatus consulta quotiens quamque honorifica in eos facta essent, ut omni tempore totius Galliae principatum Haedui tenuissent, prius etiam quam nostram amicitiam adpetissent. Populi Romani hanc esse consuetudinem, ut socios atque amicos non modo sui nihil deperdere, sed gratia, dignitate, honore auctiores velit esse; quod vero ad amicitiam populi Romani attulissent, id iis eripi quis pati posset? Postulavit deinde eadem quae legatis in mandatis dederat: ne aut Haeduis aut eorum sociis bellum inferret, obsides redderet, si nullam partem Germanorum domum remittere posset, at ne quos amplius Rhenum transire pateretur.
[44] Ariovistus ad postulata Caesaris pauca respondit, de suis virtutibus multa praedicavit: transisse Rhenum sese non sua sponte, sed rogatum et arcessitum a Gallis; non sine magna spe magnisque praemiis domum propinquosque reliquisse; sedes habere in Gallia ab ipsis concessas, obsides ipsorum voluntate datos; stipendium capere iure belli, quod victores victis imponere consuerint. Non sese Gallis sed Gallos sibi bellum intulisse: omnes Galliae civitates ad se oppugnandum venisse ac contra se castra habuisse; eas omnes copias a se uno proelio pulsas ac superatas esse. Si iterum experiri velint, se iterum paratum esse decertare; si pace uti velint, iniquum esse de stipendio recusare, quod sua voluntate ad id tempus pependerint. Amicitiam populi Romani sibi ornamento et praesidio, non detrimento esse oportere, atque se hac spe petisse. Si per populum Romanum stipendium remittatur et dediticii subtrahantur, non minus libenter sese recusaturum populi Romani amicitiam quam adpetierit. Quod multitudinem Germanorum in Galliam traducat, id se sui muniendi, non Galliae oppugnandae causa facere; eius rei testimonium esse quod nisi rogatus non venerit et quod bellum non intulerit sed defenderit. Se prius in Galliam venisse quam populum Romanum. Numquam ante hoc tempus exercitum populi Romani Galliae provinciae finibus egressum. Quid sibi vellet? Cur in suas possessiones veniret? Provinciam suam hanc esse Galliam, sicut illam nostram. Ut ipsi concedi non oporteret, si in nostros fines impetum faceret, sic item nos esse iniquos, quod in suo iure se interpellaremus. Quod fratres a senatu Haeduos appellatos diceret, non se tam barbarum neque tam imperitum esse rerum ut non sciret neque bello Allobrogum proximo Haeduos Romanis auxilium tulisse neque ipsos in iis contentionibus quas Haedui secum et cum Sequanis habuissent auxilio populi Romani usos esse. Debere se suspicari simulata Caesarem amicitia, quod exercitum in Gallia habeat, sui opprimendi causa habere. Qui nisi decedat atque exercitum deducat ex his regionibus, sese illum non pro amico sed pro hoste habiturum. Quod si eum interfecerit, multis sese nobilibus principibusque populi Romani gratum esse facturum (id se ab ipsis per eorum nuntios compertum habere), quorum omnium gratiam atque amicitiam eius morte redimere posset. Quod si decessisset et liberam possessionem Galliae sibi tradidisset, magno se illum praemio remuneraturum et quaecumque bella geri vellet sine ullo eius labore et periculo confecturum.
[45] Multa a Caesare in eam sententiam dicta sunt quare negotio desistere non posset: neque suam neque populi Romani consuetudinem pati ut optime meritos socios desereret, neque se iudicare Galliam potius esse Ariovisti quam populi Romani. Bello superatos esse Arvernos et Rutenos a Q. Fabio Maximo, quibus populus Romanus ignovisset neque in provinciam redegisset neque stipendium posuisset. Quod si antiquissimum quodque tempus spectari oporteret, populi Romani iustissimum esse in Gallia imperium; si iudicium senatus observari oporteret, liberam debere esse Galliam, quam bello victam suis legibus uti voluisset.
[46] Dum haec in conloquio geruntur, Caesari nuntiatum est equites Ariovisti propius tumulum accedere et ad nostros adequitare, lapides telaque in nostros coicere. Caesar loquendi finem fecit seque ad suos recepit suisque imperavit ne quod omnino telum in hostes reicerent. Nam etsi sine ullo periculo legionis delectae cum equitatu proelium fore videbat, tamen committendum non putabat ut, pulsis hostibus, dici posset eos ab se per fidem in conloquio circumventos. Postea quam in vulgus militum elatum est qua arrogantia in conloquio Ariovistus usus omni Gallia Romanis interdixisset, impetumque in nostros eius equites fecissent, eaque res conloquium ut diremisset, multo maior alacritas studiumque pugnandi maius exercitui iniectum est.
[47] Biduo post Ariovistus ad Caesarem legatos misit: velle se de iis rebus quae inter eos egi coeptae neque perfectae essent agere cum eo: uti aut iterum conloquio diem constitueret aut, si id minus vellet, ex suis legatis aliquem ad se mitteret. Conloquendi Caesari causa visa non est, et eo magis quod pridie eius diei Germani retineri non potuerant quin tela in nostros coicerent. Legatum ex suis sese magno cum periculo ad eum missurum et hominibus feris obiecturum existimabat. Commodissimum visum est C. Valerium Procillum, C. Valerii Caburi filium, summa virtute et humanitate adulescentem, cuius pater a C. Valerio Flacco civitate donatus erat, et propter fidem et propter linguae Gallicae scientiam, qua multa iam Ariovistus longinqua consuetudine utebatur, et quod in eo peccandi Germanis causa non esset, ad eum mittere, et una M. Metium, qui hospitio Ariovisti utebatur. His mandavit quae diceret Ariovistus cognoscerent et ad se referrent. Quos cum apud se in castris Ariovistus conspexisset, exercitu suo praesente conclamavit: quid ad se venirent? an speculandi causa? Conantes dicere prohibuit et in catenas coniecit.
[48] Eodem die castra promovit et milibus passuum VI a Caesaris castris sub monte consedit. Postridie eius diei praeter castra Caesaris suas copias traduxit et milibus passuum duobus ultra eum castra fecit eo consilio uti frumento commeatuque qui ex Sequanis et Haeduis supportaretur Caesarem intercluderet. Ex eo die dies continuos V Caesar pro castris suas copias produxit et aciem instructam habuit, ut, si vellet Ariovistus proelio contendere, ei potestas non deesset. Ariovistus his omnibus diebus exercitum castris continuit, equestri proelio cotidie contendit. Genus hoc erat pugnae, quo se Germani exercuerant: equitum milia erant VI, totidem numero pedites velocissimi ac fortissimi, quos ex omni copia singuli singulos suae salutis causa delegerant: cum his in proeliis versabantur, ad eos se equites recipiebant; hi, si quid erat durius, concurrebant, si qui graviore vulnere accepto equo deciderat, circumsistebant; si quo erat longius prodeundum aut celerius recipiendum, tanta erat horum exercitatione celeritas ut iubis sublevati equorum cursum adaequarent.
[49] Ubi eum castris se tenere Caesar intellexit, ne diutius commeatu prohiberetur, ultra eum locum, quo in loco Germani consederant, circiter passus DC ab his, castris idoneum locum delegit acieque triplici instructa ad eum locum venit. Primam et secundam aciem in armis esse, tertiam castra munire iussit.
[Hic locus ab hoste circiter passus DC, uti dictum est, aberat.] Eo circiter hominum XVI milia expedita cum omni equitatu Ariovistus misit, quae copiae nostros terrerent et munitione prohiberent. Nihilo setius Caesar, ut ante constituerat, duas acies hostem propulsare, tertiam opus perficere iussit. Munitis castris duas ibi legiones reliquit et partem auxiliorum, quattuor reliquas legiones in castra maiora reduxit.
[50] Proximo die instituto suo Caesar ex castris utrisque copias suas eduxit paulumque a maioribus castris progressus aciem instruxit hostibusque pugnandi potestatem fecit. Ubi ne tum quidem eos prodire intellexit, circiter meridiem exercitum in castra reduxit. Tum demum Ariovistus partem suarum copiarum, quae castra minora oppugnaret, misit. Acriter utrimque usque ad vesperum pugnatum est. Solis occasu suas copias Ariovistus multis et inlatis et acceptis vulneribus in castra reduxit. Cum ex captivis quaereret Caesar quam ob rem Ariovistus proelio non decertaret, hanc reperiebat causam, quod apud Germanos ea consuetudo esset ut matres familiae eorum sortibus et vaticinationibus declararent utrum proelium committi ex usu esset necne; eas ita dicere: non esse fas Germanos superare, si ante novam lunam proelio contendissent.
[51] Postridie eius diei Caesar praesidio utrisque castris quod satis esse visum est reliquit, alarios omnes in conspectu hostium pro castris minoribus constituit, quod minus multitudine militum legionariorum pro hostium numero valebat, ut ad speciem alariis uteretur; ipse triplici instructa acie usque ad castra hostium accessit. Tum demum necessario Germani suas copias castris eduxerunt generatimque constituerunt paribus intervallis, Harudes, Marcomanos, Tribocos, Vangiones, Nemetes, Sedusios, Suebos, omnemque aciem suam raedis et carris circumdederunt, ne qua spes in fuga relinqueretur. Eo mulieres imposuerunt, quae ad proelium proficiscentes milites passis manibus flentes implorabant ne se in servitutem Romanis traderent.
[52] Caesar singulis legionibus singulos legatos et quaestorem praefecit, uti eos testes suae quisque virtutis haberet; ipse a dextro cornu, quod eam partem minime firmam hostium esse animadverterat, proelium commisit. Ita nostri acriter in hostes signo dato impetum fecerunt itaque hostes repente celeriterque procurrerunt, ut spatium pila in hostes coiciendi non daretur. Relictis pilis comminus gladiis pugnatum est. At Germani celeriter ex consuetudine sua phalange facta impetus gladiorum exceperunt. Reperti sunt complures nostri qui in phalanga insilirent et scuta manibus revellerent et desuper vulnerarent. Cum hostium acies a sinistro cornu pulsa atque in fugam coniecta esset, a dextro cornu vehementer multitudine suorum nostram aciem premebant. Id cum animadvertisset P. Crassus adulescens, qui equitatui praeerat, quod expeditior erat quam ii qui inter aciem versabantur, tertiam aciem laborantibus nostris subsidio misit.
[53] Ita proelium restitutum est, atque omnes hostes terga verterunt nec prius fugere destiterunt quam ad flumen Rhenum milia passuum ex eo loco circiter L pervenerunt. Ibi perpauci aut viribus confisi tranare contenderunt aut lintribus inventis sibi salutem reppererunt. In his fuit Ariovistus, qui naviculam deligatam ad ripam nactus ea profugit; reliquos omnes consecuti equites nostri interfecerunt. Duae fuerunt Ariovisti uxores, una Sueba natione, quam domo secum eduxerat, altera Norica, regis Voccionis soror, quam in Gallia duxerat a fratre missam: utraque in ea fuga periit; duae filiae: harum altera occisa, altera capta est. C. Valerius Procillus, cum a custodibus in fuga trinis catenis vinctus traheretur, in ipsum Caesarem hostes equitatu insequentem incidit. Quae quidem res Caesari non minorem quam ipsa victoria voluptatem attulit, quod hominem honestissimum provinciae Galliae, suum familiarem et hospitem, ereptum ex manibus hostium sibi restitutum videbat neque eius calamitate de tanta voluptate et gratulatione quicquam fortuna deminuerat. Is se praesente de se ter sortibus consultum dicebat, utrum igni statim necaretur an in aliud tempus reservaretur: sortium beneficio se esse incolumem. Item M. Metius repertus et ad eum reductus est.
[54] Hoc proelio trans Rhenum nuntiato, Suebi, qui ad ripas Rheni venerant, domum reverti coeperunt; quos ubi qui proximi Rhenum incolunt perterritos senserunt, insecuti magnum ex iis numerum occiderunt. Caesar una aestate duobus maximis bellis confectis maturius paulo quam tempus anni postulabat in hiberna in Sequanos exercitum deduxit; hibernis Labienum praeposuit; ipse in citeriorem Galliam ad conventus agendos profectus est. |
LIBRO PRIMO
[1
La Gallia è, nel suo complesso, divisa in tre parti: la prima la abitano i
Belgi, l'altra gli Aquitani, la terza quelli che nella loro lingua
prendono il nome di Celti, nella nostra, di Galli. I tre popoli
differiscono tra loro per lingua, istituzioni e leggi. Il fiume Garonna
divide i Galli dagli Aquitani, la Marna e la Senna li separano dai Belgi.
Tra i vari popoli i più forti sono i Belgi, ed eccone i motivi: sono
lontanissimi dalla finezza e dalla civiltà della nostra provincia; i
mercanti, con i quali hanno scarsissimi contatti, portano ben pochi fra i
prodotti che tendono a indebolire gli animi; confinano con i Germani
d'oltre Reno e con essi sono continuamente in guerra. Anche gli Elvezi
superano in valore gli altri Galli per la stessa ragione: combattono con i
Germani quasi ogni giorno, o per tenerli lontani dai propri territori o
per attaccarli nei loro. La parte in cui, come si è detto, risiedono i
Galli, inizia dal Rodano, è delimitata dalla Garonna, dall'Oceano, dai
territori dei Belgi, raggiunge anche il Reno dalla parte dei Sequani e
degli Elvezi, è volta a settentrione. La parte dei Belgi inizia dalle più
lontane regioni della Gallia, si estende fino al corso inferiore del Reno,
guarda a settentrione e a oriente. L'Aquitania, invece, va dalla Garonna
fino ai Pirenei e alla parte dell'Oceano che bagna la Spagna, è volta a
occidente e a settentrione.
[2
Tra gli Elvezi il più nobile e il più ricco in assoluto fu Orgetorige.
Costui, al tempo del consolato di M. Messala e M. Pisone, mosso dal
desiderio di regnare, spinse i nobili a fare lega e convinse il popolo a
emigrare in massa: sosteneva che avrebbero potuto impadronirsi dell'intera
Gallia con estrema facilità, poiché erano più forti di tutti. Li persuase
più facilmente perché, da ogni parte, gli Elvezi sono bloccati dalla
conformazione naturale della regione: da un lato sono chiusi dal Reno,
fiume assai largo e profondo, che divide le loro terre dai Germani;
dall'altro incombe su di essi il Giura, un monte altissimo, al confine tra
Elvezi e Sequani; dal terzo lato sono chiusi dal lago Lemano e dal Rodano,
che li separa dalla nostra provincia. Ne conseguiva che potevano compiere
solo brevi spostamenti e attaccare i popoli limitrofi con maggiore
difficoltà. Sotto questo aspetto gli Elvezi, gente con la voglia di
combattere, erano profondamente scontenti. Inoltre, mi rapporto al loro
numero e alla gloria della loro potenza militare, ritenevano di possedere
territori troppo piccoli, che si estendevano per duecentoquaranta miglia
in lunghezza e centottanta in larghezza.
[3
Spinti da tali motivi e indotti dal prestigio di Orgetorige, gli Elvezi
decisero di preparare ciò che serviva per la partenza: comprarono quanti
più giumenti e carri fosse possibile, seminarono tutto il grano che gli
riuscì di seminare, per averne a sufficienza durante il viaggio,
rafforzarono i rapporti di pace e di amicizia con i popoli più vicini.
Ritennero che due anni fossero sufficienti per portare a termine i
preparativi: con una legge fissarono la partenza al terzo anno. Per
eseguire tali operazioni viene scelto Orgetorige, che si assume il compito
di recarsi in ambasceria presso gli altri popoli. Durante la sua missione,
il sequano Castico, figlio di Catamantalede, che era stato per molti anni
signore dei Sequani e aveva ricevuto dal senato del popolo romano il
titolo di amico, venne persuaso da Orgetorige a impadronirsi del regno che
in precedenza era stato del padre. Allo stesso modo Orgetorige convince ad
analoga azione l'eduo Dumnorige, al quale dà in sposa sua figlia.
Dumnorige era fratello di Diviziaco, a quel tempo principe degli Edui e
amatissimo dal suo popolo. Orgetorige dimostra a Castico e a Dumnorige che
è assai facile portare a compimento l'impresa, perché egli stesso sta per
prendere il potere: gli Elvezi, senza dubbio, erano i più forti tra tutti
i Galli. Assicura che con le sue truppe e con il suo esercito avrebbe
procurato loro il regno. Spinti dalle sue parole, si scambiano giuramenti
di fedeltà, sperando, una volta ottenuti i rispettivi domini, di potersi
impadronire di tutta la Gallia mediante i tre popoli più potenti e più
forti.
[4
Un delatore svelò l'accordo agli Elvezi. Secondo la loro usanza, essi
costrinsero Orgetorige a discolparsi incatenato: se lo avessero
condannato, la pena comportava il rogo. Nel giorno stabilito per il
processo, Orgetorige fece venire da ogni parte tutti i suoi familiari e
servi, circa diecimila persone, nonché tutti i suoi clienti e debitori,
che erano molto numerosi. Grazie a essi riuscì a sottrarsi
all'interrogatorio. Mentre il popolo, adirato per l'accaduto, cercava di
far valere con le armi il proprio diritto e i magistrati radunavano dalle
campagne una grande moltitudine di uomini, Orgetorige morì. Non mancò il
sospetto, secondo l'opinione degli Elvezi, che si fosse suicidato.
[5
Dopo la morte di Orgetorige, gli Elvezi cercano ugualmente di attuare il
progetto di abbandonare il loro territorio. Quando ritengono di essere
ormai pronti per la partenza, incendiano tutte le loro città, una dozzina,
i loro villaggi, circa quattrocento, e le singole case private che ancora
restavano; danno fuoco a tutto il grano, a eccezione delle scorte che
dovevano portare con sé, per essere più pronti ad affrontare tutti i
pericoli, una volta privati della speranza di tornare in patria; ordinano
che ciascuno porti da casa farina per tre mesi. Persuadono i Rauraci, i
Tulingi e i Latobici, con i quali confinavano, a seguire la loro
decisione, a incendiare le città e i villaggi e a partire con loro.
Accolgono e si aggregano come alleati i Boi, che si erano stabiliti al di
là del Reno, erano passati nel Norico e avevano assediato Noreia.
[6
Le strade, attraverso le quali gli Elvezi potevano uscire dal loro
territorio, erano in tutto due: la prima, stretta e difficoltosa,
attraversava le terre dei Sequani tra il monte Giura e il Rodano e
permetteva, a stento, il transito di un carro per volta; inoltre, il Giura
incombeva su di essa a precipizio, in modo tale che pochissimi bastavano
facilmente a impedire il passaggio; la seconda attraversava la nostra
provincia ed era molto più agevole e rapida, perché tra i territori degli
Elvezi e degli Allobrogi, da poco pacificati, scorre il Rodano, che in
alcuni punti consente il guado. Ginevra è la città degli Allobrogi più
settentrionale e confina con i territori degli Elvezi, ai quali è
collegata da un ponte. Gli Elvezi, per garantirsi via libera, pensavano di
persuadere gli Allobrogi, che non sembravano ancora ben disposti verso i
Romani, o di obbligarli con la forza. Ultimati i preparativi per la
partenza, stabiliscono la data in cui avrebbero dovuto riunirsi tutti
sulla riva del Rodano: cinque giorni prima delle calende di aprile,
nell'anno del consolato di L. Pisone e A. Gabinio.
[7
Cesare, appena informato che gli Elvezi si proponevano di attraversare la
nostra provincia, affretta la sua partenza da Roma, si dirige a marce
forzate, con la massima rapidità, verso la Gallia transalpina e giunge a
Ginevra. Ordina che tutta la provincia fornisca il maggior numero
possibile di soldati (in Gallia transalpina c'era una sola e unica
legione) e dà disposizione di distruggere il ponte che sorgeva nei pressi
della città. Gli Elvezi, conosciuto il suo arrivo, gli inviano come
ambasciatori i cittadini più nobili, con in testa Nammeio e Veruclezio,
incaricati di dirgli che, poiché non esisteva altro cammino, erano
intenzionati ad attraversare la provincia senza arrecare danni e gliene
chiedevano licenza. Cesare, memore che gli Elvezi avevano ucciso il
console L. Cassio e costretto l'esercito romano, dopo averlo sconfitto, a
subire l'onta del giogo, non riteneva giusto concedere il permesso;
inoltre, era convinto che questa gente dall'animo ostile non si sarebbe
astenuta da offese e danni, una volta concessa la facoltà di attraversare
la provincia. Tuttavia, per guadagnare tempo fino all'arrivo dei soldati
da lui richiesti, risponde agli ambasciatori che si riservava qualche
giorno di tempo per decidere: se a loro andava bene, ritornassero alle idi
di aprile.
[8
Nel frattempo, impiegando la legione al suo seguito e i soldati giunti
dalla provincia, Cesare scava un fossato ed erige un muro lungo diciannove
miglia e alto sedici piedi, dal lago Lemano, che sbocca nel Rodano, fino
al monte Giura, che divide i territori dei Sequani dagli Elvezi. Ultimata
l'opera, dispone presidi e costruisce ridotte per respingere con maggior
facilità gli Elvezi, se avessero tentato di passare suo malgrado. Quando
giunse il giorno fissato con gli ambasciatori ed essi ritornarono, Cesare
disse che, conforme alle tradizioni e ai precedenti del popolo romano, non
poteva concedere ad alcuno il transito attraverso la provincia e si
dichiarò pronto a impedir loro il passaggio nel caso cercassero di far
ricorso alla forza. Gli Elvezi, persa questa speranza, cercarono di
aprirsi un varco sia di giorno, sia, più spesso, di notte, o per mezzo di
barche legate insieme e di zattere, che avevano costruito in gran numero,
o guadando il Rodano nei punti in cui era meno profondo. Respinti dalle
fortificazioni e dall'intervento dei nostri soldati, rinunciarono ai loro
tentativi.
[9
Agli Elvezi rimaneva solo la strada attraverso le terre dei Sequani;
contro il loro volere, però, non avrebbero potuto passare, perché era
troppo stretta. Da soli non sarebbero riusciti a persuadere i Sequani,
perciò mandarono degli emissari all'eduo Dumnorige, per ottenere via
libera grazie alla sua intercessione. Dumnorige era molto potente presso i
Sequani per il favore di cui godeva e per le sue elargizioni, ed era amico
degli Elvezi perché aveva preso in moglie una elvetica, la figlia di
Orgetorige; inoltre, spinto dalla brama di regnare, tendeva a novità
politiche e voleva, mediante i benefici resi, tenere legati a sé quanti
più popoli possibile. Perciò, si assume l'incarico e ottiene che i Sequani
concedano agli Elvezi il permesso di transito e che le due parti si
scambino ostaggi: i Sequani per non ostacolare gli Elvezi durante
l'attraversamento del paese, gli Elvezi per attraversarlo senza provocare
offese o danni.
[10
A Cesare viene riferito il disegno degli Elvezi di attraversare i
territori dei Sequani e degli Edui per spingersi nella regione dei
Santoni, non lontani dai Tolosati, un popolo stanziato nella nostra
provincia. Si rendeva conto che, se ciò fosse accaduto, la presenza di
uomini bellicosi e ostili, al confine di quelle zone pianeggianti ed
estremamente fertili, avrebbe rappresentato un grave pericolo per la
provincia. Di conseguenza, posto il legato T. Labieno a capo delle
fortificazioni costruite, si dirige a marce forzate in Italia, dove
arruola due legioni e ne mobilita altre tre, che svernavano nei pressi di
Aquileia. Con le cinque legioni si dirige nella Gallia transalpina per la
via più breve, attraverso le Alpi. Qui i Ceutroni, i Graioceli e i
Caturigi, appostatisi sulle alture, tentano di sbarrare la strada al
nostro esercito. Respinti questi popoli in una serie di scontri, da Ocelo,
la più lontana città della Gallia cisalpina, Cesare dopo sei giorni di
marcia giunge nel territorio dei Voconzi, nella Gallia transalpina. Da qui
conduce l'esercito nelle terre degli Allobrogi e, poi, dei Segusiavi, il
primo popolo fuori della provincia, al di là del Rodano.
[11
Gli Elvezi, oltrepassati con le loro truppe gli impervi territori dei
Sequani, erano giunti nella regione degli Edui e ne devastavano i campi.
Gli Edui, non essendo in grado di difendere se stessi, né i propri beni,
inviano a Cesare un'ambasceria per chiedergli aiuto: in ogni circostanza
avevano acquisito meriti presso il popolo romano, perciò non avrebbero
dovuto vedere, quasi al cospetto del nostro esercito, i loro campi
saccheggiati, i loro figli asserviti, le loro città espugnate. Nello
stesso tempo gli Ambarri, affini per razza agli Edui, informano Cesare che
i loro campi erano stati devastati e che essi difficilmente avrebbero
potuto tenere lontane dalle loro città le forze nemiche. Allo stesso modo
gli Allobrogi, che al di là del Rodano avevano villaggi e possedimenti,
fuggono e si rifugiano da Cesare, dicendogli che nulla rimaneva loro, se
non la terra dei campi. Cesare, spinto da tali notizie, decide di non
dover aspettare che gli Elvezi giungano nei territori dei Santoni, dopo
aver distrutto tutti i beni degli alleati di Roma.
[12
C'è un fiume, la Saona, che scorre attraverso i territori degli Edui e dei
Sequani e si versa nel Rodano con incredibile placidità, tanto che a
occhio non è possibile stabilire quale sia il senso della corrente. Gli
Elvezi lo stavano attraversando con zattere e imbarcazioni legate. Cesare,
non appena fu informato dagli esploratori che i tre quarti degli Elvezi
erano già sull'altra sponda e che circa un quarto era rimasto al di qua
della Saona, dopo mezzanotte partì dall'accampamento con tre legioni e
raggiunse gli Elvezi che non avevano ancora varcato il fiume. Li colse
alla sprovvista, mentre erano ancora impacciati dalle salmerie: ne uccise
la maggior parte, i superstiti fuggirono e si nascosero nelle selve
circostanti. Questa tribù (infatti, il popolo degli Elvezi si divide, nel
suo complesso, in quattro tribù) si chiamava dei Tigurini. I Tigurini,
all'epoca dei nostri padri, erano stati gli unici a sconfinare, avevano
ucciso il console L. Cassio e sottoposto i suoi soldati all'onta del
giogo. Così, o per caso o per volontà degli dèi immortali, la prima a
pagare le proprie colpe fu proprio la tribù che aveva inferto al popolo
romano una memorabile sconfitta. Cesare vendicò non solo le offese
pubbliche, ma anche quelle private, perché i Tigurini, nella stessa
battaglia in cui era morto Cassio, avevano ucciso il legato L. Pisone, avo
di suo suocero L. Pisone.
[13
Dopodiché, per poter raggiungere le rimanenti truppe degli Elvezi, Cesare
ordina di costruire un ponte sulla Saona e, così, trasborda sull'altra
riva le sue truppe. Gli Elvezi, scossi dal suo arrivo repentino, quando si
resero conto che per attraversare il fiume a Cesare era occorso un giorno
solo, mentre essi avevano impiegato venti giorni di enormi sforzi, gli
mandarono degli ambasciatori. Li guidava Divicone, già capo degli Elvezi
all'epoca della guerra di Cassio. Divicone parlò a Cesare in questi
termini: se il popolo romano siglava la pace con gli Elvezi, essi si
sarebbero recati dove Cesare avesse deciso e voluto, per rimanervi; se,
invece, continuava con le operazioni di guerra, si ricordasse sia del
precedente rovescio del popolo romano, sia dell'antico eroismo degli
Elvezi. Aveva attaccato all'improvviso una sola tribù, quando gli uomini
ormai al di là del fiume non potevano soccorrerla: non doveva, dunque,
attribuire troppo merito, per la vittoria, al suo grande valore, o
disprezzare gli Elvezi, che avevano imparato dai padri e dagli avi a
combattere da prodi più che con l'inganno o gli agguati. Perciò, non si
esponesse al rischio che il luogo dove si trovavano prendesse il nome e
tramandasse alla storia la disfatta del popolo romano e il massacro del
suo esercito.
[14
A tali parole Cesare così rispose: tanto meno doveva esitare, perché ciò
che gli ambasciatori degli Elvezi avevano ricordato era impresso nella sua
mente, e quanto minore era stata la colpa del popolo romano, tanto maggior
dolore provava lui per la sconfitta: se i Romani avessero avuto coscienza
di qualche torto commesso, facilmente si sarebbero tenuti in guardia; ma
non pensavano di aver compiuto qualcosa per cui temere, né di dover temere
senza motivo, e questo li aveva traditi. E se anche avesse voluto
dimenticare le antiche offese, poteva forse rimuovere dalla mente le
recenti? Gli Elvezi, contro il suo volere, non avevano cercato di aprirsi
a forza un varco attraverso la provincia, non avevano infierito contro gli
Edui, gli Ambarri, gli Allobrogi? Che si gloriassero in modo tanto
insolente e si stupissero di aver evitato così a lungo la punizione delle
offese inflitte, concorreva a uno stesso scopo: gli dèi immortali, di
solito, quando vogliono castigare qualcuno per le sue colpe, gli
concedono, ogni tanto, maggior fortuna e un certo periodo di impunità,
perché abbia a dolersi ancor di più, quando la sorte cambia. La situazione
stava così, ma lui era disposto a far pace: gli Elvezi, però, dovevano
consegnargli ostaggi, a garanzia che le promesse le avrebbero mantenute, e
risarcire gli Edui, i loro alleati e gli Allobrogi per i danni arrecati.
Divicone replicò che gli Elvezi avevano imparato dai loro antenati a
ricevere, non a consegnare ostaggi; di ciò il popolo romano era testimone.
Detto questo, se ne andò.
[15
Il giorno seguente gli Elvezi tolgono le tende. Lo stesso fa Cesare e, per
vedere dove si dirigevano, manda in avanscoperta tutta la cavalleria, di
circa quattromila unità, reclutata sia in tutta la provincia, sia tra gli
Edui e i loro alleati. I nostri, inseguita con troppo slancio la
retroguardia degli Elvezi, si scontrano con la cavalleria nemica in un
luogo sfavorevole: pochi dei nostri cadono. Gli Elvezi, esaltati dal
successo, poiché con cinquecento cavalieri avevano sbaragliato un numero
di nemici così alto, incominciarono a fermarsi, di tanto in tanto, con
maggiore audacia e a provocare con la loro retroguardia i nostri. Cesare
tratteneva i suoi e si accontentava, per il momento, di impedire al nemico
ruberie, foraggiamenti e saccheggi. Proseguirono per circa quindici giorni
la marcia, in modo che gli ultimi reparti del nemico e i nostri primi non
distassero più di cinque o sei miglia.
[16
Nel frattempo, Cesare ogni giorno chiedeva agli Edui il grano che gli
avevano promesso ufficialmente. Infatti, a causa del freddo, dato che la
Gallia, come già si è detto, è situata a settentrione, non solo il
frumento nei campi non era ancora maturo, ma non c'era neppure una
quantità sufficiente di foraggio. Del grano, poi, che aveva fatto portare
su nave risalendo la Saona, Cesare non poteva far uso, perché gli Elvezi
si erano allontanati dal fiume ed egli non voleva perderne il contatto.
Gli Edui rimandavano di giorno in giorno: dicevano che il grano lo stavano
raccogliendo, che era già in viaggio, che stava per arrivare. Cesare,
quando si rese conto che da troppo tempo si tirava in lungo e che
incalzava il giorno della distribuzione ai soldati, convocò i principi
degli Edui, presenti in buon numero nell'accampamento; tra di essi c'erano
Diviziaco e Lisco. Quest'ultimo era il "vergobreto" - come lo chiamano gli
Edui - ossia il magistrato che riveste la carica più alta, è eletto
annualmente e ha potere di vita e di morte sui suoi concittadini. Cesare
li accusa duramente: non lo aiutavano proprio quando il grano non poteva
né comprarlo, né prenderlo dai campi, in un momento così critico e con il
nemico così vicino, tanto più che aveva intrapreso la guerra spinto
soprattutto dalle loro preghiere. Perciò, si lamenta ancor più
pesantemente di essere stato abbandonato.
[17
Solo allora Lisco, spinto dal discorso di Cesare, espone ciò che in
precedenza aveva passato sotto silenzio: c'erano degli individui che
godevano di grande prestigio tra il popolo e che, pur non rivestendo
cariche pubbliche, avevano da privati più potere dei magistrati stessi.
Erano loro a indurre la massa, con discorsi sediziosi e proditori, a non
consegnare il grano dovuto: sostenevano che, se gli Edui non erano più
capaci di conservare la signoria sul paese, era meglio sopportare il
dominio dei Galli piuttosto che dei Romani; i Romani, una volta sconfitti
gli Elvezi, avrebbero senza dubbio tolto la libertà agli Edui insieme agli
altri Galli. E le stesse persone rivelavano ai nemici i nostri piani e
tutto ciò che accadeva nell'accampamento. Lisco non era in grado di
tenerle a freno, anzi, adesso che era stato costretto a palesare a Cesare
la situazione così critica, si rendeva conto di quale pericolo stesse
correndo. Ecco il motivo per cui aveva taciuto il più a lungo possibile.
[18
Cesare intuiva che il discorso alludeva a Dumnorige, fratello di
Diviziaco, ma non voleva trattare l'argomento di fronte a troppa gente;
così, si affretta a sciogliere l'assemblea, ma trattiene Lisco. A tu per
tu gli chiede delucidazioni su ciò che aveva detto durante la riunione.
Lisco parla con maggior libertà e minor timore. Cesare, poi, prende
segretamente informazioni anche da altre fonti e scopre che era vero: si
trattava proprio di Dumnorige, un individuo di estrema audacia, di gran
credito presso il popolo per la sua liberalità e avido di rivolgimenti.
Per parecchi anni aveva ottenuto a basso prezzo l'appalto delle dogane e
di tutte le altre imposte, perché nessuno osava fare concorrenza alle sue
offerte. In questo modo aveva aumentato il patrimonio familiare e si era
procurato ingenti mezzi per fare delle elargizioni. A sue spese finanziava
costantemente un gran numero di cavalieri, che aveva sempre intorno a sé;
inoltre, non solo in patria, ma anche tra le genti confinanti godeva di
molta autorità e, per aumentarla, aveva dato in sposa sua madre a un uomo
molto nobile e potente della tribù dei Biturigi, aveva preso in moglie una
donna degli Elvezi, aveva fatto maritare una sua sorella dal lato materno
e altre sue parenti con uomini che appartenevano ad altri popoli. Favoriva
gli Elvezi ed era ben disposto nei loro confronti per ragioni di
parentela; nutriva anche un odio personale nei confronti di Cesare e dei
Romani, perché con il loro arrivo il suo potere era diminuito e suo
fratello Diviziaco aveva riacquistato la precedente posizione di influenza
e di onore. Nel caso di una sconfitta dei Romani aveva forti speranze di
ottenere il regno con l'appoggio degli Elvezi; sotto il dominio del popolo
romano non poteva nutrire speranze non solo di regnare, ma neppure di
mantenere l'influenza che aveva. Cesare, continuando nella sua indagine,
veniva anche a sapere che nel malaugurato scontro di cavalleria di recente
avvenuto, il primo a fuggire era stato Dumnorige con i suoi (infatti, era
lui il comandante della cavalleria che gli Edui avevano mandato di
rinforzo a Cesare): la loro fuga aveva seminato il panico tra gli altri
cavalieri.
[19
Cesare, una volta appurato tutto ciò, poiché ai sospetti si aggiungevano
dati di assoluta certezza (Dumnorige aveva fatto passare gli Elvezi
attraverso i territori dei Sequani; aveva promosso lo scambio degli
ostaggi; aveva agito sempre senza ricevere ordini da Cesare o dal suo
popolo, anzi a loro insaputa; era, infine, accusato dal magistrato degli
Edui), riteneva che vi fossero motivi sufficienti per procedere
personalmente contro Dumnorige o per invitare il suo popolo a punirlo. A
tutte le precedenti considerazioni, una sola si opponeva: Cesare aveva
conosciuto l'eccezionale devozione verso il popolo romano, la disposizione
davvero buona nei propri confronti, la straordinaria fedeltà, giustizia e
misura di Diviziaco, fratello di Dumnorige. Intervenendo contro
quest'ultimo, quindi, temeva di offendere i sentimenti di Diviziaco.
Perciò, prima di muoversi contro Dumnorige, convocò Diviziaco: allontanati
i soliti interpreti, utilizzò, per il colloquio, C. Valerio Trocillo,
principe della provincia della Gallia, suo parente, nel quale riponeva la
massima fiducia. Cesare inizia subito col ricordare a Diviziaco tutto ciò
che in sua presenza era stato detto su Dumnorige durante l'assemblea dei
Galli e lo mette al corrente delle informazioni che ciascuno,
singolarmente, gli aveva dato sul conto del fratello. Gli chiede, anzi lo
prega di non offendersi, se lui stesso, aperta un'inchiesta contro
Dumnorige, emetterà un giudizio o inviterà gli Edui a emetterlo.
[20
Diviziaco abbracciò Cesare e scoppiò in lacrime: incominciò a implorarlo
di non prendere provvedimenti troppo gravi nei confronti del fratello.
Diceva di sapere che era vero, ma ne era addolorato più di chiunque altro,
perché a rendere potente Dumnorige era stato proprio lui, Diviziaco,
quando era molto influente in patria e nel resto della Gallia, mentre suo
fratello non lo era affatto a causa della sua giovane età. Dumnorige,
però, si era servito delle risorse e delle forze acquisite, finendo non
solo per diminuire il favore di cui godeva suo fratello, ma quasi per
rovinare se stesso. Tuttavia, Diviziaco diceva di essere mosso sia
dall'affetto fraterno, sia dall'opinione della sua gente. Se Cesare
condannava Dumnorige a una pena grave, nessuno avrebbe creduto
all'estraneità di Diviziaco, che aveva una posizione di privilegio, come
amico di Cesare, ragion per cui egli avrebbe perso l'appoggio di tutti i
Galli. Piangendo, continuava a rivolgergli parole di supplica. Cesare,
prendendogli la destra, lo consola, gli chiede di non aggiungere altro e
gli dichiara che la sua influenza contava per lui tanto, che avrebbe
sacrificato al suo desiderio e alle sue preghiere sia l'offesa arrecata
alla repubblica, sia il proprio risentimento. Alla presenza del fratello
convoca Dumnorige, gli espone gli addebiti da muovergli, le cose che aveva
capito e quelle di cui il suo popolo si lamentava. Lo ammonisce a evitare
in futuro tutti i sospetti e gli dice che gli perdonava il passato in
virtù di suo fratello Diviziaco. Lo mette, però, sotto sorveglianza per
poter sapere che cosa facesse e con chi parlasse.
[21
Nello stesso giorno Cesare venne informato dagli esploratori che i nemici
si erano fermati alle pendici di un monte a otto miglia dal suo
accampamento. Mandò allora ad accertare quale fosse la conformazione del
monte e se c'era una via d'accesso. Gli riferirono che vi si poteva salire
con facilità. Ordina a T. Labieno, legato propretore, di salire dopo
mezzanotte sulla sommità del monte con due legioni, avvalendosi delle
guide che avevano effettuato il sopralluogo, e gli chiarisce il suo piano.
Lui stesso, dopo le tre di notte, per la stessa via percorsa dal nemico,
muove contro gli Elvezi, mandando avanti tutta la cavalleria. In
avanscoperta, con gli esploratori, viene spedito P. Considio, che aveva
fama di soldato espertissimo per avere servito prima nell'esercito di L.
Silla e, poi, in quello di M. Crasso.
[22
All'alba, mentre Labieno teneva la sommità del monte e Cesare non distava
più di millecinquecento passi dall'accampamento dei nemici, ignari, come
si seppe in seguito dai prigionieri, sia del suo arrivo, sia della
presenza di Labieno, Considio a briglia sciolta si precipita da Cesare e
gli comunica che il monte, di cui Labieno doveva impadronirsi, era nelle
mani dei nemici: lo aveva capito dalle armi e dalle insegne galliche.
Cesare comanda alle sue truppe di ritirarsi sul colle più vicino e le
schiera a battaglia. Labieno aveva ricevuto ordine di non attaccare finché
non avesse visto nei pressi dell'accampamento nemico le truppe di Cesare:
lo scopo era di sferrare l'assalto contemporaneamente da tutti i lati.
Labieno, perciò, teneva la sommità del monte e aspettava i nostri, senza
attaccare. Solo a giorno già inoltrato Cesare seppe dagli esploratori che
il monte era in mano ai suoi, che gli Elvezi avevano spostato
l'accampamento e che Considio, in preda al panico, aveva riferito di avere
visto ciò che, in realtà, non aveva visto. Quel giorno Cesare segue i
nemici alla solita distanza e si ferma a tre miglia dalle loro posizioni.
[23
L'indomani, considerando che mancavano solo due giorni alla distribuzione
di grano e che Bibracte, la città degli Edui più grande e più ricca in
assoluto, non distava più di diciotto miglia, Cesare pensò di dover
provvedere ai rifornimenti. Smette di seguire gli Elvezi e si affretta
verso Bibracte. Alcuni schiavi, fuggiti dalla cavalleria gallica del
decurione L. Emilio, riferiscono al nemico la faccenda. Gli Elvezi, o
perché pensavano che i Romani si allontanassero per paura, tanto più che
il giorno precedente non avevano attaccato pur occupando le alture, o
perché contavano di poter impedire ai nostri l'approvvigionamento di
grano, modificarono i loro piani, invertirono il senso di marcia e
incominciarono a inseguire e a provocare la nostra retroguardia.
[24
Cesare, quando se ne accorse, ritirò le sue truppe sul colle più vicino e
mandò la cavalleria a fronteggiare l'attacco nemico. Nel frattempo, a metà
del colle dispose, su tre linee, le quattro legioni di veterani, mentre in
cima piazzò le due legioni da lui appena arruolate nella Gallia cisalpina
e tutti gli ausiliari, riempiendo di uomini tutto il monte. Ordinò,
frattanto, che le salmerie venissero ammassate in un sol luogo e che lo
difendessero le truppe schierate più in alto. Gli Elvezi, che venivano
dietro con tutti i loro carri, raccolsero in un unico posto i bagagli, si
schierarono in formazione serratissima, respinsero la nostra cavalleria,
formarono la falange e avanzarono contro la nostra prima linea.
[25
Cesare ordinò di allontanare e nascondere prima il suo cavallo, poi quelli
degli altri: voleva rendere il pericolo uguale per tutti e togliere a
ognuno la speranza della fuga. Spronati i soldati, attaccò. I nostri
riuscirono con facilità a spezzare la falange nemica lanciando dall'alto i
giavellotti; una volta disunita la falange, sguainarono le spade e si
gettarono all'assalto. I Galli combattevano con grande difficoltà: molti
dei loro scudi erano stati trafitti e inchiodati da un solo lancio di
giavellotti; i giavellotti si erano piegati, per cui essi non riuscivano
né a svellerli, né a lottare nel modo migliore con la mano sinistra
impedita. Molti, dopo avere a lungo agitato il braccio, preferirono
gettare a terra gli scudi e combattere a corpo scoperto. Alla fine,
spossati per le ferite, incominciarono a ritirarsi e a cercar riparo su un
monte, che si trovava a circa un miglio di distanza; lì si attestarono.
Mentre i nostri si spingevano sotto, i Boi e i Tulingi, che con circa
quindicimila uomini chiudevano lo schieramento nemico e proteggevano la
retroguardia, aggirarono i nostri e li assalirono dal fianco scoperto.
Vedendo ciò, gli Elvezi che si erano rifugiati sul monte incominciarono a
premere di nuovo e a riaccendere lo scontro. I Romani operarono una
conversione e attaccarono su due fronti: la prima e la seconda linea per
tener testa agli Elvezi già vinti e respinti, la terza per reggere
all'urto dei nuovi arrivati.
[26
Così, si combatté su due fronti a lungo e con accanimento. Alla fine,
quando non poterono più sostenere l'attacco dei nostri, parte degli
Elvezi, come aveva già fatto prima, si mise al sicuro sul monte, parte si
ritirò là dove avevano ammassato i bagagli e i carri. A dire il vero, per
tutto il tempo della battaglia, durata dall'una del pomeriggio fino al
tramonto, nessuno poté vedere un solo nemico in fuga. Nei pressi delle
salmerie si lottò addirittura fino a notte inoltrata, perché gli Elvezi
avevano disposto i carri come una trincea e dall'alto scagliavano frecce
sui nostri che attaccavano. Alcuni, appostati tra i carri e le ruote,
lanciavano matare e tragule, colpendo i nostri. Dopo una lunga lotta, i
soldati romani si impadronirono dell'accampamento e delle salmerie. Qui
vennero catturati la figlia di Orgetorige e uno dei figli. Sopravvissero
allo scontro centotrentamila Elvezi e per tutta la notte marciarono
ininterrottamente. Senza fermarsi mai neppure nelle notti seguenti, dopo
tre giorni giunsero nei territori dei Lingoni. I nostri, invece, sia per
curare le ferite riportate dai soldati, sia per dare sepoltura ai morti,
si attardarono per tre giorni e non poterono incalzarli. Cesare inviò ai
Lingoni una lettera e dei messaggeri per proibir loro di fornire grano o
altro agli Elvezi: in caso contrario, li avrebbe trattati alla stessa
stregua. Al quarto giorno riprese a inseguire gli Elvezi con tutte le
truppe.
[27
Agli Elvezi mancava tutto il necessario per proseguire la guerra, perciò
inviarono degli ambasciatori a offrire la resa. Cesare era ancora in
marcia quando gli si fecero incontro; si gettarono ai suoi piedi e gli
chiesero pace, piangendo e supplicando. Cesare ordinò agli Elvezi di
aspettarlo dove adesso si trovavano, ed essi obbedirono. Appena giunto,
chiese la consegna degli ostaggi, delle armi e degli schiavi fuggiti.
Mentre gli Elvezi stavano ancora provvedendo alla ricerca e alla raccolta,
scese la notte, nelle prime ore della quale circa seimila uomini della
tribù dei Verbigeni lasciarono l'accampamento degli Elvezi e si diressero
verso il Reno e i territori dei Germani: forse temevano di essere uccisi,
una volta consegnate le armi, oppure speravano di salvarsi, pensando che
in mezzo a tanta gente che si era arresa la loro fuga potesse rimanere
nascosta o passare del tutto inosservata.
[28
Cesare, appena lo seppe, ordinò ai popoli, attraverso i cui territori
erano passati i Verbigeni, di cercarli e di riportarglieli, se volevano
essere giustificati ai suoi occhi. Trattò come nemici i Verbigeni
catturati, mentre accettò la resa degli Elvezi che gli consegnarono
ostaggi, armi e fuggiaschi. Comandò agli Elvezi, ai Tulingi e ai Latobici
di ritornare nei territori dai quali erano partiti e, poiché in patria
erano andati perduti tutti i raccolti e non avevano più nulla con cui
sfamarsi, diede disposizione agli Allobrogi di rifornirli di grano. Ordinò
agli Elvezi di ricostruire le città e i villaggi incendiati. La sua
intenzione era, soprattutto, di non lasciare spopolate le zone dalle quali
gli Elvezi si erano mossi: non voleva che i Germani d'oltre Reno
passassero nei territori degli Elvezi, più fertili, venendo a confinare
con la provincia della Gallia e con gli Allobrogi. I Boi, che avevano dato
prova di grande valore, ottennero il permesso di stabilirsi nei territori
degli Edui, che lo avevano richiesto. Ai Boi gli Edui diedero campi da
coltivare e, in seguito. concessero parità di diritti e la stessa
condizione di libertà di cui essi stessi godevano.
[29
Nell'accampamento degli Elvezi vennero trovate e consegnate a Cesare delle
tavolette scritte in caratteri greci. Si trattava di un elenco nominativo
degli uomini in grado di combattere che avevano lasciato i loro territori;
c'era anche, a parte, una lista riguardante i bambini, i vecchi e le
donne. La somma dei due elenchi contava duecentosessantatremila Elvezi,
trentaseimila Tulingi, quattordicimila Latobici, ventitremila Rauraci,
trentaduemila Boi. Circa novantaduemila erano, tra di essi, gli uomini in
grado di portare armi. Il totale ammontava a trecentosessantottomila. Si
tenne, per ordine di Cesare, un censimento generale degli Elvezi che
rientravano in patria: risultarono centodiecimila.
[30
Terminata la guerra con gli Elvezi, da quasi tutta la Gallia vennero a
congratularsi con Cesare, in veste di ambasciatori, i più autorevoli
cittadini dei vari popoli. Si rendevano conto che Cesare, con questa
guerra, aveva punito gli Elvezi per le vecchie offese da essi inflitte al
popolo romano, ma ne aveva tratto vantaggio la Gallia non meno di Roma:
gli Elvezi, pur godendo di grandissima prosperità, avevano abbandonato la
loro terra per portare guerra a tutta la Gallia, conquistarla e scegliersi
per insediamento, tra tutte le regioni del paese, la zona che avessero
giudicato più vantaggiosa e fertile, assoggettando gli altri popoli con un
tributo. Chiesero a Cesare il permesso di fissare una data per una
riunione generale dei Galli: volevano presentargli delle richieste, sulle
quali c'era completo accordo. Cesare acconsentì e tutti giurarono
solennemente di non rivelare gli argomenti trattati, se non su incarico
dell'assemblea stessa.
[31
Dopo che l'assemblea fu sciolta, si ripresentarono a Cesare i principi
delle varie popolazioni, gli stessi che già erano venuti da lui. Gli
chiesero di poter trattare con lui, segretamente, di questioni che
riguardavano non solo loro, ma la salvezza comune. Ottenuto il permesso,
si gettarono tutti ai suoi piedi, supplicandolo: desideravano e si
preoccupavano di non fare trapelare nulla del loro colloquio tanto quanto
di vedere esaudite le proprie richieste, perché erano certi che avrebbero
subito i peggiori tormenti, se la cosa si fosse risaputa. Parlò a nome di
tutti l'eduo Diviziaco: tutta la Gallia era divisa in due fazioni con a
capo, rispettivamente, gli Edui e gli Arverni. I due popoli si erano
contesi tenacemente la supremazia per molti anni, fino a che gli Arverni e
i Sequani non erano ricorsi all'aiuto dei Germani, assoldandoli. In un
primo tempo, avevano passato il Reno circa quindicimila Germani; quando,
però, questa gente rozza e barbara aveva incominciato ad apprezzare i
campi, la civiltà e le ricchezze dei Galli, il loro numero era aumentato:
adesso, in Gallia, ammontavano a circa centoventimila. Gli Edui e i popoli
loro soggetti li avevano affrontati più di una volta, ma avevano subito
una grave disfatta, perdendo tutti i nobili, tutti i senatori, tutti i
cavalieri. In passato, gli Edui detenevano il potere assoluto in Gallia
sia per il loro valore, sia per l'ospitalità e l'amicizia che li legava al
popolo romano; adesso, invece, prostrati dalle battaglie e dalle calamità,
erano stati costretti dai Sequani a consegnare in ostaggio i cittadini più
insigni e a vincolare il popolo con il giuramento di non chiedere la
restituzione degli ostaggi, di non implorare l'aiuto del popolo romano e
di non ribellarsi mai alla loro autorità. Ma lui, Diviziaco, non erano
riusciti a costringerlo: tra tutti gli Edui, era l'unico a non aver
giurato, né consegnato i propri figli in ostaggio. Era fuggito dalla sua
terra ed era venuto a Roma dal senato per chiedere aiuto, proprio perché
solo lui non era vincolato da giuramenti o da ostaggi. Ma ai Sequani
vincitori era toccata sorte peggiore che agli Edui vinti: Ariovisto, re
dei Germani, si era stabilito nei territori dei Sequani e aveva occupato
un terzo delle loro campagne, le più fertili dell'intera Gallia; adesso
ordinava ai Sequani di evacuarne un altro terzo, perché pochi mesi prima
lo avevano raggiunto circa ventimila Arudi e a essi voleva trovare una
regione in cui potessero stanziarsi. In pochi anni tutti i Galli sarebbero
stati scacciati dai loro territori e tutti i Germani avrebbero
oltrepassato il Reno. Non c'era paragone, infatti, tra le campagne dei
Galli e dei Germani, né tra il loro tenore di vita. Ariovisto, poi, da
quando aveva vinto l'esercito dei Galli ad Admagetobriga, regnava con
superbia e crudeltà, chiedeva in ostaggio i figli di tutti i più nobili e
riservava loro ogni specie di punizione e di tortura, se non eseguivano
gli ordini secondo il suo cenno e volere. Era un uomo barbaro, iracondo e
temerario. Non era possibile sopportare più a lungo le sue prepotenze. Se
non avessero trovato aiuto in Cesare e nel popolo romano, a tutti i Galli
non restava che seguire la decisione degli Elvezi: emigrare dalla patria,
cercarsi altra dimora, altre sedi lontane dai Germani e tentare la sorte,
qualunque cosa accadesse. Ma se Ariovisto avesse avuto notizia di tutto
questo, senza dubbio avrebbe inflitto terribili supplizi agli ostaggi in
sua mano. Cesare, avvalendosi del prestigio suo e dell'esercito oppure
sfruttando la recente vittoria o il nome del popolo romano, poteva
impedire che aumentasse il numero dei Germani in Gallia e difendere tutto
il paese dai torti di Ariovisto.
[32
Quando Diviziaco ebbe finito il suo discorso, tutti i presenti, tra grandi
pianti, iniziarono a chiedere aiuto a Cesare, il quale notò che solo i
Sequani non si comportavano per nulla come gli altri, ma, senza alzare lo
sguardo da terra, tenevano la testa bassa, tristi. Stupito, ne chiese loro
il motivo. I Sequani non risposero, continuando a rimanere in silenzio,
nello stesso atteggiamento di tristezza. Più volte Cesare ripeté la sua
domanda, senza ottenere la benché minima risposta. Intervenne ancora
Diviziaco: la sorte dei Sequani era molto più misera e pesante di quella
degli altri perché non osavano, neppure in una riunione segreta,
lamentarsi e implorare aiuto e rabbrividivano per la crudeltà di Ariovisto
come se fosse lì presente, anche se era lontano. E poi, perché gli altri,
almeno, avevano la possibilità di fuggire; essi, invece, che avevano
accolto Ariovisto nei loro territori e avevano visto le loro città cadere
nelle sue mani, dovevano sopportare tormenti d'ogni sorta.
[33
Cesare, sapute queste cose, rinfrancò i Galli con le sue parole e la
promessa che avrebbe preso a cuore la faccenda: aveva fondate speranze che
Ariovisto, in considerazione dei benefici ricevuti e del prestigio di
Cesare, avrebbe posto fine ai suoi torti. Detto ciò, sciolse l'assemblea.
Molte considerazioni, oltre alle precedenti, lo spingevano a ritenere che
fosse necessario riflettere sulla situazione e occuparsene: primo, vedeva
che gli Edui, più volte definiti dal senato fratelli e consanguinei, si
trovavano sotto il dominio e la schiavitù dei Germani e capiva che loro
ostaggi si trovavano nelle mani di Ariovisto e dei Sequani, cosa che
giudicava una vergogna per sé e per la repubblica, data la potenza del
popolo romano; secondo, riteneva pericoloso per Roma che, a poco a poco, i
Germani prendessero l'abitudine di oltrepassare il Reno e di stanziarsi in
Gallia in numero molto elevato. Infatti, stimava che questa gente, rozza e
barbara, una volta occupata tutta la Gallia, non avrebbe fatto a meno di
passare nella nostra provincia e di dirigersi verso l'Italia, come un
tempo i Cimbri ed i Teutoni, soprattutto tenendo conto che solo il Rodano
divide la nostra provincia dalla regione dei Sequani. Stimava, dunque, di
doversi occupare al più presto del problema. Ariovisto stesso, poi, aveva
assunto una superbia e una arroganza tale, che non lo si poteva più
sopportare.
[34
Perciò, Cesare decise di mandare ad Ariovisto degli ambasciatori,
incaricati di chiedergli che scegliesse un luogo per un colloquio, a metà
strada tra loro: voleva trattare di questioni politiche della massima
importanza per entrambi. Agli ambasciatori Ariovisto così rispose: se gli
serviva qualcosa da Cesare, si sarebbe recato di persona da lui; ma se era
Cesare a volere qualcosa, toccava a lui andare da Ariovisto. Inoltre, non
osava recarsi senza esercito nelle zone della Gallia possedute da Cesare,
né era possibile radunare l'esercito senza ingenti scorte di viveri e
grandi sforzi. Del resto, si domandava con meraviglia che cosa Cesare o,
in generale, il popolo romano avessero a che fare nella sua parte di
Gallia, da lui vinta in guerra.
[35
Ricevuta tale risposta, Cesare manda di nuovo ad Ariovisto degli
ambasciatori, coi compito di comunicargli quanto segue: durante il
consolato di Cesare, il senato e il popolo romano lo avevano definito re e
amico. Adesso, poiché così dimostrava a Cesare e al popolo romano la sua
gratitudine, rifiutandosi di venire a colloquio benché invitato e
ritenendo di non dover discutere o conoscere questioni di interesse
comune, Cesare, allora, gli notificava le proprie richieste: primo, di non
far più passare in Gallia altri Germani; secondo, di restituire gli
ostaggi ricevuti dagli Edui e di permettere ai Sequani di rendere quelli
che detenevano per ordine suo; infine, di non provocare ingiustamente gli
Edui e di non muovere guerra né a essi, né ai loro alleati. Regolandosi
così, Ariovisto si sarebbe garantito per sempre il favore e l'amicizia del
popolo romano. Cesare, invece, se non avesse ottenuto quanto chiedeva, non
sarebbe rimasto indifferente alle offese inflitte agli Edui, perché sotto
il consolato di M. Messala e M. Pisone il senato aveva stabilito che il
governatore della Gallia transalpina doveva difendere gli Edui e gli altri
amici del popolo romano, per quanto ciò rispondesse agli interessi di
Roma.
[36
Ariovisto replicò così: il diritto di guerra permetteva ai vincitori di
dominare i vinti a proprio piacimento; allo stesso modo il popolo romano
era abituato a governare i vinti non secondo le imposizioni altrui, ma a
proprio arbitrio. Se Ariovisto non dava ordini ai Romani su come
esercitare il loro diritto, non c'era ragione che i Romani ponessero
ostacoli a lui, quando applicava il suo. Gli Edui avevano tentato la sorte
in guerra, avevano combattuto ed erano usciti sconfitti; perciò, li aveva
resi suoi tributari. Era Cesare a fargli un grave torto, perché con il suo
arrivo erano diminuiti i versamenti dei popoli sottomessi. Non avrebbe
restituito gli ostaggi agli Edui, ma neppure avrebbe mosso guerra a essi,
né ai loro alleati, se rispettavano gli obblighi assunti, pagando ogni
anno i tributi. In caso contrario, poco sarebbe servito loro il titolo di
fratelli del popolo romano. Se Cesare lo aveva avvertito che non avrebbe
lasciato impunite le offese inferte agli Edui, gli rispondeva che nessuno
aveva combattuto contro Ariovisto senza subire una disfatta. Attaccasse
pure quando voleva: si sarebbe reso conto del valore degli invitti
Germani, che erano addestratissimi e per quattordici anni non avevano mai
avuto bisogno di un tetto.
[37
Nel momento stesso in cui a Cesare veniva riferita la risposta di
Ariovisto, giungevano emissari da parte degli Edui e dei Treveri. Gli Edui
si lamentavano che gli Arudi, da poco trasferitisi in Gallia, devastavano
il loro territorio: neppure la consegna degli ostaggi era valsa a ottenere
la pace da Ariovisto. I Treveri, invece, dicevano che le cento tribù degli
Svevi si erano stabilite lungo le rive del Reno e tentavano di
attraversarlo; li guidavano i fratelli Nasua e Cimberio. Cesare,
fortemente scosso dalle notizie, pensò di dover stringere i tempi per
evitare di incontrare maggiore resistenza, se il nuovo gruppo degli Svevi
si fosse aggiunto alle precedenti truppe di Ariovisto. Perciò, fatta al
più presto provvista di grano, mosse contro Ariovisto forzando le tappe.
[38
Dopo tre giorni di marcia gli riferirono che Ariovisto era partito dai
suoi territori già da tre giorni e si dirigeva con tutte le truppe verso
Vesonzione, la più grande città dei Sequani, per occuparla. Cesare giudicò
di dover impedire a ogni costo che Vesonzione cadesse. Infatti, nella
città si trovava, in abbondanza, tutto ciò che serve in guerra; inoltre,
era così protetta dalla conformazione naturale, da permettere con facilità
le operazioni belliche: il fiume Doubs la circonda quasi completamente,
come se il suo corso fosse stato tracciato con un compasso; dove non
scorre il fiume, in una zona che si estende per non più di milleseicento
piedi, sorge un monte molto elevato, la cui base tocca da entrambi i lati
le sponde del Doubs. Un muro circonda il monte, lo unisce alla città e ne
fa una roccaforte. Cesare qui si diresse, a marce forzate di giorno e di
notte. occupò la città e vi pose un presidio.
[39
Nei pochi giorni in cui Cesare si trattenne a Vesonzione per rifornirsi di
grano e di viveri, i Galli e i mercanti, interrogati dai nostri soldati,
andavano dicendo che i Germani erano uomini dal fisico imponente,
incredibilmente valorosi e avvezzi al combattimento; spesso li avevano
affrontati, ma non erano neppure riusciti a sostenerne l'aspetto e lo
sguardo. Di colpo, in seguito a tali voci, un timore così grande si
impadronì dei nostri, da sconvolgere profondamente le menti e gli animi di
tutti. Dapprima, si manifestò tra i tribuni militari, i prefetti e gli
altri privi di grande esperienza militare, che avevano seguito Cesare da
Roma per ragioni di amicizia. Tutti adducevano scuse, chi l'una, chi
l'altra, sostenendo di avere dei motivi che li costringevano a partire, e
ne chiedevano a Cesare il permesso. Alcuni, trattenuti dalla vergogna,
rimanevano, per non destare sospetti di timore, ma non potevano
contraffare l'espressione del volto, né talora trattenere le lacrime; al
sicuro, nelle loro tende, si lamentavano del loro destino o compiangevano
con i loro amici il comune pericolo. In ogni angolo dell'accampamento si
facevano testamenti. I discorsi e la paura di questa gente, a poco a poco,
impressionavano anche le persone provviste di grande esperienza militare:
legionari, centurioni e capi della cavalleria. Chi voleva apparire meno
pusillanime diceva di paventare non tanto il nemico, quanto la strada
molto stretta e l'estensione delle foreste che li dividevano da Ariovisto,
oppure di avere paura che il frumento non potesse essere trasportato tanto
facilmente. Alcuni avevano addirittura riferito a Cesare che, all'ordine
di togliere le tende e di avanzare, i soldati non avrebbero obbedito, né
levato il campo, terrorizzati com'erano.
[40
Cesare, messo in allarme, riunì il consiglio di guerra e convocò anche i
centurioni di ogni grado. Li rimproverò aspramente, perché, soprattutto,
avevano la presunzione di chiedersi e di rimuginare dove li portasse e con
quali intenzioni. Sotto il suo consolato, Ariovisto aveva ricercato con
molta ansia l'amicizia del popolo romano: chi poteva immaginarsi che
sarebbe venuto meno ai propri doveri così avventatamente? Dal canto suo,
era convinto che Ariovisto, conosciute le richieste e constatata l'equità
dei patti proposti, non avrebbe respinto l'appoggio di Cesare e del popolo
romano. E se, spinto da un demenziale impulso, avesse mosso guerra ai
Romani, che cosa mai dovevano temere? Che motivo c'era di non aver più
fiducia nel valore dei soldati o nella sua efficienza di generale? Ai
tempi dei loro padri avevano già affrontato il pericolo rappresentato da
quei nemici, quando i Cimbri e i Teutoni erano stati sconfitti da C. Mario
e l'esercito si era meritato non meno gloria del comandante stesso; un
pericolo simile lo avevano corso, e non erano passati molti anni, anche in
Italia con la rivolta degli schiavi, che però si erano avvalsi della
pratica e della disciplina imparate dai Romani. Tali esempi permettevano
di giudicare come sia positiva in sé la fermezza d'animo: proprio il
nemico, temuto a lungo e senza motivo quando era privo d'armi, lo avevano
successivamente sconfitto quando era armato e già vincitore. Infine, i
Germani erano lo stesso popolo con il quale gli Elvezi si erano più volte
scontrati, non solo nei propri territori, ma anche nei loro, riportando la
vittoria nella maggior parte dei casi. E gli Elvezi non erano riusciti a
tener testa all'esercito romano. Chi era rimasto scosso perché i Galli
erano stati sconfitti e messi in fuga, avrebbe scoperto, se si fosse
informato, che Ariovisto aveva logorato i suoi avversari con una guerra di
attesa, tenendosi per molti mesi in un accampamento tra le paludi, senza
esporsi mai. Poi, quando ormai i Galli disperavano di poter combattere e
si erano disuniti, li aveva assaliti, riuscendo, così, a sconfiggerli
grazie ai suoi calcoli e ai suoi piani più che al suo valore. Ma se c'era
spazio per questi calcoli contro dei barbari privi di esperienza militare,
neppure Ariovisto stesso si illudeva di poter così sorprendere il nostro
esercito. Chi esprimeva il proprio timore, fingendo di essere preoccupato
per le scorte di grano e per la strada molto stretta, era un insolente,
perché osava negare il senso del dovere del comandante o addirittura
voleva impartirgli delle direttive. I suoi compiti di comandante erano di
indurre i Sequani, i Leuci e i Lingoni a fornire il grano, ormai maturo
nei campi; quanto alla strada, avrebbero giudicato tra breve essi stessi.
Se si mormorava che i soldati non avrebbero eseguito gli ordini, né levato
il campo, non se ne curava affatto: conosceva, infatti, casi di
disobbedienza da parte delle truppe, ma si trattava di comandanti che
avevano fallito un'impresa ed erano stati abbandonati dalla fortuna dei
quali era stato scoperto qualche misfatto e dimostrata l'avidità. Ma tutta
la sua vita comprovava la sua onestà, la guerra contro gli Elvezi la sua
fortuna. Perciò, avrebbe dato subito l'ordine che voleva rimandare a più
tardi: avrebbe levato le tende la notte successiva, dopo le tre, per
accertarsi al più presto se in loro prevaleva la vergogna, unita al senso
del dovere, oppure la paura. E se, poi, nessuno lo avesse seguito, si
sarebbe messo in marcia, comunque, con la sola decima legione, su cui non
aveva dubbi: sarebbe stata la sua coorte pretoria. Nei confronti della
decima legione Cesare aveva avuto una benevolenza particolare e in essa
riponeva la massima fiducia per il suo valore.
[41
Dopo il discorso di Cesare, lo stato d'animo di tutti mutò in modo
sorprendente e in ognuno nacque una gran voglia di agire, un gran
desiderio di combattere. Per prima la decima legione, attraverso i tribuni
militari, lo ringraziò per lo straordinario apprezzamento ricevuto e
confermò di essere prontissima a scendere in campo. Poi le altre legioni,
con i tribuni militari e i centurioni più alti in grado, provvidero a
scusarsi con Cesare: non avevano mai nutrito dubbi o timori, né avevano
pensato che la valutazione delle scelte strategiche spettasse a loro, ma
al comandante. Cesare ne accettò le scuse e a Diviziaco, l'unico a cui
riservava la massima fiducia tra i Galli, chiese l'itinerario da seguirsi
per portare l'esercito in luoghi aperti compiendo un giro di oltre
cinquanta miglia. Come aveva preannunziato, dopo le tre di notte partì. Il
settimo giorno di marcia ininterrotta fu informato dagli esploratori che
le truppe di Ariovisto distavano dai nostri ventiquattro miglia.
[42
Ariovisto, informato dell'arrivo di Cesare, gli manda degli ambasciatori:
il colloquio sollecitato in precedenza poteva, per quanto lo riguardava,
aver luogo, perché Cesare si era avvicinato ed egli stimava di non correre
pericolo. Cesare non respinge la proposta, perché riteneva ormai che
Ariovisto avesse riacquistato il buon senso, visto che offriva
spontaneamente ciò che prima aveva negato, quando ne era stato richiesto.
Inoltre, Cesare nutriva grandi speranze che Ariovisto, in considerazione
dei grandi benefici ricevuti da lui e dal popolo romano, avrebbe deposto
la sua ostinazione, una volta conosciuto che cosa si voleva da lui. Il
colloquio fu fissato da lì a cinque giorni. Nel periodo di tempo che lo
precedette, si ebbe un'intensa attività diplomatica. Ariovisto pose come
condizione che Cesare non portasse al colloquio truppe di fanteria, perché
temeva di cadere in un'imboscata: entrambi sarebbero giunti con la
cavalleria, altrimenti non si sarebbe presentato. Cesare non voleva che,
per il frapporsi di un pretesto, il colloquio saltasse, ma neppure osava
mettersi nelle mani della cavalleria dei Galli; decise, perciò, che la
cosa più conveniente era lasciare a terra i cavalieri Galli e mettere in
sella i soldati della decima legione, nella quale riponeva la massima
fiducia, per avere, se c'era bisogno di agire, la scorta più leale
possibile. Mentre veniva eseguita l'operazione, uno dei soldati della
decima legione, non senza spirito, disse che Cesare aveva fatto per loro
più di quanto avesse promesso: aveva detto che li avrebbe presi come
coorte pretoria, adesso li faceva passare addirittura al rango equestre.
[43
C'era un'ampia pianura, con un rialzo di terra abbastanza grande,
all'incirca a pari distanza dagli accampamenti di Ariovisto e di Cesare.
Qui, come stabilito, si incontrarono per il colloquio. A duecento passi
dal rialzo, Cesare fermò i legionari che lo seguivano a cavallo. Anche i
cavalieri di Ariovisto si fermarono alla stessa distanza. Ariovisto chiese
che si parlasse senza scendere da cavallo e che ciascuno portasse con sé
dieci uomini. Quando giunsero sul posto, Cesare iniziò il suo discorso
ricordando i benefici resi ad Ariovisto da lui e dal senato: era stato
definito re e amico, gli erano stati inviati doni in abbondanza. Onori del
genere toccavano a poche persone ed i Romani, di solito, li concedevano in
considerazione di servigi eccezionali; Ariovisto, invece, pur non avendo
né titoli, né motivo per pretendere simili privilegi, li aveva ottenuti
grazie al favore e alla liberalità di Cesare e del senato. E gli
illustrava anche quanto fossero antiche e giuste le ragioni dei legami che
intercorrevano tra i Romani e gli Edui, quante e quali onorifiche
disposizioni il senato avesse preso nei loro riguardi, come gli Edui
avessero sempre detenuto l'egemonia su tutta la Gallia, ancor prima di
cercare la nostra amicizia. Il popolo romano voleva, per consuetudine, che
gli alleati e gli amici non solo non perdessero nulla del potere
acquisito, ma vedessero crescere il favore, la dignità, l'onore di cui
godevano: chi poteva, dunque, tollerare che venisse tolto agli Edui ciò
che avevano offerto all'amicizia del popolo romano? Ribadì, poi, le stesse
richieste presentate dai suoi ambasciatori: che Ariovisto non muovesse
guerra né agli Edui, né ai loro alleati, restituisse gli ostaggi e, se non
poteva rimandare indietro nessuno dei Germani ormai presenti in Gallia,
almeno non permettesse che altri oltrepassassero il Reno.
[44
Ariovisto dedicò poche parole alle richieste di Cesare, ma molte ne spese
per elencare i propri meriti: aveva passato il Reno non per volontà sua,
ma su richiesta e invito dei Galli; non aveva certo lasciato la patria e i
congiunti senza viva speranza di forti ricompense; in Gallia occupava sedi
che gli erano state concesse; gli ostaggi gli erano stati consegnati
spontaneamente; percepiva tributi secondo il diritto di guerra, che i
vincitori sono soliti imporre ai vinti. Non era stato lui ad aggredire i
Galli, ma i Galli lui; tutti i popoli della Gallia si erano mossi ed erano
scesi in campo contro di lui; li aveva respinti e sconfitti, tutti, in una
sola battaglia. Se i Galli intendevano riprovarci, era pronto a battersi
di nuovo, ma, se desideravano la pace, non era giusto che si rifiutassero
di pagare il tributo fino ad allora versato volontariamente. L'amicizia
del popolo romano doveva essere per lui non un danno, ma un vanto e una
protezione, e con questa speranza l'aveva richiesta. Se a causa del popolo
romano doveva rimetterci i tributi e restituire i prigionieri, avrebbe
rinunciato all'amicizia di Roma con lo stesso piacere con cui l'aveva
cercata. Se faceva passare al di qua del Reno molti Germani, era per
difendersi, non per assalire la Gallia: lo testimoniava il fatto che era
venuto solo perché lo avevano chiamato e non aveva mosso guerra, ma si era
difeso. Era giunto in Gallia prima del popolo romano, il cui esercito, in
precedenza, non era mai uscito dai confini della provincia della Gallia.
Che cosa cercava Cesare, come mai entrava nei possedimenti di Ariovisto?
Questa parte di Gallia era sua, così come l'altra era nostra. Come non era
ammissibile che i Romani cedessero, se i Germani avessero attaccato il
nostro territorio, così noi, allo stesso modo, eravamo in torto a
interferire nel suo diritto. Se Cesare dichiarava che gli Edui avevano
ricevuto il titolo di amici dal senato, gli rispondeva che non era così
barbaro, né sprovveduto da ignorare che gli Edui non avevano aiutato i
Romani nel recente conflitto con gli Allobrogi, né si erano avvalsi del
sostegno del popolo romano nella lotta contro di lui e i Sequani. Doveva
sospettare che Cesare simulasse questa amicizia e tenesse in Gallia un
esercito con il solo scopo di sopraffarlo. Se Cesare non si ritirava con
le sue truppe dalle regioni in questione, lo avrebbe considerato non un
amico, ma un nemico. E se lo avesse ucciso, avrebbe fatto cosa gradita a
molti nobili e capi del popolo romano; lo aveva saputo da loro emissari:
con la morte di Cesare poteva guadagnarsi il favore e l'amicizia di tutti
loro. Ma se Cesare si allontanava e gli concedeva il libero possesso della
Gallia, lo avrebbe ricompensato ampiamente e gli avrebbe consentito di
muovere qualsiasi guerra volesse, senza travaglio o pericolo alcuno.
[45
Cesare, in risposta, spiegò lungamente ad Ariovisto perché non poteva
venir meno all'impegno preso: né lui, né il popolo romano avevano
l'abitudine di abbandonare gli alleati molto benemeriti; inoltre, non
riteneva che la Gallia spettasse ad Ariovisto più che al popolo romano. Q.
Fabio Massimo aveva sconfitto gli Arverni e i Ruteni; il popolo romano li
aveva perdonati, non aveva ridotto a provincia i loro territori, né
imposto tributi. Se occorreva riandare ai tempi più antichi, il dominio
del popolo romano in Gallia era il più giusto; se bisognava rispettare il
decreto del senato, la Gallia doveva rimanere libera, perché, vinta in
guerra da Roma, aveva voluto mantenere le proprie leggi.
[46
Mentre il colloquio andava svolgendosi in questo modo, a Cesare venne
riferito che i cavalieri di Ariovisto si avvicinavano al rialzo e si
dirigevano contro i nostri, scagliando pietre e frecce. Allora interruppe
il discorso, raggiunse i suoi e diede ordine tassativo di non rispondere
ai nemici neanche con un dardo. Infatti, anche se nello scontro con la
cavalleria nemica non prevedeva alcun pericolo per la sua legione
prediletta, tuttavia non ritenne opportuno ingaggiar battaglia, perché i
nemici, battuti, non potessero sostenere di essere caduti vittima di un
tradimento di Cesare, durante il colloquio. Quando tra le nostre truppe si
sparse la voce, dappertutto, del tono di arroganza assunto da Ariovisto,
che aveva interdetto ai Romani tutta la Gallia, e di come i suoi cavalieri
avessero assalito i nostri, causando l'interruzione del colloquio,
nell'esercito si destò un ardore e un desiderio di combattere ancor più
vivo.
[47
Due giorni dopo, Ariovisto inviò a Cesare un'ambasceria: voleva trattare
delle questioni di cui avevano cominciato a discutere senza giungere a una
conclusione: perciò, gli chiedeva di scegliere un giorno per un nuovo
incontro o, se preferiva, di mandare uno dei suoi in veste di legato.
Cesare non vedeva motivo di riprendere il colloquio, tanto più che il
giorno precedente i Germani non avevano saputo trattenersi dal lanciare
frecce contro i nostri. Riteneva che mandare uno dei suoi in veste di
legato, mettendolo nelle mani di quegli uomini rozzi, fosse molto
pericoloso. La cosa più utile gli sembrò inviare C. Valerio Procillo, un
giovane di notevolissimo valore e civiltà, figlio di C. Valerio Caburo, il
quale aveva ricevuto la cittadinanza romana da C. Valerio Flacco: gli dava
piena fiducia, conosceva la lingua gallica, che Ariovisto parlava
piuttosto bene per lunga consuetudine e, infine, i Germani non avevano
motivo di essere scorretti nei riguardi di C. Valerio Procillo. Con lui
inviò M. Mezio, che aveva con Ariovisto vincoli di ospitalità. Cesare li
incaricò di sentire le proposte e di riferirgliele. Ma quando Ariovisto li
vide nel suo accampamento, alla presenza del suo esercito cominciò a
gridare: cosa venivano a fare da lui? Volevano spiarlo? I due tentarono di
rispondere, ma Ariovisto li obbligò a tacere e li fece gettare in catene.
[48
Quel giorno stesso Ariovisto si spostò in avanti e si stabilì ai piedi di
un monte, a sei miglia dall'accampamento di Cesare. L'indomani transitò
con le sue truppe davanti al campo romano, lo oltrepassò e pose le tende a
due miglia di distanza, con l'intento di impedire a Cesare di ricevere il
grano e i viveri che venivano forniti dai Sequani e dagli Edui. Da quel
momento, per cinque giorni consecutivi, Cesare condusse le sue truppe
davanti al campo, in formazione da combattimento, per dare ad Ariovisto la
possibilità di misurarsi con lui, se lo voleva. Ma Ariovisto, per tutti e
cinque i giorni, tenne bloccato il suo esercito nell'accampamento,
limitandosi quotidianamente a semplici scaramucce di cavalleria. I Germani
erano addestrati in questa tecnica militare disponevano di seimila
cavalieri e di altrettanti fanti molto veloci e forti; ciascun cavaliere
aveva scelto tra tutta la truppa, a propria tutela, un fante, insieme al
quale entrava nella mischia. I cavalieri si riparavano presso i fanti,
che, se c'era qualche pericolo, si precipitavano; se il cavaliere veniva
ferito piuttosto gravemente e cadeva da cavallo, lo attorniavano; se
dovevano spingersi più lontano o ripiegare più alla svelta, si erano
garantiti con l'esercizio una tale rapidità, da reggere all'andatura dei
cavalli, tenendosi aggrappati alla criniera.
[49
Constatato che Ariovisto rimaneva nel suo accampamento, Cesare, per non
vedersi tagliati i rifornimenti, scelse una zona adatta per porre le
tende, al di là del posto in cui si erano stabiliti i Germani, a una
distanza di circa seicento passi da essi. Schierato l'esercito su tre
linee, giunse al luogo prescelto e ordinò che le prime due linee
rimanessero in armi e che la terza fortificasse l'accampamento. Il luogo
distava, come già si è detto, circa seicento passi dal nemico. Ariovisto
vi inviò circa sedicimila uomini senza bagagli e tutta la cavalleria, per
atterrire i nostri e impedire l'opera di fortificazione. Cesare, non di
meno, come aveva in precedenza stabilito, ordinò alle prime due linee di
respingere il nemico e alla terza di portare a termine i lavori.
Fortificato il sito, con una parte delle truppe ausiliarie lasciò due
legioni e ricondusse nel campo maggiore le quattro rimanenti.
[50
Il giorno successivo, secondo la sua abitudine, Cesare fece uscire le sue
truppe dai due accampamenti, le schierò a battaglia non molto lontano dal
campo maggiore e diede al nemico la possibilità di combattere. Quando si
rese conto che neppure allora i nemici si sarebbero fatti avanti, verso
mezzogiorno ordinò ai suoi soldati di rientrare negli accampamenti. Solo
allora Ariovisto inviò una parte delle sue truppe ad assalire il campo
minore. Fino a sera si combatté con accanimento da ambo le parti. Al
tramonto Ariovisto richiamò le sue truppe, che avevano inflitto ai nostri
molte perdite, ma molte ne avevano subite. Cesare chiese ai prigionieri
per quale motivo Ariovisto non accettasse lo scontro aperto e ne scoprì la
causa: presso i Germani era consuetudine che le madri di famiglia,
consultando le sorti e i vaticini, dichiarassero se era vantaggioso
combattere o no. In questo caso, il responso era stato il seguente: il
destino è avverso alla vittoria dei Germani, se combatteranno prima della
luna nuova.
[51
Il giorno successivo Cesare lasciò in entrambi gli accampamenti un
presidio a suo parere sufficiente e dispiegò tutte le truppe degli alleati
davanti all'accampamento minore, ben visibili, sfruttandole per ingannare
il nemico, dato che i legionari erano inferiori ai Germani, dal punto di
vista numerico; sistemato l'esercito su tre linee, avanzò fino
all'accampamento dei nemici. Solo allora i Germani furono costretti a
condurre fuori le loro truppe e si disposero secondo le varie tribù, a
pari distanza le une dalle altre: gli Arudi, i Marcomanni, i Triboci, i
Vangioni, i Nemeti, i Sedusi, gli Svevi. Tutto intorno collocarono carri e
carriaggi, per togliere a chiunque la speranza di fuggire. Sui carri
fecero salire le loro donne, che, mentre essi partivano per combattere,
piangevano e con le mani protese li imploravano di non renderle schiave
dei Romani.
[52
Cesare mise a capo di ciascuna legione i rispettivi legati e il questore,
perché ognuno li avesse a testimoni del proprio valore; egli stesso guidò
l'attacco alla testa dell'ala destra, perché si era accorto che da quella
parte lo schieramento nemico era molto debole. Al segnale, i nostri
attaccarono con tale veemenza e i nemici si slanciarono in avanti così
all'improvviso e con tale rapidità, che non si ebbe il tempo di lanciare i
giavellotti. Ci si sbarazzò di essi e si combatté corpo a corpo, con le
spade. I Germani formarono rapidamente, secondo la loro abitudine, delle
falangi e ressero all'assalto condotto con le spade. Si videro molti
soldati romani salire sopra le varie falangi, strappare via con le mani
gli scudi dei nemici e colpire dall'alto. Mentre l'ala sinistra dello
schieramento nemico veniva respinta e messa in fuga, l'ala destra con la
sua massa premeva violentemente sui nostri. Il giovane P. Crasso,
comandante della cavalleria, essendo nei movimenti più libero di chi
combatteva nel folto dello schieramento, se ne accorse e mandò la terza
linea in aiuto dei nostri in difficoltà.
[53
Questa mossa salvò le sorti della battaglia: i nemici volsero tutti le
spalle e non si fermarono prima di aver raggiunto il Reno, che distava
circa cinque miglia dal luogo dello scontro. Qui, pochissimi o cercarono
di attraversare il fiume a nuoto, confidando nelle proprie forze, o
scovarono delle imbarcazioni e si misero in salvo. Tra di loro ci fu
Ariovisto, il quale trovò legata alla riva una piccola barca che gli servì
per fuggire; tutti gli altri Germani furono inseguiti dalla nostra
cavalleria e uccisi. Ariovisto aveva due mogli: una sveva, che si era
portato da casa, l'altra norica, sorella del re Voccione, che gli era
stata inviata dal fratello stesso e che Ariovisto aveva sposato in Gallia.
Entrambe morirono nella rotta. Delle due figlie, una fu uccisa, l'altra
catturata. C. Valerio Procillo, mentre durante la fuga veniva portato via
dai suoi guardiani legato con triplice catena, si imbatté proprio in
Cesare, che con la cavalleria stava inseguendo i nemici. Ciò procurò a
Cesare una gioia non minore della vittoria stessa, perché si vedeva
restituito, strappato alle mani del nemico, l'uomo più onesto della
provincia della Gallia, suo amico e ospite: la Fortuna non aveva voluto
togliere nulla alla sua grande gioia e contentezza e aveva impedito la
morte di C. Valerio Procillo. Il giovane raccontava che, in sua presenza,
erano state consultate tre volte le sorti per decidere se doveva essere
arso sul rogo subito o in un secondo tempo: era vivo per beneficio delle
sorti. Anche M. Mezio fu ritrovato e riportato a Cesare.
[54
Quando al di là del Reno si ebbe notizia della battaglia, gli Svevi, che
erano giunti alle rive del fiume, incominciarono a ritornare in patria.
Non appena gli Ubi, che abitano nei pressi del Reno, si accorsero che gli
Svevi erano in preda al panico, li inseguirono e ne uccisero un gran
numero. Cesare, che in una sola campagna aveva concluso due grandissime
guerre, tradusse l'esercito negli accampamenti invernali, nelle terre dei
Sequani, un po' prima di quanto non richiedesse la stagione. Qui lasciò
Labieno come comandante e si recò in Gallia cisalpina, per tenervi le
sessioni giudiziarie. |
LIBER SECUNDUS
[1] Cum esset Caesar in citeriore Gallia [in hibernis], ita uti supra demonstravimus, crebri ad eum rumores adferebantur litterisque item Labieni certior fiebat omnes Belgas, quam tertiam esse Galliae partem dixeramus, contra populum Romanum coniurare obsidesque inter se dare. Coniurandi has esse causas: primum quod vererentur ne, omni pacata Gallia, ad eos exercitus noster adduceretur; deinde quod ab non nullis Gallis sollicitarentur, partim qui, ut Germanos diutius in Gallia versari noluerant, ita populi Romani exercitum hiemare atque inveterascere in Gallia moleste ferebant, partim qui mobilitate et levitate animi novis imperiis studebant; ab non nullis etiam quod in Gallia a potentioribus atque iis qui ad conducendos homines facultates habebant vulgo regna occupabantur; qui minus facile eam rem imperio nostro consequi poterant.
[2] His nuntiis litterisque commotus Caesar duas legiones in citeriore Gallia novas conscripsit et inita aestate in ulteriorem Galliam qui deduceret Q. Pedium legatum misit. Ipse, cum primum pabuli copia esse inciperet, ad exercitum venit. Dat negotium Senonibus reliquisque Gallis qui finitimi Belgis erant uti ea quae apud eos gerantur cognoscant seque de his rebus certiorem faciant. Hi constanter omnes nuntiaverunt manus cogi, exercitum in unum locum conduci. Tum vero dubitandum non existimavit quin ad eos proficisceretur. Re frumentaria provisa castra movet diebusque circiter XV ad fines Belgarum pervenit.
[3] Eo cum de improviso celeriusque omnium opinione venisset, Remi, qui proximi Galliae ex Belgis sunt, ad eum legatos Iccium et Andebrogium, primos civitatis, miserunt, qui dicerent se suaque omnia in fidem atque potestatem populi Romani permittere, neque se cum reliquis Belgis consensisse neque contra populum Romanum coniurasse, paratosque esse et obsides dare et imperata facere et oppidis recipere et frumento ceterisque rebus iuvare; reliquos omnes Belgas in armis esse, Germanosque qui cis Rhenum incolant sese cum his coniunxisse, tantumque esse eorum omnium furorem ut ne Suessiones quidem, fratres consanguineosque suos, qui eodem iure et isdem legibus utantur, unum imperium unumque magistratum cum ipsis habeant, deterrere potuerint quin cum iis consentirent.
[4] Cum ab iis quaereret quae civitates quantaeque in armis essent et quid in bello possent, sic reperiebat: plerosque Belgos esse ortos a Germanis Rhenumque antiquitus traductos propter loci fertilitatem ibi consedisse Gallosque qui ea loca incolerent expulisse, solosque esse qui, patrum nostrorum memoria omni Gallia vexata, Teutonos Cimbrosque intra suos fines ingredi prohibuerint; qua ex re fieri uti earum rerum memoria magnam sibi auctoritatem magnosque spiritus in re militari sumerent. De numero eorum omnia se habere explorata Remi dicebant, propterea quod propinquitatibus adfinitatibus quo coniuncti quantam quisque multitudinem in communi Belgarum concilio ad id bellum pollicitus sit cognoverint. Plurimum inter eos Bellovacos et virtute et auctoritate et hominum numero valere: hos posse conficere armata milia centum, pollicitos ex eo numero electa milia LX totiusque belli imperium sibi postulare. Suessiones suos esse finitimos; fines latissimos feracissimosque agros possidere. Apud eos fuisse regem nostra etiam memoria Diviciacum, totius Galliae potentissimum, qui cum magnae partis harum regionum, tum etiam Britanniae imperium obtinuerit; nunc esse regem Galbam: ad hunc propter iustitiam prudentiamque summam totius belli omnium voluntate deferri; oppida habere numero XII, polliceri milia armata L; totidem Nervios, qui maxime feri inter ipsos habeantur longissimeque absint; XV milia Atrebates, Ambianos X milia, Morinos XXV milia, Menapios VII milia, Caletos X milia, Veliocasses et Viromanduos totidem, Atuatucos XVIIII milia; Condrusos, Eburones, Caerosos, Paemanos, qui uno nomine Germani appellantur, arbitrari ad XL milia.
[5] Caesar Remos cohortatus liberaliterque oratione prosecutus omnem senatum ad se convenire principumque liberos obsides ad se adduci iussit. Quae omnia ab his diligenter ad diem facta sunt. Ipse Diviciacum Haeduum magnopere cohortatus docet quanto opere rei publicae communisque salutis intersit manus hostium distineri, ne cum tanta multitudine uno tempore confligendum sit. Id fieri posse, si suas copias Haedui in fines Bellovacorum introduxerint et eorum agros populari coeperint. His datis mandatis eum a se dimittit. Postquam omnes Belgarum copias in unum locum coactas ad se venire vidit neque iam longe abesse ab iis quos miserat exploratoribus et ab Remis cognovit, flumen Axonam, quod est in extremis Remorum finibus, exercitum traducere maturavit atque ibi castra posuit. Quae res et latus unum castrorum ripis fluminis muniebat et post eum quae erant tuta ab hostibus reddebat et commeatus ab Remis reliquisque civitatibus ut sine periculo ad eum portari possent efficiebat. In eo flumine pons erat. Ibi praesidium ponit et in altera parte fluminis Q. Titurium Sabinum legatum cum sex cohortibus relinquit; castra in altitudinem pedum XII vallo fossaque duodeviginti pedum muniri iubet.
[6] Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt. Aegre eo die sustentatum est. Gallorum eadem atque Belgarum oppugnatio est haec: ubi circumiecta multitudine hominum totis moenibus undique in murum lapides iaci coepti sunt murusque defensoribus nudatus est, testudine facta portas succedunt murumque subruunt. Quod tum facile fiebat. Nam cum tanta multitudo lapides ac tela coicerent, in muro consistendi potestas erat nulli. Cum finem oppugnandi nox fecisset, Iccius Remus, summa nobilitate et gratia inter suos, qui tum oppido praeerat, unus ex iis qui legati de pace ad Caesarem venerant, nuntium ad eum mittit, nisi subsidium sibi submittatur, sese diutius sustinere non posse.
[7] Eo de media nocte Caesar isdem ducibus usus qui nuntii ab Iccio venerant, Numidas et Cretas sagittarios et funditores Baleares subsidio oppidanis mittit; quorum adventu et Remis cum spe defensionis studium propugnandi accessit et hostibus eadem de causa spes potiundi oppidi discessit. Itaque paulisper apud oppidum morati agrosque Remorum depopulati, omnibus vicis aedificiisque quo adire potuerant incensis, ad castra Caesaris omnibus copiis contenderunt et a milibus passuum minus duobus castra posuerunt; quae castra, ut fumo atque ignibus significabatur, amplius milibus passuum VIII latitudinem patebant.
[8] Caesar primo et propter multitudinem hostium et propter eximiam opinionem virtutis proelio supersedere statuit; cotidie tamen equestribus proeliis quid hostis virtute posset et quid nostri auderent periclitabatur. Ubi nostros non esse inferiores intellexit, loco pro castris ad aciem instruendam natura oportuno atque idoneo, quod is collis ubi castra posita erant paululum ex planitie editus tantum adversus in latitudinem patebat quantum loci acies instructa occupare poterat, atque ex utraque parte lateris deiectus habebat et in fronte leniter fastigatus paulatim ad planitiem redibat, ab utroque latere eius collis transversam fossam obduxit circiter passuum CCCC et ad extremas fossas castella constituit ibique tormenta conlocavit, ne, cum aciem instruxisset, hostes, quod tantum multitudine poterant, ab lateribus pugnantes suos circumvenire possent. Hoc facto, duabus legionibus quas proxime conscripserat in castris relictis ut, si quo opus esset, subsidio duci possent, reliquas VI legiones pro castris in acie constituit. Hostes item suas copias ex castris eductas instruxerunt.
[9] Palus erat non magna inter nostrum atque hostium exercitum. Hanc si nostri transirent hostes expectabant; nostri autem, si ab illis initium transeundi fieret, ut impeditos adgrederentur, parati in armis erant. Interim proelio equestri inter duas acies contendebatur. Ubi neutri transeundi initium faciunt, secundiore equitum proelio nostris Caesar suos in castra reduxit. Hostes protinus ex eo loco ad flumen Axonam contenderunt, quod esse post nostra castra demonstratum est. Ibi vadis repertis partem suarum copiarum traducere conati sunt eo consilio ut, si possent, castellum, cui praeerat Q. Titurius legatus, expugnarent pontemque interscinderent; si minus potuissent, agros Remorum popularentur, qui magno nobis usui ad bellum gerendum erant, commeatuque nostros prohiberent.
[10]
[Caesar] certior factus ab Titurio omnem equitatum et levis armaturae Numidas, funditores sagittariosque pontem traducit atque ad eos contendit. Acriter in eo loco pugnatum est. Hostes impeditos nostri in flumine adgressi magnum eorum numerum occiderunt; per eorum corpora reliquos audacissime transire conantes multitudine telorum reppulerunt primosque, qui transierant, equitatu circumventos interfecerunt. Hostes, ubi et de expugnando oppido et de flumine transeundo spem se fefellisse intellexerunt neque nostros in locum iniquiorum progredi pugnandi causa viderunt atque ipsos res frumentaria deficere coepit, concilio convocato constituerunt optimum esse domum suam quemque reverti, et quorum in fines primum Romani exercitum introduxissent, ad eos defendendos undique convenirent, ut potius in suis quam in alienis finibus decertarent et domesticis copiis rei frumentariae uterentur. Ad eam sententiam cum reliquis causis haec quoque ratio eos deduxit, quod Diviciacum atque Haeduos finibus Bellovacorum adpropinquare cognoverant. His persuaderi ut diutius morarentur neque suis auxilium ferrent non poterat.
[11] Ea re constituta, secunda vigilia magno cum, strepitu ac tumultu castris egressi nullo certo ordine neque imperio, cum sibi quisque primum itineris locum peteret et domum pervenire properaret, fecerunt ut consimilis fugae profectio videretur. Hac re statim Caesar per speculatores cognita insidias veritus, quod qua de causa discederent nondum perspexerat, exercitum equitatumque castris continuit. Prima luce, confirmata re ab exploratoribus, omnem equitatum, qui novissimum agmen moraretur, praemisit. His Q. Pedium et L. Aurunculeium Cottam legatos praefecit; T. Labienum legatum cum legionibus tribus subsequi iussit. Hi novissimos adorti et multa milia passuum prosecuti magnam multitudinem eorum fugientium conciderunt, cum ab extremo agmine, ad quos ventum erat, consisterent fortiterque impetum nostrorum militum sustinerent, priores, quod abesse a periculo viderentur neque ulla necessitate neque imperio continerentur, exaudito clamore perturbatis ordinibus omnes in fuga sibi praesidium ponerent. Ita sine ullo periculo tantam eorum multitudinem nostri interfecerunt quantum fuit diei spatium; sub occasum solis sequi destiterunt seque in castra, ut erat imperatum, receperunt.
[12] Postridie eius diei Caesar, prius quam se hostes ex terrore ac fuga reciperent, in fines Suessionum, qui proximi Remis erant, exercitum duxit et magno itinere
[confecto] ad oppidum Noviodunum contendit. Id ex itinere oppugnare conatus, quod vacuum ab defensoribus esse audiebat, propter latitudinem fossae murique altitudinem paucis defendentibus expugnare non potuit. Castris munitis vineas agere quaeque ad oppugnandum usui erant comparare coepit. Interim omnis ex fuga Suessionum multitudo in oppidum proxima nocte convenit. Celeriter vineis ad oppidum actis, aggere iacto turribusque constitutis, magnitudine operum, quae neque viderant ante Galli neque audierant, et celeritate Romanorum permoti legatos ad Caesarem de deditione mittunt et petentibus Remis ut conservarentur impetrant.
[13] Caesar, obsidibus acceptis primis civitatis atque ipsius Galbae regis duobus filiis armisque omnibus ex oppido traditis, in deditionem Suessiones accipit exercitumque in Bellovacos ducit. Qui cum se suaque omnia in oppidum Bratuspantium contulissent atque ab eo oppido Caesar cum exercitu circiter milia passuum V abesset, omnes maiores natu ex oppido egressi manus ad Caesarem tendere et voce significare coeperunt sese in eius fidem ac potestatem venire neque contra populum Romanum armis contendere. Item, cum ad oppidum accessisset castraque ibi poneret, pueri mulieresque ex muro passis manibus suo more pacem ab Romanis petierunt.
[14] Pro his Diviciacus (nam post discessum Belgarum dimissis Haeduorum copiis ad eum reverterat) facit verba: Bellovacos omni tempore in fide atque amicitia civitatis Haeduae fuisse; impulsos ab suis principibus, qui dicerent Haeduos a Caesare in servitutem redacto. Omnes indignitates contumeliasque perferre, et ab Haeduis defecisse et populo Romano bellum intulisse. Qui eius consilii principes fuissent, quod intellegerent quantam calamitatem civitati intulissent, in Britanniam profugisse. Petere non solum Bellovacos, sed etiam pro his Haeduos, ut sua clementia ac mansuetudine in eos utatur. Quod si fecerit, Haeduorum auctoritatem apud omnes Belgas amplificaturum, quorum auxiliis atque opibus, si qua bella inciderint, sustentare consuerint.
[15] Caesar honoris Diviciaci atque Haeduorum causa sese eos in fidem recepturum et conservaturum dixit, et quod erat civitas magna inter Belgas auctoritate atque hominum multitudine praestabat, DC obsides poposcit. His traditis omnibusque armis ex oppido conlatis, ab eo loco in fines Ambianorum pervenit; qui se suaque omnia sine mora dediderunt. Eorum fines Nervii attingebant. Quorum de natura moribusque Caesar cum quaereret, sic reperiebat: nullum esse aditum ad eos mercatoribus; nihil pati vini reliquarumque rerum ad luxuriam pertinentium inferri, quod his rebus relanguescere animos eorum et remitti virtutem existimarent; esse homines feros magnaeque virtutis; increpitare atque incusare reliquos Belgas, qui se populo Romano dedidissent patriamque virtutem proiecissent; confirmare sese neque legatos missuros neque ullam condicionem pacis accepturos.
[16] Cum per eorum fines triduum iter fecisset, inveniebat ex captivis Sabim flumen a castris suis non amplius milibus passuum X abesse; trans id flumen omnes Nervios consedisse adventumque ibi Romanorum expectare una cum Atrebatibus et Viromanduis, finitimis suis (nam his utrisque persuaserant uti eandem belli fortunam experirentur); expectari etiam ab iis Atuatucorum copias atque esse in itinere; mulieres quique per aetatem ad pugnam inutiles viderentur in eum locum coniecisse quo propter paludes exercitui aditus non esset.
[17] His rebus cognitis, exploratores centurionesque praemittit qui locum castris idoneum deligant. Cum ex dediticiis Belgis reliquisque Gallis complures Caesarem secuti una iter facerent, quidam ex his, ut postea ex captivis cognitum est, eorum dierum consuetudine itineris nostri exercitus perspecta, nocte ad Nervios pervenerunt atque his demonstrarunt inter singulas legiones impedimentorum magnum numerum intercedere, neque esse quicquam negotii, cum prima legio in castra venisset reliquaeque legiones magnum spatium abessent, hanc sub sarcinis adoriri; qua pulsa impedimentisque direptis, futurum ut reliquae contra consistere non auderent. Adiuvabat etiam eorum consilium qui rem deferebant quod Nervii antiquitus, cum equitatu nihil possent (neque enim ad hoc tempus ei rei student, sed quicquid possunt, pedestribus valent copiis), quo facilius finitimorum equitatum, si praedandi causa ad eos venissent, impedirent, teneris arboribus incisis atque inflexis crebrisque in latitudinem ramis enatis
[et] rubis sentibusque interiectis effecerant ut instar muri hae saepes munimentum praeberent, quo non modo non intrari sed ne perspici quidem posset. His rebus cum iter agminis nostri impediretur, non omittendum sibi consilium Nervii existimaverunt.
[18] Loci natura erat haec, quem locum nostri castris delegerant. Collis ab summo aequaliter declivis ad flumen Sabim, quod supra nominavimus, vergebat. Ab eo flumine pari acclivitate collis nascebatur adversus huic et contrarius, passus circiter CC infimus apertus, ab superiore parte silvestris, ut non facile introrsus perspici posset. Intra eas silvas hostes in occulto sese continebant; in aperto loco secundum flumen paucae stationes equitum videbantur. Fluminis erat altitudo pedum circiter trium.
[19] Caesar equitatu praemisso subsequebatur omnibus copiis; sed ratio ordoque agminis aliter se habebat ac Belgae ad Nervios detulerant. Nam quod hostibus adpropinquabat, consuetudine sua Caesar VI legiones expeditas ducebat; post eas totius exercitus impedimenta conlocarat; inde duae legiones quae proxime conscriptae erant totum agmen claudebant praesidioque impedimentis erant. Equites nostri cum funditoribus sagittariisque flumen transgressi cum hostium equitatu proelium commiserunt. Cum se illi identidem in silvis ad suos reciperent ac rursus ex silva in nostros impetum facerent, neque nostri longius quam quem ad finem porrecta
[ac] loca aperta pertinebant cedentes insequi auderent, interim legiones VI quae primae venerant, opere dimenso, castra munire coeperunt. Ubi prima impedimenta nostri exercitus ab iis qui in silvis abditi latebant visa sunt, quod tempus inter eos committendi proelii convenerat, ut intra silvas aciem ordinesque constituerant atque ipsi sese confirmaverant, subito omnibus copiis provolaverunt impetumque in nostros equites fecerunt. His facile pulsis ac proturbatis, incredibili celeritate ad flumen decucurrerunt, ut paene uno tempore et ad silvas et in flumine
[et iam in manibus nostris] hostes viderentur. Eadem autem celeritate adverso colle ad nostra castra atque eos qui in opere occupati erant contenderunt.
[20] Caesari omnia uno tempore erant agenda: vexillum proponendum, quod erat insigne, cum ad arma concurri oporteret; signum tuba dandum; ab opere revocandi milites; qui paulo longius aggeris petendi causa processerant arcessendi; acies instruenda; milites cohortandi; signum dandum. Quarum rerum magnam partem temporis brevitas et incursus hostium impediebat. His difficultatibus duae res erant subsidio, scientia atque usus militum, quod superioribus proeliis exercitati quid fieri oporteret non minus commode ipsi sibi praescribere quam ab aliis doceri poterant, et quod ab opere singulisque legionibus singulos legatos Caesar discedere nisi munitis castris vetuerat. Hi propter propinquitatem et celeritatem hostium nihil iam Caesaris imperium expectabant, sed per se quae videbantur administrabant.
[21] Caesar, necessariis rebus imperatis, ad cohortandos milites, quam
[in] partem fors obtulit, decucurrit et ad legionem decimam devenit. Milites non longiore oratione cohortatus quam uti suae pristinae virtutis memoriam retinerent neu perturbarentur animo hostiumque impetum fortiter sustinerent, quod non longius hostes aberant quam quo telum adigi posset, proelii committendi signum dedit. Atque in alteram item cohortandi causa profectus pugnantibus occurrit. Temporis tanta fuit exiguitas hostiumque tam paratus ad dimicandum animus ut non modo ad insignia accommodanda sed etiam ad galeas induendas scutisque tegimenta detrahenda tempus defuerit. Quam quisque ab opere in partem casu devenit quaeque prima signa conspexit, ad haec constitit, ne in quaerendis suis pugnandi tempus dimitteret.
[22] Instructo exercitu magis ut loci natura
[deiectusque collis] et necessitas temporis quam ut rei militaris ratio atque ordo postulabat, cum diversae legiones aliae alia in parte hostibus resisterent saepibusque densissimis, ut ante demonstravimus, interiectis prospectus impediretur, neque certa subsidia conlocari neque quid in quaque parte opus esset provideri neque ab uno omnia imperia administrari poterant. Itaque in tanta rerum iniquitate fortunae quoque eventus varii sequebantur.
[23] Legionis VIIII. et X. milites, ut in sinistra parte aciei constiterant, pilis emissis cursu ac lassitudine exanimatos vulneribusque confectos Atrebates (nam his ea pars obvenerat) celeriter ex loco superiore in flumen compulerunt et transire conantes insecuti gladiis magnam partem eorum impeditam interfecerunt. Ipsi transire flumen non dubitaverunt et in locum iniquum progressi rursus resistentes hostes redintegrato proelio in fugam coniecerunt. Item alia in parte diversae duae legiones, XI. et VIII., profligatis Viromanduis, quibuscum erant congressae, ex loco superiore in ipsis fluminis ripis proeliabantur. At totis fere castris a fronte et a sinistra parte nudatis, cum in dextro cornu legio XII. et non magno ab ea intervallo VII. constitisset, omnes Nervii confertissimo agmine duce Boduognato, qui summam imperii tenebat, ad eum locum contenderunt; quorum pars ab aperto latere legiones circumvenire, pars summum castrorum locum petere coepit.
[24] Eodem tempore equites nostri levisque armaturae pedites, qui cum iis una fuerant, quos primo hostium impetu pulsos dixeram, cum se in castra reciperent, adversis hostibus occurrebant ac rursus aliam in partem fugam petebant; et calones, qui ab decumana porta ac summo iugo collis nostros victores flumen transire conspexerant, praedandi causa egressi, cum respexissent et hostes in nostris castris versari vidissent, praecipites fugae sese mandabant. Simul eorum qui cum impedimentis veniebant clamor fremitusque oriebatur, aliique aliam in partem perterriti ferebantur. Quibus omnibus rebus permoti equites Treveri, quorum inter Gallos virtutis opinio est singularis, qui auxilii causa a civitate missi ad Caesarem venerant, cum multitudine hostium castra
[nostra] compleri, legiones premi et paene circumventas teneri, calones, equites, funditores, Numidas diversos dissipatosque in omnes partes fugere vidissent, desperatis nostris rebus domum contenderunt: Romanos pulsos superatosque, castris impedimentisque eorum hostes potitos civitati renuntiaverunt.
[25] Caesar ab X. legionis cohortatione ad dextrum cornu profectus, ubi suos urgeri signisque in unum locum conlatis XII. legionis confertos milites sibi ipsos ad pugnam esse impedimento vidit, quartae cohortis omnibus centurionibus occisis signiferoque interfecto, signo amisso, reliquarum cohortium omnibus fere centurionibus aut vulneratis aut occisis, in his primipilo P. Sextio Baculo, fortissimo viro, multis gravibusque vulneribus confecto, ut iam se sustinere non posset, reliquos esse tardiores et non nullos ab novissimis deserto loco proelio excedere ac tela vitare, hostes neque a fronte ex inferiore loco subeuntes intermittere et ab utroque latere instare et rem esse in angusto vidit, neque ullum esse subsidium quod submitti posset, scuto ab novissimis
[uni] militi detracto, quod ipse eo sine scuto venerat, in primam aciem processit centurionibusque nominatim appellatis reliquos cohortatus milites signa inferre et manipulos laxare iussit, quo facilius gladiis uti possent. Cuius adventu spe inlata militibus ac redintegrato animo, cum pro se quisque in conspectu imperatoris etiam in extremis suis rebus operam navare cuperet, paulum hostium impetus tardatus est.
[26] Caesar, cum VII. legionem, quae iuxta constiterat, item urgeri ab hoste vidisset, tribunos militum monuit ut paulatim sese legiones coniungerent et conversa signa in hostes inferrent. Quo facto cum aliis alii subsidium ferrent neque timerent ne aversi ab hoste circumvenirentur, audacius resistere ac fortius pugnare coeperunt. Interim milites legionum duarum quae in novissimo agmine praesidio impedimentis fuerant, proelio nuntiato, cursu incitato in summo colle ab hostibus conspiciebantur, et T.Labienus castris hostium potitus et ex loco superiore quae res in nostris castris gererentur conspicatus X.legionem subsidio nostris misit. Qui cum ex equitum et calonum fuga quo in loco res esset quantoque in periculo et castra et legiones et imperator versaretur cognovissent, nihil ad celeritatem sibi reliqui fecerunt.
[27] Horum adventu tanta rerum commutatio est facta ut nostri, etiam qui vulneribus confecti procubuissent, scutis innixi proelium redintegrarent, calones perterritos hostes conspicati etiam inermes armatis occurrerent, equites vero, ut turpitudinem fugae virtute delerent, omnibus in locis pugnae se legionariis militibus praeferrent. At hostes, etiam in extrema spe salutis, tantam virtutem praestiterunt ut, cum primi eorum cecidissent, proximi iacentibus insisterent atque ex eorum corporibus pugnarent, his deiectis et coacervatis cadaveribus qui superessent ut ex tumulo tela in nostros conicerent et pila intercepta remitterent: ut non nequiquam tantae virtutis homines iudicari deberet ausos esse transire latissimum flumen, ascendere altissimas ripas, subire iniquissimum locum; quae facilia ex difficillimis animi magnitudo redegerat.
[28] Hoc proelio facto et prope ad internecionem gente ac nomine Nerviorum redacto, maiores natu, quos una cum pueris mulieribusque in aestuaria ac paludes coniectos dixeramus, hac pugna nuntiata, cum victoribus nihil impeditum, victis nihil tutum arbitrarentur, omnium qui supererant consensu legatos ad Caesarem miserunt seque ei dediderunt; et in commemoranda civitatis calamitate ex DC ad tres senatores, ex hominum milibus LX vix ad D, qui arma ferre possent, sese redactos esse dixerunt. Quos Caesar, ut in miseros ac supplices usus misericordia videretur, diligentissime conservavit suisque finibus atque oppidis uti iussit et finitimis imperavit ut ab iniuria et maleficio se suosque prohiberent.
[29] Atuatuci, de quibus supra diximus, cum omnibus copiis auxilio Nerviis venirent, hac pugna nuntiata ex itinere domum reverterunt; cunctis oppidis castellisque desertis sua omnia in unum oppidum egregie natura munitum contulerunt. Quod cum ex omnibus in circuitu partibus altissimas rupes deiectusque haberet, una ex parte leniter acclivis aditus in latitudinem non amplius pedum CC relinquebatur; quem locum duplici altissimo muro munierant; tum magni ponderis saxa et praeacutas trabes in muro conlocabant. Ipsi erant ex Cimbris Teutonisque prognati, qui, cum iter in provinciam nostram atque Italiam facerent, iis impedimentis quae secum agere ac portare non poterant citra flumen Rhenum depositis custodiam
[ex suis] ac praesidium VI milia hominum una reliquerant. Hi post eorum obitum multos annos a finitimis exagitati, cum alias bellum inferrent, alias inlatum defenderent, consensu eorum omnium pace facta hunc sibi domicilio locum delegerant.
[30] Ac primo adventu exercitus nostri crebras ex oppido excursiones faciebant parvulisque proeliis cum nostris contendebant; postea vallo pedum XII in circuitu quindecim milium crebrisque castellis circummuniti oppido sese continebant. Ubi vineis actis aggere extructo turrim procul constitui viderunt, primum inridere ex muro atque increpitare vocibus, quod tanta machinatio a tanto spatio institueretur: quibusnam manibus aut quibus viribus praesertim homines tantulae staturae (nam plerumque omnibus Gallis prae magnitudine corporum quorum brevitas nostra contemptui est) tanti oneris turrim in muro sese posse conlocare confiderent?
[31] Ubi vero moveri et adpropinquare muris viderunt, nova atque inusitata specie commoti legatos ad Caesarem de pace miserunt, qui ad hunc modum locuti; non se existimare Romanos sine ope divina bellum gerere, qui tantae altitudinis machinationes tanta celeritate promovere possent; se suaque omnia eorum potestati permittere dixerunt. Unum petere ac deprecari: si forte pro sua clementia ac mansuetudine, quam ipsi ab aliis audirent, statuisset Atuatucos esse conservandos, ne se armis despoliaret. Sibi omnes fere finitimos esse inimicos ac suae virtuti invidere; a quibus se defendere traditis armis non possent. Sibi praestare, si in eum casum deducerentur, quamvis fortunam a populo Romano pati quam ab his per cruciatum interfici inter quos dominari consuessent.
[32]Ad haec Caesar respondit: se magis consuetudine sua quam merito eorum civitatem conservaturum, si prius quam murum aries attigisset se dedidissent; sed deditionis nullam esse condicionem nisi armis traditis. Se id quod in Nerviis fecisset facturum finitimisque imperaturum ne quam dediticiis populi Romani iniuriam inferrent. Re renuntiata ad suos illi se quae imperarentur facere dixerunt. Armorum magna multitudine de muro in fossam, quae erat ante oppidum, iacta, sic ut prope summam muri aggerisque altitudinem acervi armorum adaequarent, et tamen circiter parte tertia, ut postea perspectum est, celata atque in oppido retenta, portis patefactis eo die pace sunt usi.
[33] Sub vesperum Caesar portas claudi militesque ex oppido exire iussit, ne quam noctu oppidani a militibus iniuriam acciperent. Illi ante inito, ut intellectum est, consilio, quod deditione facta nostros praesidia deducturos aut denique indiligentius servaturos crediderant, partim cum iis quae retinuerant et celaverant armis, partim scutis ex cortice factis aut viminibus intextis, quae subito, ut temporis exiguitas postulabat, pellibus induxerant, tertia vigilia, qua minime arduus ad nostras munitiones accensus videbatur, omnibus copiis repente ex oppido eruptionem fecerunt. Celeriter, ut ante Caesar imperaverat, ignibus significatione facta, ex proximis castellis eo concursum est, pugnatumque ab hostibus ita acriter est ut a viris fortibus in extrema spe salutis iniquo loco contra eos qui ex vallo turribusque tela iacerent pugnari debuit, cum in una virtute omnis spes consisteret. Occisis ad hominum milibus IIII reliqui in oppidum reiecti sunt. Postridie eius diei refractis portis, cum iam defenderet nemo, atque intromissis militibus nostris, sectionem eius oppidi universam Caesar vendidit. Ab iis qui emerant capitum numerus ad eum relatus est milium LIII.
[34] Eodem tempore a P. Crasso, quem cum legione una miserat ad Venetos, Venellos, Osismos, Coriosolitas, Esuvios, Aulercos, Redones, quae sunt maritimae civitates Oceanumque attingunt, certior factus est omnes eas civitates in dicionem potestatemque populi Romani esse redactas.
[35] His rebus gestis omni Gallia pacata, tanta huius belli ad barbaros opinio perlata est uti ab iis nationibus quae trans Rhenum incolerent legationes ad Caesarem mitterentur, quae se obsides daturas, imperata facturas pollicerentur. Quas legationes Caesar, quod in Italiam Illyricumque properabat, inita proxima aestate ad se reverti iussit. Ipse in Carnutes, Andes, Turonos quaeque civitates propinquae iis locis erant ubi bellum gesserat, legionibus in hiberna deductis, in Italiam profectus est. Ob easque res ex litteris Caesaris dierum XV supplicatio decreta est, quod ante id tempus accidit nulli. |
LIBRO SECONDO
[1
Mentre Cesare si trovava in Gallia cisalpina e le legioni erano state
dislocate - lo si è visto sopra - negli accampamenti invernali, di
frequente gli giungevano delle voci, confermate anche da una lettera di
Labieno: tutti i Belgi, che rappresentano, come abbiamo detto, una delle
tre parti della Gallia, stavano formando una lega contro il popolo romano
e si scambiavano ostaggi. I motivi dell'alleanza erano i seguenti. Primo,
temevano che il nostro esercito, una volta sottomessa la Gallia, li
attaccasse. Secondo, ricevevano le pressioni intanto di parecchi Galli
(c'era chi non aveva voluto la presenza dei Germani in Gallia e,
naturalmente, mal sopportava che l'esercito romano svernasse e si
impiantasse nel loro paese e c'era chi, instabile e volubile d'animo,
auspicava rivolgimenti politici) e poi di molti altri: in tutta la Gallia
generalmente i regni erano nelle mani di chi aveva più potere e disponeva
dei mezzi per assoldare un esercito, e costoro, sotto il nostro dominio,
non riuscivano così facilmente a raggiungere i loro scopi.
[2
Le notizie e la lettera di Labieno spinsero Cesare ad arruolare in Gallia
cisalpina due nuove legioni, e il legato Q. Pedio, all'inizio dell'estate,
ricevette l'incarico di condurle in Gallia transalpina. Cesare stesso
raggiunse l'esercito non appena cominciò a esservi foraggio a sufficienza.
Ai Senoni e agli altri Galli confinanti con i Belgi diede incarico di
informarsi e di comunicargli che cosa i Belgi stessero preparando. Tutti,
concordemente, gli riferirono che erano in corso reclutamenti e che le
truppe venivano concentrate in un sol luogo. Solo allora Cesare ritenne
che non c'era da esitare a muovere contro di loro. Preparate le scorte di
grano, toglie le tende e in circa quindici giorni giunge nella regione dei
Belgi.
[3
Il suo arrivo fu improvviso e più rapido di ogni previsione. I Remi, il
popolo belga più vicino alla Gallia, gli inviarono in veste di
ambasciatori Iccio e Andocumborio, i più insigni tra i cittadini: si
ponevano con tutti i loro beni sotto la protezione e l'autorità del popolo
romano; non avevano condiviso i sentimenti degli altri Belgi, né aderito
alla lega contro Roma; erano pronti a consegnare ostaggi, a eseguire gli
ordini, ad accogliere i soldati romani nelle loro città. a rifornirli di
grano e di tutto il necessario; gli altri Belgi erano già in armi e a essi
si erano uniti i Germani stanziati al di qua dei Reno; li aveva presi
tutti una smania e follia tale, che i Remi non erano riusciti a dissuadere
neanche i Suessioni, dei fratelli, dei consanguinei: eppure avevano in
comune leggi e diritto, dipendevano da un unico comandante militare e
magistrato civile.
[4
Cesare chiese ai Remi quanti e quali popoli si trovassero in armi e quanto
valessero in guerra. Ecco che cosa seppe: la maggior parte dei Belgi
discendeva dai Germani; anticamente avevano varcato il Reno attratti dalla
fertilità della regione e l'avevano occupata, scacciando i Galli che
l'abitavano; all'epoca dei nostri padri erano stati gli unici a impedire
ai Cimbri e ai Teutoni, che avevano messo a ferro e fuoco tutta la Gallia,
di penetrare nei loro territori; perciò, memori di tale impresa, i Belgi
si attribuivano un'enorme importanza ed erano molto fieri della loro forza
militare. Circa il numero dei partecipanti alla lega, i Remi sostenevano
di avere tutti dati sicuri, perché grazie ai legami di vicinanza e
parentela sapevano quanti uomini ciascun popolo avesse promesso per la
guerra nell'assemblea generale dei Belgi. I più potenti per valore,
prestigio e numero erano i Bellovaci, in grado di mettere insieme un
esercito di centomila uomini; ne avevano promessi sessantamila scelti e
chiedevano il comando supremo delle operazioni. Loro confinanti erano i
Suessioni, che possedevano territori molto estesi e fertili. Fu loro re,
anche ai nostri giorni, Diviziaco, il sovrano più potente di tutta la
Gallia, sotto il cui dominio erano cadute molte regioni del paese e,
addirittura, la Britannia; ora regnava Galba: a lui, uomo giusto e saggio,
era stato conferito il comando supremo per unanime consenso; le loro città
erano dodici ed essi si erano impegnati a fornire cinquantamila uomini,
come pure i Nervi, che tra i Belgi erano i più lontani e avevano fama di
essere i più indomiti; gli Atrebati ne avevano promesso quindicimila, gli
Ambiani diecimila, i Morini venticinquemila, i Menapi settemila, i Caleti
diecimila, altrettanti i Veliocassi e i Viromandui, gli Atuatuci
diciannovemila; inoltre, si pensava che i Condrusi, gli Eburoni, i Cerosi
e i Pemani, complessivamente designati con il nome di Germani, avrebbero
fornito circa quarantamila soldati.
[5
Cesare incoraggiò i Remi e rivolse loro parole di benevolenza. Ordinò che
tutti i senatori si recassero da lui e che gli fossero consegnati in
ostaggio i figli dei più nobili. Tutte le sue disposizioni vennero
puntualmente eseguite nel giorno fissato. Cesare moltiplicò le pressioni
sull'eduo Diviziaco, spiegandogli quanto fosse vitale, per la repubblica e
l'interesse di tutti, tenere divise le forze nemiche, per non dover
affrontare in un solo scontro un esercito così numeroso. E ciò era
possibile se gli Edui avessero invaso i territori dei Bellovaci,
incominciando a devastarli. Affidatogli tale incarico, lo congedò. Quando
vide che tutte le truppe dei Belgi, concentrate in un unico luogo,
muovevano contro di lui e apprese, su informazione dei Remi e degli
esploratori inviati, che i nemici erano ormai vicini, si affrettò a
tradurre l'esercito al di là del fiume Aisne, che si trova nei più lontani
territori dei Remi, e qui si attestò. Così difendeva un lato
dell'accampamento per mezzo della riva del fiume, metteva al riparo dai
nemici la zona alle sue spalle e garantiva la sicurezza dei rifornimenti
inviati dai Remi e dagli altri popoli. Sul fiume c'era un ponte. Su una
sponda pone un presidio e lascia, sull'altra, il legato Q. Titurio Sabino
con sei coorti. Dà ordine di fortificare l'accampamento con un vallo di
dodici piedi d'altezza e una fossa larga diciotto.
[6
A otto miglia di distanza dall'accampamento sorgeva una città dei Remi,
chiamata Bibrax. Appena giunti sul posto, i Belgi cominciarono a
stringerla d'assedio con accanimento. Per quel giorno la città, a stento,
resistette. I Belgi usano la stessa tecnica di assedio dei Galli:
circondano il perimetro delle mura con un gran numero di uomini e da ogni
parte iniziano a lanciare pietre, costringendo i difensori ad abbandonare
i propri posti; poi formano la testuggine, incendiano le porte e abbattono
le mura. E a Bibrax una tale tecnica era facilmente attuabile: gli
attaccanti che scagliavano pietre e dardi erano così numerosi, che nessuno
dei difensori poteva rimanere sulle mura. L'arrivo della notte costrinse i
Belgi a interrompere l'assedio. Il Remo Iccio, persona di nobilissima
stirpe, che godeva di molta influenza tra i suoi e all'epoca era capo
della città, inviò a Cesare un messo, uno degli ambasciatori già mandati
per chiedere la pace: se non gli pervenivano aiuti da Cesare, non era in
grado di resistere più a lungo.
[7
Cesare, nel cuore della notte, di rinforzo agli abitanti manda truppe
della Numidia, arcieri cretesi e frombolieri delle Baleari, sotto la guida
dei messi inviati da Iccio. L'arrivo dei Romani riaccese le speranze dei
difensori e la loro voglia di combattere, mentre per lo stesso motivo gli
assedianti disperarono di poter prendere Bibrax. Perciò, rimasero per un
certo periodo nei pressi della città, devastando i campi dei Remi e
incendiando tutti i villaggi e gli edifici che avevano potuto raggiungere,
poi, al gran completo, puntarono sul campo di Cesare e posero le tende a
meno di due miglia di distanza. Il loro accampamento, a giudicare dal fumo
e dai fuochi accesi, si estendeva per più di otto miglia.
[8
In un primo tempo, considerando sia il numero dei nemici, sia la loro fama
di soldati estremamente valorosi, Cesare decise di evitare lo scontro
aperto. Ogni giorno, però, con attacchi di cavalleria saggiava il valore
dei nemici e il coraggio dei Romani. Si rese conto che i nostri non erano
inferiori. Il terreno di fronte all'accampamento era vantaggioso e adatto
per schierare l'esercito, perché il colle su cui si trovava il nostro
campo sovrastava leggermente la pianura, si estendeva per uno spazio
equivalente a quello che poteva occupare l'esercito in formazione da
combattimento, aveva entrambi i fianchi scoscesi e la cima arrotondata,
che digradava dolcemente verso la pianura. Perciò ordinò di scavare, alla
base di entrambi i fianchi del colle, due fosse trasversali di circa
quattrocento passi, in cima alle quali comandò di costruire ridotte e
collocare macchine da lancio: voleva evitare che, una volta dispiegate le
truppe, i nostri durante la battaglia venissero aggirati dal nemico, che
era così numeroso. Attuate tali disposizioni, lasciò nell'accampamento,
pronte a intervenire in caso di necessità, le due legioni arruolate per
ultime e schierò di fronte al campo le altre sei. Allo stesso modo i
nemici fecero uscire le loro truppe e le disposero per lo scontro.
[9
Tra il nostro esercito e il nemico c'era una palude non molto estesa. I
Belgi aspettavano i Romani al varco; i nostri, invece, si tenevano armati,
pronti ad assalire il nemico in difficoltà, se avesse tentato per primo il
passaggio. Nel frattempo, le cavallerie dei due eserciti si scontravano.
Nessuno osò attraversare per primo il fiume, perciò, dopo che i nostri
cavalieri ebbero la meglio, Cesare ricondusse i suoi nell'accampamento. I
nemici si diressero immediatamente al fiume Aisne, che scorreva - lo si è
già detto - dietro il nostro campo. Trovati alcuni guadi, tentarono di
tradurre sull'altra sponda parte delle truppe. La loro intenzione era, nel
migliore dei casi, di espugnare la ridotta comandata dal legato Q. Titurio
e di distruggere il ponte, altrimenti di devastare i campi dei Remi, che
per noi erano di vitale importanza al fine di proseguire la guerra, e di
tagliarci i rifornimenti.
[10
Cesare, informato della situazione da Titurio, portò tutta la cavalleria,
i Numidi armati alla leggera, i frombolieri e gli arcieri al di là del
ponte e marciò contro il nemico. Lo scontro fu violento. I nostri li
assalirono mentre stavano attraversando il fiume ed erano in difficoltà.
Ne uccisero la maggior parte e respinsero con un nugolo di frecce gli
altri che, con estrema audacia, tentavano di passare sui corpi dei caduti,
circondarono con la cavalleria e uccisero i primi giunti sull'altra
sponda. I nemici si resero conto di non aver più speranze di espugnare la
città, né di attraversare il fiume e videro che i nostri non avanzavano,
per dare battaglia, su un terreno sfavorevole. Perciò, dato che anche le
loro scorte di grano incominciavano a scarseggiare, convocarono
l'assemblea e decisero che la cosa migliore era tornare tutti in patria.
Sarebbero accorsi in difesa del primo popolo attaccato dai Romani: così
avrebbero combattuto nei propri territori, non in quelli altrui, e si
sarebbero serviti delle scorte di grano che avevano in patria. Giunsero a
tale decisione, tra l'altro, perché avevano saputo che Diviziaco e gli
Edui si stavano avvicinando ai territori dei Bellovaci. E non si poteva
convincere questi ultimi ad attardarsi e a non soccorrere i loro.
[11
Presa la decisione, prima di mezzanotte i Belgi lasciarono l'accampamento
con grande strepito e tumulto, senza seguire ordini precisi o comandanti.
Ognuno voleva raggiungere la testa della colonna e si affrettava a
rientrare in patria, tanto che la loro partenza sembrava piuttosto una
fuga. Gli osservatori riferirono immediatamente il fatto a Cesare, ma
egli, temendo una trappola, poiché non aveva ancora capito il motivo della
loro partenza, trattenne l'esercito e la cavalleria nell'accampamento.
All'alba, quando gli esploratori confermarono la notizia, Cesare mandò in
avanti tutta la cavalleria agli ordini dei legati Q. Pedio e L.
Aurunculeio Cotta, col compito di ostacolare la retroguardia nemica.
Ordinò al legato T. Labieno di seguirli con tre legioni. I soldati romani
assalirono la retroguardia avversaria e protrassero l'inseguimento per
molte miglia, facendo strage dei Belgi in fuga. Gli ultimi della colonna
nemica, raggiunti, si fermarono e ressero con vigore all'urto dei nostri;
i primi, invece, ritenendosi fuori pericolo e non essendo trattenuti né
dalla necessità, né da comandanti, non appena udirono i clamori della
battaglia, ruppero l'ordine di marcia e si diedero tutti alla fuga,
cercando di salvarsi. Così, senza correre alcun pericolo, i nostri
uccisero tanti nemici, quanti ne consentì la durata del giorno. Al
tramonto posero fine al loro inseguimento e, secondo gli ordini ricevuti,
rientrarono all'accampamento.
[12
L'indomani, prima che i nemici potessero riaversi dal terrore e dallo
scompiglio della fuga, Cesare condusse l'esercito nei territori dei
Suessioni, al confine con i Remi, giungendo a marce forzate alla città di
Novioduno. Appena giunto sul posto, tentò di espugnarla, perché si diceva
che era sguarnita, ma la larghezza del fossato e l'altezza delle mura non
gli permisero di impadronirsene, nonostante che i difensori fossero
realmente pochi. Forfificato l'accampamento, provvide a spingere in avanti
le vinee e a preparare tutto ciò che serve ad un assedio. Nel frattempo,
la notte successiva rientrarono in città tutti i Suessioni che si erano
dati alla fuga. Vedendo che i Romani rapidamente accostavano le vinee,
innalzavano un terrapieno e costruivano delle torri, i Suessioni, scossi
sia dall'imponenza delle opere costruite, mai viste o di cui non avevano
mai sentito parlare prima, sia dalla rapidità dei Romani, mandano a Cesare
un'ambasceria per offrire la resa. Su richiesta dei Remi, ottengono salva
la vita.
[13
Cesare, ricevuti in ostaggio i cittadini più nobili, tra cui due figli del
re Galba stesso, dopo la consegna di tutte le armi che vi erano in città,
accettò la resa dei Suessioni e guidò l'esercito contro i Bellovaci,
asserragliati con tutti i loro beni nella città di Bratuspanzio. Quando
Cesare e le sue legioni distavano circa cinque miglia, tutti i più anziani
uscirono dalla città e iniziarono a esprimere, a parole e con le mani
protese verso Cesare, l'intenzione di porsi sotto la sua protezione e
autorità e di non combattere contro il popolo romano. Allo stesso modo,
quando Cesare si era avvicinato alla città e poneva le tende, dall'alto
delle mura i bambini e le donne, con le mani protese, secondo il loro
costume, chiedevano pace ai Romani.
[14
In loro favore parlò Diviziaco, che dopo la ritirata dei Belgi aveva
rimandato in patria le truppe edue e raggiunto Cesare: i Bellovaci in ogni
circostanza si erano dimostrati alleati e amici degli Edui; a spingere il
popolo erano stati i capi con i loro discorsi, sostenendo che gli Edui,
ridotti in servitù da Cesare, subivano umiliazioni e offese di ogni sorta;
perciò, si erano staccati dagli Edui e avevano dichiarato guerra al popolo
romano. I responsabili della decisione, consapevoli del danno provocato
alla loro gente, erano fuggiti in Britannia. Alle preghiere dei Bellovaci,
che chiedevano a Cesare clemenza e generosità, si aggiungeva
l'intercessione degli Edui. E se Cesare avesse risparmiato i Bellovaci,
avrebbe accresciuto l'autorità degli Edui presso tutti i Belgi, che erano
soliti fornire, in caso di guerra, truppe e mezzi per farvi fronte.
[15
Cesare disse che, per aumentare il prestigio di Diviziaco e degli Edui,
avrebbe accolto e tenuto sotto la sua protezione i Bellovaci. Poiché erano
un popolo di grande autorità tra i Belgi e molto numerosi, chiese seicento
ostaggi. Gli furono consegnati insieme a tutte le armi della città. Da lì
passò nella regione degli Ambiani, che senza indugio si posero con tutti i
loro beni sotto la sua autorità. Gli Ambiani confinavano con i Nervi.
Cesare prese informazioni sul carattere e sui costumi di quest'ultimi e
seppe quanto segue: i mercanti non avevano alcun accesso e i Nervi non
permettevano che si introducessero vino o altri prodotti di lusso, perché
ritenevano che indebolissero gli animi e diminuissero la loro forza; gente
rude e molto valorosa, accusavano duramente gli altri Belgi di essersi
arresi al popolo romano e di aver rinnegato la virtù dei padri;
assicuravano che non avrebbero inviato ambascerie. né accettato la pace, a
nessuna condizione.
[16
Cesare, dopo tre giorni di marcia nella regione dei Nervi, veniva a sapere
dai prigionieri che il fiume Sambre non distava più di dieci miglia dal
suo accampamento: al di là del fiume si erano attestati tutti i Nervi e
aspettavano l'arrivo dei Romani insieme agli Atrebati e ai Viromandui,
loro confinanti (li avevano persuasi, infatti, a tentare la stessa sorte
in guerra); attendevano anche le truppe degli Atuatuci, che erano in
marcia; le donne e chi, per ragioni d'età, non poteva essere impiegato in
guerra, erano stati ammassati in un luogo che le paludi rendevano
inaccessibile a un esercito.
[17
Avute tali informazioni, mandò in avanscoperta alcuni esploratori e
centurioni con l'incarico di scegliere una zona adatta per accamparsi. Al
seguito di Cesare c'erano parecchi Belgi che avevano giurato sottomissione
e altri Galli. Alcuni di essi, come si seppe in seguito dai prigionieri,
dopo aver osservato l'ordine di marcia fin lì tenuto dal nostro esercito,
di notte raggiunsero i Nervi e riferirono che tra le singole legioni
procedeva un gran numero di salmerie, per cui non era affatto difficile
assalire la prima legione non appena fosse giunta al campo, mentre le
altre erano lontane e i soldati ancora impacciati dagli zaini. Una volta
messa in fuga la prima legione e saccheggiate le salmerie, le rimanenti
legioni non avrebbero osato opporre resistenza. Un altro elemento giocava
a favore del piano degli informatori: fin dai tempi più antichi i Nervi
non avevano contingenti di cavalleria (neppure ai giorni nostri si
preoccupano di averne, ma tutta la loro forza risiede nella fanteria);
così, per ostacolare, in caso di razzia, i cavalieri dei popoli limitrofi,
incidevano gli alberi ancora giovani e li piegavano, costringendo i rami a
crescere, fitti, in senso orizzontale; tra gli alberi, poi, piantavano
rovi e arbusti spinosi in modo che le siepi formassero una barriera simile
a un muro, impedendo non solo il passaggio, ma anche la vista. Dato che il
nostro esercito avrebbe trovato sulla sua strada tali ostacoli, i Nervi
ritennero di non dover scartare il piano proposto.
[18
La conformazione naturale del luogo, scelto dai nostri per l'accampamento,
era la seguente: un colle, che digradava in modo uniforme, scendeva fino
alla Sambre, fiume di cui abbiamo già fatto cenno. Sulla riva opposta,
proprio di fronte, sorgeva un altro colle che aveva identica pendenza: in
basso, per un tratto di circa duecento passi, era brullo, mentre sulla
cima aveva fitti boschi, impenetrabili alla vista. Qui i nemici si
tenevano nascosti; nella zona senza vegetazione, lungo il fiume, si
vedevano poche squadre di cavalleria. La profondità del fiume era di circa
tre piedi.
[19
Cesare, mandata in avanti la cavalleria, la seguiva con tutte le truppe.
La disposizione e l'ordine di marcia, però, erano diversi da quelli che i
Belgi avevano riferito ai Nervi. Infatti, trovandosi in prossimità del
nemico, Cesare, secondo la sua abitudine, faceva avanzare libere da
carichi le sei legioni, ponendo dietro di esse i bagagli di tutto
l'esercito; le due legioni di recente arruolate chiudevano lo schieramento
e presidiavano le salmerie. La nostra cavalleria, insieme ai frombolieri e
agli arcieri, attraversò il fiume e si scontrò con i cavalieri avversari.
I nemici sistematicamente si ritiravano nei boschi presso i loro e, da lì,
attaccavano i nostri, che non osavano inseguire i fuggitivi oltre il
limite segnato dalla zona pianeggiante e senza vegetazione. Nel frattempo,
le sei legioni che erano in testa, tracciato lo spazio, iniziarono a
fortificare il campo. I nemici, nascosti nelle selve, avevano già formato
le linee di attacco e le file, spronandosi alla lotta: non appena videro i
primi carri del nostro esercito - era il segnale convenuto per l'attacco -
in massa si lanciarono in avanti e puntarono contro i nostri cavalieri. Li
volsero in fuga e dispersero con facilità, poi scesero di corsa verso il
fiume, velocissimi: sembrava quasi che fossero, nello stesso istante, sul
limitare dei boschi, nel fiume e già addosso ai nostri. Poi, con
altrettanta rapidità, salirono il colle opposto dirigendosi contro il
nostro accampamento e i legionari intenti ai lavori di fortificazione.
[20
Cesare si trovò a dover far tutto contemporaneamente: inalberare il
vessillo, con cui si dava l'avviso di correre alle armi, ordinare gli
squilli di tromba, richiamare i soldati dai lavori, comandare il rientro
ai legionari che si erano un po' allontanati in cerca di materiale,
formare la linea di combattimento, esortare i soldati e dare il segnale
d'attacco. La mancanza di tempo e l'incalzare dei nemici impedivano di
eseguire la maggior parte delle suddette operazioni. A fronte di tali
difficoltà due fattori erano d'aiuto: primo, la perizia e l'esperienza dei
nostri soldati, che, addestrati dalle precedenti battaglie, erano in grado
di imporsi da soli la condotta necessaria non meno tranquillamente che se
avessero ricevuto precise istruzioni da altri; secondo, l'obbligo imposto
da Cesare ai vari legati di non allontanarsi dalla propria legione prima
del termine dei lavori. I legati, vista la vicinanza e la rapidità dei
nemici, non stettero ad aspettare ordini da Cesare, ma prendevano
personalmente le disposizioni che ritenevano opportune.
[21
Cesare, impartiti gli ordini necessari, corse a spronare i soldati,
guidato dal caso: capitò dalla decima legione. Si limitò a incitare i
soldati a ricordarsi dell'antico valore, a non lasciarsi turbare, a
reggere con vigore all'assalto nemico. Dato che i Nervi erano quasi a tiro
e i nostri potevano colpirli con le frecce, diede il segnale d'attacco. E
poi si precipitò in un'altra direzione, sempre con lo scopo di
incoraggiare i soldati, ma li trovò che stavano già combattendo. Il tempo
fu talmente breve e i nemici così risoluti che i nostri non riuscirono non
solo ad applicare i fregi, ma neppure a mettersi in testa gli elmi o a
togliere le fodere dagli scudi. Chi tornava dai lavori si fermò dove
capitava, presso le prime insegne che vide, per non perdere tempo alla
ricerca della sua unità di appartenenza.
[22
L'esercito fu schierato tenendo presente non tanto i dettami della tecnica
militare, quanto la conformazione naturale del luogo, il pendio del colle
e le circostanze. Le legioni, operando separate, resistevano ai nemici in
zone diverse. Siepi fittissime, come si è detto in precedenza, erano
frapposte e impedivano la vista. Non era possibile predisporre adeguati
contingenti di riserva e provvedere alle necessità di ciascun settore, era
esclusa l'unità di comando. Perciò, in tanta disparità di situazioni, era
inevitabile che la fortuna giocasse ruoli diversi sul campo di battaglia.
[23
I soldati della nona e della decima legione, schierati all'ala sinistra,
lanciarono i giavellotti e respinsero rapidamente i nemici che avevano di
fronte, gli Atrebati, rimasti senza fiato per la corsa e sfiniti dalle
ferite; li costrinsero a retrocedere dall'alto fino al fiume e qui, mentre
tentavano il guado e si trovavano in difficoltà, li inseguirono con le
spade in pugno e ne fecero strage. Poi senza esitazione attraversarono il
fiume e avanzarono, anche se la posizione era sfavorevole; i nemici, a
loro volta, opposero resistenza, riaprendo la battaglia, ma i nostri li
volsero in fuga. E anche in un altro settore, due legioni, l'undicesima e
l'ottava, agendo separatamente, avevano respinto dalla sommità del colle i
Viromandui, con i quali si erano scontrate, e combattevano ormai sulla
riva del fiume. Ma quasi tutto l'accampamento sulla fronte e sulla
sinistra era rimasto sguarnito (la dodicesima legione e, non lontano, la
settima avevano preso posto all'ala destra), perciò lì puntarono tutti i
Nervi in formazione compatta, sotto la guida di Boduognato, il comandante
in capo. Parte di essi iniziò una manovra di aggiramento per sorprendere
le legioni dal fianco scoperto, parte si diresse verso la sommità del
nostro campo.
[24
In quel mentre, rientravano nell'accampamento i nostri cavalieri e i fanti
armati alla leggera, che a essi si erano affiancati (entrambi erano stati
messi in fuga, come avevamo detto, al primo assalto dei Nervi). Trovandosi
di fronte i nemici, si sbandarono di nuovo, in un'altra direzione. I
caloni, invece, che dalla porta decumana e dalla sommità del colle avevano
visto i nostri, vittoriosi, portarsi oltre il fiume, uscivano
dall'accampamento per far bottino, ma, dopo essersi voltati e aver scorto
i nemici nel nostro campo, scapparono precipitosamente. Nello stesso
istante si levavano le grida e gli strepiti degli addetti alle salmerie:
in preda al panico, si lanciarono dove capitava. Scossi da tale
confusione, i cavalieri dei Treveri, che pure rispetto agli altri Galli
godono di una fama di straordinario valore e che erano stati mandati dal
loro popolo a Cesare come rinforzo, quando videro il campo romano pieno di
nemici, le legioni pressate da vicino e quasi circondate, i caloni, i
cavalieri, i frombolieri e i Numidi dispersi in fuga disordinata, si
diressero in patria, convinti che la nostra situazione fosse disperata; al
loro popolo annunciarono che i Romani erano stati sconfitti e debellati e
che i nemici si erano impossessati dell'accampamento e delle salmerie.
[25
Cesare, terminato il suo discorso alla decima legione, si diresse verso
l'ala destra, dove vide che i suoi erano alle strette e che i soldati
della dodicesima legione, vicini l'uno all'altro, si impacciavano a
vicenda, perché le insegne erano state raccolte in un sol luogo; tutti i
centurioni e un vessillifero della quarta coorte erano caduti, il vessillo
perduto, quasi tutti i centurioni delle altre coorti morti o feriti; tra
di essi il primipilo P. Sestio Baculo, soldato di grandissimo valore, non
riusciva più a reggersi in piedi, sfinito com'era dalle numerose e gravi
ferite; gli altri andavano esaurendo le forze e alcuni della retroguardia,
rimasti senza comandanti, lasciavano la mischia e si sottraevano ai colpi;
il nemico non cessava di avanzare dal basso frontalmente e di premere dai
lati. Quando vide che la situazione era critica e che non aveva truppe di
rincalzo, prese lo scudo a un soldato della retroguardia (perché era
giunto fin lì senza), avanzò in prima linea, si rivolse ai centurioni
chiamandoli per nome, uno per uno, arringò i soldati e diede l'ordine di
muovere all'attacco e di allargare i manipoli, perché i nostri potessero
usare le spade con maggior facilità. Il suo arrivo infuse fiducia nei
soldati e restituì loro il coraggio: ciascuno, pur in una situazione di
estremo pericolo, voleva dar prova di valore agli occhi del comandante,
per cui l'impeto dei nemici per un po' venne frenato.
[26
Cesare, quando si accorse che anche la settima legione, lì a fianco, era
in difficoltà, comandò ai tribuni militari di avvicinare gradualmente le
due legioni e, operata una conversione, di muovere all'assalto. La manovra
permise ai soldati di aiutarsi reciprocamente e i nostri, adesso che non
temevano più l'accerchiamento, iniziarono a resistere con maggior coraggio
e a combattere con più vigore. Nel frattempo, i soldati delle due legioni
della retroguardia, che presidiavano le salmerie, non appena ebbero
notizia dello scontro, raggiunsero di corsa la cima del colle e lì
apparvero ai nemici. E T. Labieno, conquistato il campo dei Nervi, dopo
aver visto dall'alto che cosa stava accadendo nel nostro, mandò in
rinforzo la decima legione. Dalla fuga dei cavalieri e dei caloni i
soldati si resero conto di come stavano le cose e di quale minaccia
incombesse sul campo, sulle legioni e sul comandante e si impegnarono al
massimo per arrivare al più presto.
[27
Il loro arrivo capovolse la situazione: perfino i nostri feriti si
rialzavano da terra appoggiandosi agli scudi e riprendevano a combattere.
I caloni, avendo visto i nemici impauriti, affrontavano anche disarmati
chi era armato. I cavalieri, poi, per cancellare la vergogna della fuga
con una prova di valore, in tutte le zone dello scontro precedevano i
legionari. Ma i nemici, anche ridotti quasi alla disperazione, diedero
prova di grandissimo valore, al punto che i soldati delle seconde file
salivano sui corpi dei primi caduti e da lì combattevano; abbattuti
anch'essi, si formavano mucchi di cadaveri, dai quali i superstiti, come
da un tumulo, lanciavano frecce sui nostri e scagliavano indietro i
giavellotti da essi intercettati. Non era da ritenersi senza ragione che
uomini così valorosi avessero osato attraverso un fiume larghissimo,
scalare un monte tanto alto e muovere all'attacco da una posizione
assolutamente sfavorevole: il loro eroismo aveva reso facili delle imprese
estremamente difficili.
[28
Con la battaglia era pressoché annientata la stirpe e il nome dei Nervi. I
più anziani, che con le donne e i bambini, come si era detto, si trovavano
negli stagni e nelle paludi, non appena seppero l'esito dello scontro,
considerando che nulla avrebbe ostacolato i vincitori o tutelato i vinti,
con il consenso di tutti i superstiti mandarono a Cesare dei messi e si
arresero. Menzionando la disfatta subita, gli dissero che di seicento
senatori tre soli erano sopravvissuti e che di sessantamila uomini in
grado di combattere se ne erano salvati a malapena cinquecento. Cesare,
per render palese la sua clemenza nei confronti dei miseri e dei supplici,
li tutelò con ogni cura, permise ai Nervi di mantenere territori e città,
ingiunse ai popoli limitrofi e ai loro alleati di non provocare offese o
danni.
[29
Gli Atuatuci - ne abbiamo parlato prima - stavano accorrendo con
l'esercito al completo in aiuto dei Nervi, ma, non appena fu loro riferito
l'esito dello scontro, senza neppure fermarsi rientrarono in patria.
Abbandonata ogni città o torre fortificata, si asserragliarono con tutti i
loro beni in una sola roccaforte, molto ben difesa per posizione naturale.
Da ogni lato la circondavano altissime rupi, da dove la vista dominava; in
un solo punto si apriva un accesso, in lieve pendio, non più largo di
duecento passi: lo avevano fortificato con un duplice muro, altissimo, e
ora vi collocavano massi enormi e travi molto acuminate. Gli Atuatuci
discendevano dai Cimbri e dai Teutoni, i quali all'epoca della loro
penetrazione nella nostra provincia e in Italia avevano lasciato al di qua
del Reno le salmerie che non si potevano portare dietro, affidandole a
seimila dei loro, incaricati di custodirle e proteggerle. Costoro, dopo
l'annientamento dei Cimbri e dei Teutoni, per molti anni tormentati dai
popoli di confine, sostennero guerre attaccando o difendendosi. Fatta la
pace, con il consenso generale delle genti limitrofe, si erano scelti come
sede la regione in cui si trovavano.
[30
In un primo tempo, dopo l'arrivo del nostro esercito, gli Atuatuci
effettuavano spesso sortite e si misuravano con i nostri in scaramucce di
poco conto; in seguito, quando vennero circondati da un vallo di quindici
miglia di perimetro con numerose ridotte, si tenevano entro le mura della
città. Le vinee erano già state spinte in avanti e il terrapieno
costruito; ma, quando videro che stavamo preparando, lontano, una torre,
dalle mura incominciarono subito a deriderci e a gridare perché mai un
marchingegno così grande veniva costruito a tanta distanza: su quali mani
e quale forza i Romani, piccoletti com'erano (tutti i Galli, infatti, per
lo più disprezzano la nostra statura a confronto dell'imponenza del loro
fisico), facevano conto per avvicinare alle mura una torre così pesante?
[31
Quando, però, videro che la torre veniva mossa e si avvicinava alle mura,
scossi dallo spettacolo, per loro nuovo e inusitato, mandarono a Cesare,
per offrire la resa, degli emissari che si espressero nei termini
seguenti: erano convinti che i Romani, capaci di muovere tanto rapidamente
un marchingegno così alto, dovevano godere, in guerra, dell'aiuto divino,
perciò essi si sottomettevano con tutti i propri beni alla loro autorità.
Avevano una sola richiesta, una supplica: se mai Cesare avesse deciso di
risparmiarli dando ancora prova della clemenza e mitezza di cui avevano
sentito parlare, lo pregavano di non essere privati delle armi. Quasi
tutti i popoli limitrofi erano loro nemici e invidiavano il loro valore;
una volta consegnate le armi, non avrebbero potuto difendersi.
Preferivano, se dovevano esserne costretti, subire dal popolo romano
qualsiasi punizione anziché morire tra i tormenti per mano di gente su cui
erano abituati a comandare.
[32
Alle loro richieste Cesare rispose: avrebbe risparmiato il popolo degli
Atuatuci, per proprio costume più che per loro merito, se si fossero
arresi prima che l'ariete avesse toccato le mura: ma l'unica condizione di
resa era la consegna delle armi. Si sarebbe regolato come con i Nervi,
ordinando ai popoli confinanti di non infliggere torti a chi si era arreso
al popolo romano. Le parole di Cesare furono riferite e gli Atuatuci si
dichiararono disposti a obbedire. Dal muro gettarono nel fosso, che
correva davanti alla città, una tale quantità di armi, che il cumulo
raggiungeva quasi la sommità del muro e l'altezza del nostro terrapieno: e
tuttavia - lo si scoprì in seguito - si erano tenuti e avevano nascosto in
città circa un terzo delle armi. Aperte le porte, per quel giorno rimasero
tranquilli.
[33
Verso sera Cesare ordinò che le porte venissero chiuse e che i soldati
romani lasciassero la città, perché non si verificassero atti di violenza
nei confronti della popolazione. Gli Atuatuci, come si capì in seguito,
avevano architettato un piano, pensando che i nostri, dopo la resa,
avrebbero tolto i presidi o, almeno, avrebbero allentato la sorveglianza.
Perciò, con le armi che si erano tenute e avevano nascosto oppure con
scudi di corteccia o vimini intrecciati, ricoperti di pelli sul momento,
come richiedeva l'esiguo tempo a disposizione, dopo mezzanotte tentarono
in massa un'improvvisa sortita, puntando contro le nostre fortificazioni
per la via meno erta. Rapidamente, come da ordine precedente di Cesare,
furono fatte segnalazioni coi fuochi e dalle ridotte più vicine accorsero
i nostri. Il nemico si batté con accanimento, come si addice a guerrieri
valorosi che, costretti a lottare, nel momento estremo e in una posizione
difficile, contro avversari che scagliavano su di loro frecce dal vallo e
dalle torri, ripongono ogni speranza di salvezza solo nel proprio valore.
Ne furono uccisi circa quattromila, gli altri vennero ricacciati in città.
Il giorno seguente furono abbattute le porte, ormai sguarnite, e i nostri
soldati entrarono in città. Cesare vendette all'asta tutto quanto il
bottino. I compratori gli riferirono il numero dei prigionieri:
cinquantatremila.
[34
Nello stesso tempo P. Crasso, che era stato mandato con una legione nelle
terre dei Veneti, degli Unelli, degli Osismi, dei Coriosoliti, degli
Esuvi, degli Aulerci e dei Redoni, popoli marittimi che si affacciano
sull'Oceano, informò Cesare di averli sottomessi tutti all'autorità e al
dominio di Roma.
[35
Portate a termine tali imprese e pacificata la Gallia, si diffuse tra i
barbari una tale fama di questa guerra, che i popoli d'oltre Reno
inviarono a Cesare ambascerie impegnandosi alla consegna di ostaggi e
all'obbedienza. Cesare, che aveva fretta di partire per l'Italia e
l'Illirico, invitò i messi delle legazioni a ripresentarsi all'inizio
dell'estate successiva. E, condotte le legioni negli accampamenti
invernali, nelle terre dei Carnuti, degli Andi, dei Turoni e dei popoli
vicini ai luoghi in cui avevano combattuto, se ne partì per l'Italia. In
seguito alle sue imprese, comunicate per lettera da Cesare stesso, furono
decretati quindici giorni di feste solenni di ringraziamento, onore mai
tributato a nessuno prima di allora. |
LIBER TERTIUS
[1] Cum in Italiam proficisceretur Caesar, Ser. Galbam cum legione XII et parte equitatus in Nantuates, Veragros Sedunosque misit, qui a finibus Allobrogum et lacu Lemanno et flumine Rhodano ad summas Alpes pertinent. Causa mittendi fuit quod iter per Alpes, quo magno cum periculo magnisque cum portoriis mercatores ire consuerant, patefieri volebat. Huic permisit, si opus esse arbitraretur, uti in his locis legionem hiemandi causa conlocaret. Galba secundis aliquot proeliis factis castellisque compluribus eorum expugnatis, missis ad eum undique legatis obsidibusque datis et pace facta, constituit cohortes duas in Nantuatibus conlocare et ipse cum reliquis eius legionis cohortibus in vico Veragrorum, qui appellatur Octodurus hiemare; qui vicus positus in valle non magna adiecta planitie altissimis montibus undique continetur. Cum hic in duas partes flumine divideretur, alteram partem eius vici Gallis
[ad hiemandum] concessit, alteram vacuam ab his relictam cohortibus attribuit. Eum locum vallo fossaque munivit.
[2] Cum dies hibernorum complures transissent frumentumque eo comportari iussisset, subito per exploratores certior factus est ex ea parte vici, quam Gallis concesserat, omnes noctu discessisse montesque qui impenderent a maxima multitudine Sedunorum et Veragrorum teneri. Id aliquot de causis acciderat, ut subito Galli belli renovandi legionisque opprimendae consilium caperent: primum, quod legionem neque eam plenissimam detractis cohortibus duabus et compluribus singillatim, qui commeatus petendi causa missi erant, absentibus propter paucitatem despiciebant; tum etiam, quod propter iniquitatem loci, cum ipsi ex montibus in vallem decurrerent et tela coicerent, ne primum quidem impetum suum posse sustineri existimabant. Accedebat quod suos ab se liberos abstraetos obsidum nomine dolebant, et Romanos non solum itinerum causa sed etiam perpetuae possessionis culmina Alpium oceupare conari et ea loca finitimae provinciae adiungere sibi persuasum habebant.
[3] His nuntiis acceptis Galba, cum neque opus hibernorum munitionesque plene essent perfectae neque de frumento reliquoque commeatu satis esset provisum quod deditione facta obsidibusque acceptis nihil de bello timendum existimaverat, consilio celeriter convocato sententias exquirere coepit. Quo in consilio, cum tantum repentini periculi praeter opinionem accidisset ac iam omnia fere superiora loca multitudine armatorum completa conspicerentur neque subsidio veniri neque commeatus supportari interclusis itineribus possent, prope iam desperata salute non nullae eius modi sententiae dicebantur, ut impedimentis relictis eruptione facta isdem itineribus quibus eo pervenissent ad salutem contenderent. Maiori tamen parti placuit, hoc reservato ad extremum casum consilio interim rei eventum experiri et castra defendere.
[4] Brevi spatio interiecto, vix ut iis rebus quas constituissent conlocandis atque administrandis tempus daretur, hostes ex omnibus partibus signo dato decurrere, lapides gaesaque in vallum coicere. Nostri primo integris viribus fortiter propugnare neque ullum flustra telum ex loco superiore mittere, et quaecumque pars castrorum nudata defensoribus premi videbatur, eo occurrere et auxilium ferre, sed hoc superari quod diuturnitate pugnae hostes defessi proelio excedebant, alii integris viribus succedebant; quarum rerum a nostris propter paucitatem fieri nihil poterat, ac non modo defesso ex pugna excedendi, sed ne saucio quidem eius loci ubi constiterat relinquendi ac sui recipiendi facultas dabatur.
[5] Cum iam amplius horis sex continenter pugnaretur, ac non solum vires sed etiam tela nostros deficerent, atque hostes acrius instarent languidioribusque nostris vallum scindere et fossas complere coepissent, resque esset iam ad extremum perducta casum, P. Sextius Baculus, primi pili centurio, quem Nervico proelio compluribus confectum vulneribus diximus, et item C. Volusenus, tribunus militum, vir et consilii magni et virtutis, ad Galbam accurrunt atque unam esse spem salutis docent, si eruptione facta extremum auxilium experirentur. Itaque convocatis centurionibus celeriter milites certiores facit, paulisper intermitterent proelium ac tantum modo tela missa exciperent seque ex labore reficerent, post dato signo ex castris erumperent, atque omnem spem salutis in virtute ponerent.
[6] Quod iussi sunt faciunt, ac subito omnibus portis eruptione facta neque cognoscendi quid fieret neque sui colligendi hostibus facultatem relinquunt. Ita commutata fortuna eos qui in spem potiundorum castrorum venerant undique circumventos intercipiunt, et ex hominum milibus amplius XXX, quem numerum barbarorum ad castra venisse constabat, plus tertia parte interfecta reliquos perterritos in fugam coiciunt ac ne in locis quidem superioribus consistere patiuntur. Sic omnibus hostium copiis fusis armisque exutis se intra munitiones suas recipiunt. Quo proelio facto, quod saepius fortunam temptare Galba nolebat atque alio se in hiberna consilio venisse meminerat, aliis occurrisse rebus videbat, maxime frumenti
[commeatusque] inopia permotus postero die omnibus eius vici aedificiis incensis in provinciam reverti contendit, ac nullo hoste prohibente aut iter demorante incolumem legionem in Nantuates, inde in Allobroges perduxit ibique hiemavit.
[7] His rebus gestis cum omnibus de causis Caesar pacatam Galliam existimaret,
[superatis Belgis, expulsis Germanis, victis in Alpibus Sedunis,] atque ita inita hieme in Illyricum profectus esset, quod eas quoque nationes adire et regiones cognoseere volebat, subitum bellum in Gallia eoortum est. Eius belli haec fuit causa. P. Crassus adulescens eum legione VII. proximus mare Oeeanum in Andibus hiemabat. Is, quod in his loeis inopia frumenti erat, praefectos tribunosque militum eomplures in finitimas civitates frumenti causa dimisit; quo in numero est T. Terrasidius missus in Esuvios, M. Trebius Gallus in Coriosolites, Q. Velanius eum T. Silio in Venetos.
[8] Huius est civitatis longe amplissima auctoritas omnis orae maritimae regionum earum, quod et naves habent Veneti plurimas, quibus in Britanniam navigare consuerunt, et scientia atque usu rerum nauticarum ceteros antecedunt et in magno impetu maris atque aperto paucis portibus interiectis, quos tenent ipsi, omnes fere qui eo mari uti consuerunt habent vectigales. Ab his fit initium retinendi Silii atque Velanii, quod per eos suos se obsides, quos Crasso dedissent, recuperaturos existimabant. Horum auctoritate finitimi adducti, ut sunt Gallorum subita et repentina consilia, eadem de causa Trebium Terrasidiumque retinent et celeriter missis legatis per suos principes inter se coniurant nihil nisi communi consilio acturos eundemque omnes fortunae exitum esse laturos, reliquasque civitates sollicitant, ut in ea libertate quam a maioribus acceperint permanere quam Romanorum servitutem perferre malint. Omni ora maritima celeriter ad suam sententiam perducta communem legationem ad P. Crassum mittunt, si velit suos recuperare, obsides sibi remittat.
[9] Quibus de rebus Caesar a Crasso certior factus, quod ipse aberat longius, naves interim longas aedificari in flumine Ligeri, quod influit in Oceanum, remiges ex provincia institui, nautas gubernatoresque comparari iubet. His rebus celeriter administratis ipse, cum primum per anni tempus potuit, ad exercitum contendit. Veneti reliquaeque item civitates cognito Caesaris adventu
[certiores facti], simul quod quantum in se facinus admisissent intellegebant,
[legatos, quod nomen ad omnes nationes sanctum inviolatumque semper fuisset, retentos ab se et in vincula coniectos,] pro magnitudine periculi bellum parare et maxime ea quae ad usum navium pertinent providere instituunt, boc maiore spe quod multum natura loci confidebant. Pedestria esse itinera concisa aestuariis, navigationem impeditam propter inscientiam locorum paucitatemque portuum sciebant, neque nostros exercitus propter inopiam frumenti diutius apud se morari posse confidebant; ac iam ut omnia contra opinionem acciderent, tamen sc plurimum navibus posse,
[quam] Romanos neque ullam facultatem habere navium, neque eorum locorum ubi bellum gesturi essent vada, portus, insulas novisse; ac longe aliam esse navigationem in concluso mari atque in vastissimo atque apertissimo Oceano perspiciebant. His initis consiliis oppida muniunt, frumenta ex agris in oppida comportant, naves in Venetiam, ubi Caesarem primum bellum gesturum constabat, quam plurimas possunt cogunt. Socios sibi ad id bellum Osismos, Lexovios, Namnetes, Ambiliatos, Morinos, Diablintes, Menapios adsciscunt; auxilia ex Britannia, quae contra eas regiones posita est, arcessunt.
[10] Erant hae difficultates belli gerendi quas supra ostendimus, sed tamen multa Caesarem ad id bellum incitabant: iniuria retentorum equitum Romanorum, rebellio facta post deditionem, defectio datis obsidibus, tot civitatum coniuratio, in primis ne hac parte neglecta reliquae nationes sibi idem licere arbitrarentur. Itaque cum intellegeret omnes fere Gallos novis rebus studere et ad bellum mobiliter celeriterque excitari, omnes autem homines natura libertati studere et condicionem servitutis odisse, prius quam plures civitates conspirarent, partiendum sibi ac latius distribuendum exercitum putavit.
[11] Itaque T. Labienum legatum in Treveros, qui proximi flumini Rheno sunt, cum equitatu mittit. Huic mandat, Remos reliquosque Belgas adeat atque in officio contineat Germanosque, qui auxilio a Belgis arcessiti dicebantur, si per vim navibus flumen transire conentur, prohibeat. P. Crassum cum cohortibus legionariis XII et magno numero equitatus in Aquitaniam proficisci iubet, ne ex his nationibus auxilia in Galliam mittantur ac tantae nationes coniungantur. Q. Titurium Sabinum legatum cum legionibus tribus in Venellos, Coriosolites Lexoviosque mittit, qui eam manum distinendam curet. D. Brutum adulescentem classi Gallicisque navibus, quas ex Pictonibus et Santonis reliquisque pacatis regionibus convenire iusserat, praeficit et, cum primum possit, in Venetos proficisci iubet. Ipse eo pedestribus copiis contendit.
[12] Erant eius modi fere situs oppidorum ut posita in extremis lingulis promunturiisque neque pedibus aditum haberent, cum ex alto se aestus incitavisset, quod
[bis] accidit semper horarum XII spatio, neque navibus, quod rursus minuente aestu naves in vadis adflictarentur. Ita utraque re oppidorum oppugnatio impediebatur. Ac si quando magnitudine operis forte superati, extruso mari aggere ac molibus atque his oppidi moenibus adaequatis, suis fortunis desperare coeperant, magno numero navium adpulso, cuius rei summam facultatem habebant, omnia sua deportabant seque in proxima oppida recipiebant: ibi se rursus isdem oportunitatibus loci defendebant. Haec eo facilius magnam partem aestatis faciebant quod nostrae naves tempestatibus detinebantur summaque erat vasto atque aperto mari, magnis aestibus, raris ac prope nullis portibus difficultas navigandi.
[13] Namque ipsorum naves ad hunc modum factae armataeque erant: carinae aliquanto planiores quam nostrarum navium, quo facilius vada ac decessum aestus excipere possent; prorae admodum erectae atque item puppes, ad magnitudinem fluctuum tempestatumque accommodatae; naves totae factae ex robore ad quamvis vim et contumeliam perferendam; transtra ex pedalibus in altitudinem trabibus, confixa clavis ferreis digiti pollicis crassitudine; ancorae pro funibus ferreis catenis revinctae; pelles pro velis alutaeque tenuiter confectae,
[hae] sive propter inopiam lini atque eius usus inscientiam, sive eo, quod est magis veri simile, quod tantas tempestates Oceani tantosque impetus ventorum sustineri ac tanta onera navium regi velis non satis commode posse arbitrabantur. Cum his navibus nostrae classi eius modi congressus erat ut una celeritate et pulsu remorum praestaret, reliqua pro loci natura, pro vi tempestatum illis essent aptiora et accommodatiora. Neque enim iis nostrae rostro nocere poterant (tanta in iis erat firmitudo), neque propter altitudinem facile telum adigebatur, et eadem de causa minus commode copulis continebautur. Accedebat ut, cum
[saevire ventus coepisset et] se vento dedissent, et tempestatem ferrent facilius et in vadis consisterent tutius et ab aestu relictae nihil saxa et cautes timerent; quarum rerum omnium nostris navibus casus erat extimescendus.
[14] Compluribus expugnatis oppidis Caesar, ubi intellexit frustra tantum laborem sumi neque hostium fugam captis oppidis reprimi neque iis noceri posse, statuit expectandam classem. Quae ubi convenit ac primum ab hostibus visa est, circiter CCXX naves eorum paratissimae atque omni genere armorum ornatissimae profectae ex portu nostris adversae constiterunt; neque satis Bruto, qui classi praeerat, vel tribunis militum centurionibusque, quibus singulae naves erant attributae, constabat quid agerent aut quam rationem pugnae insisterent. Rostro enim noceri non posse cognoverant; turribus autem excitatis tamen has altitudo puppium ex barbaris navibus superabat, ut neque ex inferiore loco satis commode tela adigi possent et missa a Gallis gravius acciderent. Una erat magno usui res praeparata a nostris, falces praeacutae insertae adfixaeque longuriis, non absimili forma muralium falcium. His cum funes qui antemnas ad malos destinabant comprehensi adductique erant, navigio remis incitato praerumpebantur. Quibus abscisis antemnae necessario concidebant, ut, cum omnis Gallicis navibus spes in velis armamentisque consisteret, his ereptis omnis usus navium uno tempore eriperetur. Reliquum erat certamen positum in virtute, qua nostri milites facile superabant, atque eo magis quod in conspectu Caesaris atque omnis exercitus res gerebatur, ut nullum paulo fortius factum latere posset; omnes enim colles ac loca superiora, unde erat propinquus despectus in mare, ab exercitu tenebantur.
[15] Deiectis, ut diximus, antemnis, cum singulas binae ac ternae naves circumsteterant, milites summa vi transcendere in hostium naves contendebant. Quod postquam barbari fieri animadverterunt, expugnatis compluribus navibus, cum ei rei nullum reperiretur auxilium, fuga salutem petere contenderunt. Ac iam conversis in eam partem navibus quo ventus ferebat, tanta subito malacia ac tranquillitas exstitit ut se ex loco movere non possent. Quae quidem res ad negotium conficiendum maximae fuit oportunitati: nam singulas nostri consectati expugnaverunt, ut perpaucae ex omni numero noctis interventu ad terram pervenirent, cum ab hora fere IIII usque ad solis occasum pugnaretur.
[16] Quo proelio bellum Venetorum totiusque orae maritimae confectum est. Nam cum omnis iuventus, omnes etiam gravioris aetatis in quibus aliquid consilii aut dignitatis fuit eo convenerant, tum navium quod ubique fuerat in unum locum coegerant; quibus amissis reliqui neque quo se reciperent neque quem ad modum oppida defenderent habebant. Itaque se suaque omnia Caesari dediderunt. In quos eo gravius Caesar vindicandum statuit quo diligentius in reliquum tempus a barbaris ius legatorum conservaretur. Itaque omni senatu necato reliquos sub corona vendidit.
[17] Dum haec in Venetis geruntur, Q. Titurius Sabinus cum iis copiis quas a Caesare acceperat in fines Venellorum pervenit. His praeerat Viridovix ac summam imperii tenebat earum omnium civitatum quae defecerant, ex quibus exercitum
[magnasque copias] coegerat; atque his paucis diebus Aulerci Eburovices Lexoviique, senatu suo interfecto quod auctores belli esse nolebant, portas clauserunt seque cum Viridovice coniunxerunt; magnaque praeterea multitudo undique ex Gallia perditorum hominum latronumque convenerat, quos spes praedandi studiumque bellandi ab agri cultura et cotidiano labore revocabat. Sabinus idoneo omnibus rebus loco castris sese tenebat, cum Viridovix contra eum duorum milium spatio consedisset cotidieque productis copiis pugnandi potestatem faceret, ut iam non solum hostibus in contemptionem Sabinus veniret, sed etiam nostrorum militum vocibus non nihil carperetur; tantamque opinionem timoris praebuit ut iam ad vallum castrorum hostes accedere auderent. Id ea de causa faciebat quod cum tanta multitudine hostium, praesertim eo absente qui summam imperii teneret, nisi aequo loco aut oportunitate aliqua data legato dimicandum non existimabat.
[18] Hac confirmata opinione timoris idoneum quendam hominem et callidum deligit, Gallum, ex iis quos auxilii causa secum habebat. Huic magnis praemiis pollicitationibusque persuadet uti ad hostes transeat, et quid fieri velit edocet. Qui ubi pro perfuga ad eos venit, timorem Romanorum proponit, quibus angustiis ipse Caesar a Venetis prematur docet, eque longius abesse quin proxima nocte Sabinus clam ex castris exercitum educat et ad Caesarem auxilii ferendi causa proficiscatur. Quod ubi auditum est, conclamant omnes occasionem negotii bene gerendi amittendam non esse: ad castra iri oportere. Multae res ad hoc consilium Gallos hortabantur: superiorum dierum Sabini cunctatio, perfugae confirmatio, inopia cibariorum, cui rei parum diligenter ab iis erat provisum, spes Venetici belli, et quod fere libenter homines id quod volunt credunt. His rebus adducti non prius Viridovicem reliquosque duces ex concilio dimittunt quam ab iis sit concessum arma uti capiant et ad castra contendant. Qua re concessa laeti, ut explorata victoria, sarmentis virgultisque collectis, quibus fossas Romanorum compleant, ad castra pergunt.
[19] Locus erat castrorum editus et paulatim ab imo acclivis circiter passus mille. Huc magno cursu contenderunt, ut quam minimum spatii ad se colligendos armandosque Romanis daretur, exanimatique pervenerunt. Sabinus suos hortatus cupientibus signum dat. Impeditis hostibus propter ea quae ferebant onera subito duabus portis eruptionem fieri iubet. Factum est oportunitate loci, hostium inscientia ac defatigatione, virtute militum et superiorum pugnarum exercitatione, ut ne unum quidem nostrorum impetum ferrent ac statim terga verterent. Quos impeditos integris viribus milites nostri consecuti magnum numerum eorum occiderunt; reliquos equites consectati paucos, qui ex fuga evaserant, reliquerunt. Sic uno tempore et de navali pugna Sabinus et de Sabini victoria Caesar est certior factus, civitatesque omnes se statim Titurio dediderunt. Nam ut ad bella suscipienda Gallorum alacer ac promptus est animus, sic mollis ac minime resistens ad calamitates ferendas mens eorum est.
[20] Eodem fere tempore P. Crassus, cum in Aquitaniam pervenisset, quae
[pars], ut ante dictum est,
[et regionum latitudine et multitudine hominum] tertia pars Galliae est
[aestimanda], cum intellegeret in iis locis sibi bellum gerendum ubi paucis ante annis L. Valerius Praeconinus legatus exercitu pulso interfectus esset atque unde L. Manlius proconsul impedimentis amissis profugisset, non mediocrem sibi diligentiam adhibendam intellegebat. Itaque re frumentaria provisa, auxiliis equitatuque comparato, multis praeterea viris fortibus Tolosa et Carcasone et Narbone, quae sunt civitates Galliae provinciae finitimae, ex his regionibus nominatim evocatis, in Sotiatium fines exercitum introduxit. Cuius adventu cognito Sotiates magnis copiis coactis, equitatuque, quo plurimum valebant, in itinere agmen nostrum adorti primum equestre proelium commiserunt, deinde equitatu suo pulso atque insequentibus nostris subito pedestres copias, quas in convalle in insidiis conlocaverant, ostenderunt. Hi nostros disiectos adorti proelium renovarunt.
[21] Pugnatum est diu atque acriter, cum Sotiates superioribus victoriis freti in sua virtute totius Aquitaniae salutem positam putarent, nostri autem quid sine imperatore et sine reliquis legionibus adulescentulo duce efficere possent perspici cuperent; tandem confecti vulneribus hostes terga verterunt. Quorum magno numero interfecto Crassus ex itinere oppidum Sotiatium oppugnare coepit. Quibus fortiter resistentibus vineas turresque egit. Illi alias eruptione temptata, alias cuniculis ad aggerem vineasque actis (cuius rei sunt longe peritissimi Aquitani, propterea quod multis locis apud eos aerariae secturaeque sunt), ubi diligentia nostrorum nihil his rebus profici posse intellexerunt, legatos ad Crassum mittunt seque in deditionem ut recipiat petunt.
[22] Qua re impetrata arma tradere iussi faciunt. Atque in eam rem omnium nostrorum intentis animis alia ex parte oppidi Adiatunnus, qui summam imperii tenebat, cum DC devotis, quos illi soldurios appellant, quorum haec est condicio, ut omnibus in vita commodis una cum iis fruantur quorum se amicitiae dediderint, si quid his per vim accidat, aut eundem casum una ferant aut sibi mortem consciscant; neque adhuc hominum memoria repertus est quisquam qui, eo interfecto cuius se amicitiae devovisset, mortem recusaret---cum his Adiatunnus eruptionem facere conatus clamore ab ea parte munitionis sublato cum ad arma milites concurrissent vehementerque ibi pugnatum esset, repulsus in oppidum tamen uti eadem deditionis condicione uteretur a Crasso impetravit.
[23] Armis obsidibusque acceptis, Crassus in fines Vocatium et Tarusatium profectus est. Tum vero barbari commoti, quod oppidum et natura loci et manu munitum paucis diebus quibus eo ventum erat expugnatum cognoverant, legatos quoque versum dimittere, coniurare, obsides inter se dare, copias parare coeperunt. Mittuntur etiam ad eas civitates legati quae sunt citerioris Hispaniae finitimae Aquitaniae: inde auxilia ducesque arcessuntur. Quorum adventu magna cum auctoritate et magna
[cum] hominum multitudine bellum gerere conantur. Duces vero ii deliguntur qui una cum Q. Sertorio omnes annos fuerant summamque scientiam rei militaris habere existimabantur. Hi consuetudine populi Romani loca capere, castra munire, commeatibus nostros intercludere instituunt. Quod ubi Crassus animadvertit, suas copias propter exiguitatem non facile diduci, hostem et vagari et vias obsidere et castris satis praesidii relinquere, ob eam causam minus commode frumentum commeatumque sibi supportari, in dies hostium numerum augeri, non cunctandum existimavit quin pugna decertaret. Hac re ad consilium delata, ubi omnes idem sentire intellexit, posterum diem pugnae constituit.
[24] Prima luce productis omnibus copiis duplici acie instituta, auxiliis in mediam aciem coniectis, quid hostes consilii caperent expectabat. Illi, etsi propter multitudinem et veterem belli gloriam paucitatemque nostrorum se tuto dimicaturos existimabant, tamen tutius esse arbitrabantur obsessis viis commeatu intercluso sine vulnere victoria potiri, et si propter inopiam rei frumentariae Romani se recipere coepissent, impeditos in agmine et sub sarcinis infirmiore animo adoriri cogitabant. Hoc consilio probato ab ducibus, productis Romanorum copiis, sese castris tenebant. Hac re perspecta Crassus, cum sua cunctatione atque opinione timoris hostes nostros milites alacriores ad pugnaudum effecissent atque omnium voces audirentur expectari diutius non oportere quin ad castra iretur, cohortatus suos omnibus cupientibus ad hostium castra contendit.
[25] Ibi cum alii fossas complerent, alii multis telis coniectis defensores vallo munitionibusque depellerent, auxiliaresque, quibus ad pugnam non multum Crassus confidebat, lapidibus telisque subministrandis et ad aggerem caespitibus comportandis speciem atque opinionem pugnantium praeberent, cum item ab hostibus constanter ac non timide pugnaretur telaque ex loco superiore missa non frustra acciderent, equites circumitis hostium castris Crasso renuntiaverunt non eadem esse diligentia ab decumana porta castra munita facilemque aditum habere.
[26] Crassus equitum praefectos cohortatus, ut magnis praemiis pollicitationibusque suos excitarent, quid fieri vellet ostendit. Illi, ut erat imperatum, eductis iis cohortibus quae praesidio castris relictae intritae ab labore erant, et longiore itinere circumductis, ne ex hostium castris conspici possent, omnium oculis mentibusque ad pugnam intentis celeriter ad eas quas diximus munitiones pervenerunt atque his prorutis prius in hostium castris constiterunt quam plane ab his videri aut quid rei gereretur cognosci posset. Tum vero clamore ab ea parte audito nostri redintegratis viribus, quod plerumque in spe victoriae accidere consuevit, acrius impugnare coeperunt. Hostes undique circumventi desperatis omnibus rebus se per munitiones deicere et fuga salutem petere contenderunt. Quos equitatus apertissimis campis consectatus ex milium L numero, quae ex Aquitania Cantabrisque convenisse constabat, vix quarta parte relicta, multa nocte se in castra recepit.
[27] Hac audita pugna maxima pars Aquitaniae sese Crasso dedidit obsidesque ultro misit; quo in numero fuerunt Tarbelli, Bigerriones, Ptianii, Vocates, Tarusates, Elusates, Gates, Ausci, Garumni, Sibusates, Cocosates: paucae ultimae nationes anni tempore confisae, quod hiems suberat, id facere neglexerunt.
[28] Eodem fere tempore Caesar, etsi prope exacta iam aestas erat, tamen, quod omni Gallia pacata Morini Menapiique supererant, qui in armis essent neque ad eum umquam legatos de pace misissent, arbitratus id bellum celeriter confici posse eo exercitum duxit; qui longe alia ratione ac reliqui Galli bellum gerere coeperunt. Nam quod intellegebant maximas nationes, quae proelio contendissent, pulsas superatasque esse, continentesque silvas ac paludes habebant, eo se suaque omnia contulerunt. Ad quarum initium silvarum cum Caesar pervenisset castraque munire instituisset neque hostis interim visus esset, dispersis in opere nostris subito ex omnibus partibus silvae evolaverunt et in nostros impetum fecerunt. Nostri celeriter arma ceperunt eosque in silvas repulerunt et compluribus interfectis longius impeditioribus locis secuti paucos ex suis deperdiderunt.
[29] Reliquis deinceps diebus Caesar silvas caedere instituit, et ne quis inermibus imprudentibusque militibus ab latere impetus fieri posset, omnem eam materiam quae erat caesa conversam ad hostem conlocabat et pro vallo ad utrumque latus extruebat. Incredibili celeritate magno spatio paucis diebus confecto, cum iam pecus atque extrema impedimenta a nostris tenerentur, ipsi densiores silvas peterent, eius modi sunt tempestates consecutae uti opus necessario intermitteretur et continuatione imbrium diutius sub pellibus milites contineri non possent. Itaque vastatis omnibus eorum agris, vicis aedificiisque incensis, Caesar exercitum reduxit et in Aulercis Lexoviisque, reliquis item civitatibus quae |
LIBRO TERZO
[1
Cesare, partendo per l'Italia, mandò Servio Galba con la dodicesima
legione e parte della cavalleria nei territori dei Nantuati, dei Veragri e
dei Seduni, che dalla regione degli Allobrogi, dal lago Lemano e dal
Rodano raggiungono la cima delle Alpi. Lo scopo era di aprire la via
attraverso le Alpi, che i mercanti di solito percorrevano sottoposti a
gravi rischi e pesanti dazi. Cesare diede a Galba il permesso di svernare
con la legione in quei luoghi, se lo avesse ritenuto opportuno. Galba
riportò alcuni successi in battaglia ed espugnò parecchie fortezze
nemiche: tutti i popoli della zona gli mandarono ambascerie. Ricevuti gli
ostaggi e conclusa la pace, decise di stanziare nelle terre dei Nantuati
due coorti, mentre con le rimanenti pose i quartieri d'inverno in un
villaggio dei Veragri, Octoduro, situato in una valle a cui si aggiunge
una modesta pianura, chiuso tutt'intorno da monti altissimi. Dato che un
fiume divideva il villaggio in due parti, una Galba la concesse ai Galli,
perché vi svernassero, ma l'altra ordinò di evacuarla e la riservò alle
sue coorti. Fortificò il sito con un vallo e un fossato.
[2
Galba, trascorsi già parecchi giorni nell'accampamento invernale, aveva
dato ordine di consegnare le scorte di grano, quando improvvisamente seppe
dagli esploratori che, di notte, tutta la popolazione aveva abbandonato la
parte di villaggio concessa ai Galli e che i monti sovrastanti erano nelle
mani di una massa enorme di Seduni e Veragri. Le cause che avevano spinto
i Galli a prendere repentinamente la decisione di riaprire le ostilità e
di cogliere di sorpresa la nostra legione erano molteplici: primo,
disprezzavano lo scarso numero dei nostri - la legione, in effetti, non
era al completo, perché le mancavano due coorti e molti soldati che, a
piccoli gruppi, erano stati mandati in cerca di viveri; secondo,
ritenevano che i nostri, in posizione svantaggiosa com'erano, non
avrebbero potuto reggere neppure al primo assalto, quando essi, scagliando
dardi, si fossero lanciati all'attacco dai monti verso valle. A ciò si
aggiungeva il risentimento per i loro figli sottratti come ostaggi e la
convinzione che i Romani cercassero di occupare le cime delle Alpi non
tanto per aprire una via, quanto per prendere definitivamente possesso
delle loro regioni, annettendole alla nostra provincia, che con esse
confinava.
[3
I lavori e l'opera di fortificazione del campo non erano stati ultimati,
né si era provveduto a sufficienti scorte di grano o di viveri, dato che
non si vedeva motivo, dopo la resa e la consegna degli ostaggi, di temere
una guerra. Galba, messo al corrente della situazione, convocò d'urgenza i
membri del consiglio di guerra e chiese il loro parere. Il pericolo, grave
e repentino, era giunto contro ogni aspettativa: quasi tutti i monti
circostanti, ormai, brulicavano di nemici in armi, lo si vedeva; non
potevano pervenire, con le vie di comunicazione tagliate, né rinforzi, né
viveri. Perduta, ormai, ogni speranza di salvezza, durante il consiglio
alcuni espressero la proposta di lasciare i bagagli e di tentare, con una
sortita, di porsi in salvo per la via da cui erano giunti. La maggioranza,
però, decise di riservare tale piano in caso di necessità estrema,
limitandosi per il momento a valutare come si metteva la faccenda e a
difendere campo.
[4
Poco dopo - si ebbe appena il tempo di approntare le cose e di eseguire
gli ordini impartiti - i nemici, al segnale di attacco, si slanciarono in
avanti da tutte le direzioni, scagliando pietre e gese contro il vallo. In
un primo tempo i nostri, quando ancora erano nel pieno delle forze, li
contrastarono con vigore: dall'alto nessuna freccia falliva il bersaglio
ed essi accorrevano e portavano aiuto dove l'accampamento, sguarnito di
difensori, appariva in pericolo. Ma, prolungandosi la battaglia, apparve
chiaro in che cosa eravamo inferiori: i nemici stanchi uscivano dalla
mischia, lasciando il posto a forze fresche; i nostri, pochi com'erano,
non avevano modo di darsi il cambio, anzi, non solo non veniva concesso di
allontanarsi dalla battaglia a chi era stanco, ma neppure i feriti avevano
la possibilità di abbandonare il proprio posto e di ritirarsi.
[5
Si combatteva, ininterrottamente, ormai da più di sei ore e ai nostri
venivano a mancare, oltre alle forze, anche le frecce. I nemici, premendo
con impeto ancora maggiore sui legionari, sempre più spossati, avevano
iniziato ad abbattere il vallo e a riempire il fossato. La situazione era
ormai agli estremi. P. Sestio Baculo, centurione primipilo - abbiamo prima
ricordato che, durante la guerra con i Nervi, aveva riportato numerose
ferite - e anche C. Voluseno, tribuno militare, uomo di grande saggezza e
valore, si precipitano da Galba per dirgli che restava un'unica speranza:
tentare una sortita come ultimo rimedio. Così, convocati i centurioni,
Galba dà rapidamente ordine ai legionari di sospendere per il momento lo
scontro e di limitarsi a evitare i dardi nemici e a riprendere fiato: poi,
al segnale, dovevano erompere dall'accampamento e porre ogni speranza di
salvezza nel proprio valore.
[6
I legionari eseguono gli ordini e si lanciano immediatamente all'attacco
da tutte le porte, senza lasciare al nemico la possibilità di capire che
cosa stesse accadendo o di riorganizzarsi. Così, capovolte le sorti,
accade che i nemici, già sicuri di aver in pugno l'accampamento romano,
vengono invece circondati da ogni parte e uccisi. Degli oltre trentamila
uomini (tanti risultavano i barbari che avevano partecipato all'assedio
dell'accampamento romano), i nostri ne uccidono più di un terzo,
costringendo alla fuga gli altri, in preda al panico, senza permettere
loro neppure di attestarsi sulle alture. Così, messe in rotta e private
delle armi le forze nemiche, i legionari si ritirano nell'accampamento e
nelle fortificazioni. Dopo la battaglia, Galba non voleva mettere
ulteriormente alla prova la fortuna, si ricordava di aver posto i
quartieri d'inverno con ben altre intenzioni e vedeva di essere incorso in
circostanze ben diverse. Perciò, spinto soprattutto dalla mancanza di
grano e di viveri, il giorno successivo diede fuoco a tutti gli edifici
del villaggio e si incamminò sulla via del ritorno, verso la provincia;
senza che il nemico gli sbarrasse la strada o ne rallentasse la marcia,
guidò la legione nei territori dei Nantuati e, quindi, degli Allobrogi
dove passò l'inverno.
[7
Dopo tali eventi, Cesare aveva tutti i motivi di ritenere la Gallia
sottomessa: erano stati battuti i Belgi, scacciati i Germani, vinti i
Seduni sulle Alpi. Così, all'inizio dell'inverno, partì per l'Illirico,
perché voleva conoscerne i popoli e visitarne le regioni, ma
improvvisamente in Gallia scoppiò la guerra. Eccone il motivo: il giovane
P. Crasso stava svernando con la settima legione nei pressi dell'Oceano,
nella regione degli Andi. Visto che nella zona il frumento scarseggiava,
Crasso mandò molti prefetti e tribuni militari presso i popoli limitrofi
per procurarsi grano e viveri. Tra di essi T. Terrasidio fu inviato presso
gli Esuvi, M. Trebio Gallo presso i Coriosoliti, Q. Velanio con T. Sillio
presso i Veneti.
[8
I Veneti sono il popolo che, lungo tutta la costa marittima, gode di
maggior prestigio in assoluto, sia perché possiedono molte navi, con le
quali, di solito, fanno rotta verso la Britannia, sia in quanto nella
scienza e pratica della navigazione superano tutti gli altri, sia ancora
perché, in quel mare molto tempestoso e aperto, pochi sono i porti della
costa e tutti sottoposti al loro controllo, per cui quasi tutti i
naviganti abituali di quelle acque versano loro tributi. I Veneti, per
primi, trattengono Sillio e Velanio, convinti di ottenere, mediante uno
scambio, la restituzione degli ostaggi consegnati a Crasso. Influenzati
dall'autorità dei Veneti, dato che le decisioni dei Galli sono improvvise
e repentine, anche i popoli limitrofi trattengono Trebio e Terrasidio con
le stesse intenzioni. Vengono stabiliti, rapidamente, dei contatti: i
principi stringono patti per non prendere, se non di comune accordo,
nessuna iniziativa e per affrontare insieme l'esito della sorte, qualunque
fosse. Sollecitano gli altri popoli a difendere la libertà ereditata dai
loro padri piuttosto che sopportare la schiavitù dei Romani. Ben presto
tutti i popoli della costa ne sposano la causa e mandano un'ambasceria
unitaria a P. Crasso: restituisse i loro ostaggi, se voleva riavere i
suoi.
[9
Informato della situazione da Crasso, Cesare, trovandosi troppo lontano,
si limita a dar ordine, per il momento, di costruire navi da guerra lungo
la Loira, un fiume che sfocia nell'Oceano, di arruolare rematori dalla
provincia e di procurare marinai e timonieri. Dopo aver rapidamente
provveduto a tutto ciò, non appena la stagione lo consentì, raggiunse
l'esercito. I Veneti e gli altri popoli, saputo del suo arrivo e
rendendosi conto della gravità del proprio operato - avevano trattenuto e
gettato in catene degli ambasciatori, il cui nome è da sempre sacro e
inviolabile presso tutte le genti - intraprendono preparativi di guerra
commisurati a un pericolo così grande, provvedendo in particolare a tutto
ciò che serve alla navigazione, con tanta maggior speranza di successo, in
quanto confidavano molto sulla conformazione naturale del loro paese.
Sapevano, infatti, che le vie di terra erano tagliate dalle maree e che i
Romani avevano difficoltà di navigazione, per l'ignoranza dei luoghi e la
scarsità degli approdi; inoltre, confidavano che le nostre truppe, per la
mancanza di grano, non potessero trattenersi a lungo. E anche ammesso che
nessuna delle loro aspettative si fosse realizzata, disponevano di una
marina potente, mentre i Romani mancavano di una flotta, non conoscevano
neppure i passaggi, gli approdi, le isole delle zone in cui si sarebbe
combattuto; infine - lo capivano perfettamente - era ben diverso navigare
nell'Oceano, così vasto e aperto, e in un mare chiuso. Prese tali
decisioni, fortificano le città, vi ammassano scorte di grano provenienti
dalle campagne e concentrano il maggior numero possibile di navi lungo le
coste dei Veneti, dove si pensava che Cesare avrebbe iniziato le
operazioni di guerra. Si aggregano come alleati gli Osismi, i Lexovii, i
Namneti, gli Ambiliati, i Morini, i Diablinti e i Menapi; chiedono aiuti
alla Britannia, situata di fronte alle loro regioni.
[10
Abbiamo esposto le difficoltà che la guerra presentava, ma molte erano le
ragioni che spingevano Cesare allo scontro: i cavalieri romani trattenuti
contro ogni diritto, la rivolta dopo la resa, la defezione a ostaggi
consegnati, la coalizione di tante nazioni e, soprattutto, il timore che
gli altri popoli ritenessero lecito agire come i Veneti, se egli non fosse
intervenuto. A Cesare era ben noto che, per lo più, i Galli amano i
rivolgimenti e facilmente e prontamente sono disposti a far guerra (del
resto, la natura spinge tutti gli uomini ad amare la libertà e a odiare la
condizione di asservimento). Perciò, prima che la cospirazione si
estendesse ad altri popoli, ritenne opportuno dividere l'esercito per
coprire una zona di territorio più ampia.
[11
Così, manda il legato T. Labieno con la cavalleria nella regione dei
Treveri, che abitano lungo il Reno. Gli dà disposizione sia di prendere
contatto con i Remi e gli altri Belgi e di tenerli a dovere, sia di
ostacolare i Germani (si diceva che i Belgi avessero chiesto il loro
aiuto), se, a forza, avessero tentato di attraversare il fiume su navi.
Ordina a P. Crasso di partire per l'Aquitania alla testa di dodici coorti
della legione e di un buon numero di cavalieri, per evitare che i popoli
aquitani inviassero aiuti ai Galli e che nazioni così potenti si unissero.
Manda il legato Q. Titurio Sabino, alla testa di tre legioni, nelle terre
degli Unelli, dei Coriosoliti e dei Lexovi con l'ordine di tenerne
impegnate le forze. Al giovane D. Bruto affida il comando della flotta
gallica e delle navi che, dietro suo ordine, erano state fornite dai
Pictoni, dai Santoni e dalle altre regioni pacificate. Gli ingiunge di
partire alla volta dei Veneti non appena possibile. Cesare vi si dirige
con la fanteria.
[12
La posizione delle città dei Veneti era in genere la seguente: situate
all'estremità di lingue di terra e di promontori, erano inaccessibili via
terra quando si alzava la marea - un fenomeno che si verifica regolarmente
nell'arco di dodici ore - ma anche le navi non potevano accostarsi, perché
rimanevano incagliate nei bassifondi quando l'acqua si ritirava: entrambi
i fattori erano di ostacolo per un assedio. E se mai, grazie a imponenti
lavori, si riusciva ad arginare il mare con un terrapieno e con dighe,
fino a raggiungere, tramite tali opere, l'altezza delle mura, i nemici,
quando incominciavano a sentirsi perduti, facevano approdare un gran
numero di navi - ne avevano moltissime - imbarcavano tutti i loro beni e
si rifugiavano nelle città vicine, dove nuovamente potevano sfruttare gli
stessi vantaggi naturali nella difesa. Per gran parte dell'estate avevano
applicato anche più agevolmente la loro tattica, in quanto le nostre navi
erano state trattenute da tempeste e nella navigazione trovavano enormi
difficoltà, in un mare vasto e aperto, privo di approdi o quasi.
[13
Le navi dei Veneti, poi, erano costruite e attrezzate come segue: le
carene erano alquanto più piatte delle nostre, per poter resistere con
maggior facilità alle secche e alla bassa marea; le prore erano
estremamente alte e così pure le poppe, adatte a sopportare la violenza
dei flutti e delle tempeste; le navi erano completamente di rovere, capaci
di resistere a qualsiasi urto e offesa; le travi di sostegno, dello
spessore di un piede, erano fissate con chiodi di ferro della misura di un
pollice; le ancore erano legate non con funi, ma con catene di ferro; al
posto delle vele usavano pelli e cuoio sottile e morbido - forse perché
non avevano lino o non lo sapevano adoperare oppure, ed è più probabile,
perché ritenevano che le vele non potessero agevolmente reggere alle
tempeste così violente dell'Oceano, al vento tanto impetuoso e al peso
dello scafo. La nostra flotta negli scontri poteva risultare superiore
solo per rapidità e impeto dei rematori, ma per il resto le navi nemiche
erano ben più adatte alla natura del luogo e alla violenza delle tempeste.
In effetti, le nostre non potevano danneggiare con i rostri le navi dei
Veneti, tanto erano robuste, né i dardi andavano facilmente a segno,
perché erano troppo alte; per l'identica ragione risultava arduo
trattenerle con gli arpioni. Inoltre, quando il vento cominciava a
infuriare e le navi si abbandonavano alle raffiche, le loro riuscivano con
maggior facilità a sopportare le tempeste e a navigare nelle secche, senza
temere massi o scogli lasciati scoperti dalla bassa marea, tutti pericoli
che le nostre navi dovevano paventare.
[14
Cesare espugnò parecchie città, ma vedendo che tanta fatica era vana e che
non poteva impedire ai nemici di fuggire, né danneggiarli, decise di
aspettare la flotta. Non appena questa giunse e fu avvistata, circa
duecentoventi navi nemiche, assai ben equipaggiate e perfettamente
attrezzate, salparono e affrontarono le nostre; Bruto, che comandava la
flotta, non sapeva bene che cosa fare o quale tattica adottare, e così
pure i tribuni militari e i centurioni a capo di ciascuna imbarcazione.
Sapevano che il rostro non danneggiava le navi nemiche; se anche avessero
costruito delle torri, non avrebbero comunque raggiunto l'altezza delle
poppe delle navi barbare; dal basso era più difficile che le frecce
andassero a segno, mentre i dardi scagliati dai Galli risultavano
micidiali. L'unica arma di grande efficacia preparata dai nostri erano
falci acutissime, fissate a lunghi pali, di forma non dissimile dalle
falci murali. Le falci agganciavano le funi che assicuravano i pennoni
agli alberi delle navi, e le tiravano fino a spezzarle, quando i nostri
marinai aumentavano la spinta sui remi. Troncate le funi, i pennoni
inevitabilmente cadevano e così contemporaneamente, dato che tutta la
forza delle navi dei Galli consisteva nelle vele e nell'attrezzatura,
veniva sottratto alla flotta nemica ogni vantaggio. Il resto dipendeva dal
valore e in ciò i nostri avevano facilmente la meglio, tanto più che si
combatteva al cospetto di Cesare e di tutto l'esercito, per cui ogni atto
di un certo coraggio non poteva rimanere nascosto: tutti i colli e le
alture circostanti, infatti, da cui la vista dominava a strapiombo sul
mare, erano occupati dal nostro esercito.
[15
Una volta abbattuti, come abbiamo descritto, i pennoni, ciascuna nave
nemica veniva circondata da due o tre delle nostre e i soldati romani si
lanciavano all'abbordaggio con grande impeto. Quando i barbari se ne
accorsero, già molte delle loro navi erano state catturate; non trovando
alcun mezzo di difesa contro la tattica romana, cercavano salvezza nella
fuga. Avevano già orientato le navi nella direzione in cui soffiava il
vento, quando si verificò un'improvvisa, totale bonaccia, che impedì loro
di allontanarsi. La cosa fu del tutto favorevole per portare a termine le
operazioni: i nostri inseguirono le navi nemiche e le catturarono una a
una. Ben poche, di quante erano, riuscirono a prender terra grazie al
sopraggiungere della notte. Si era combattuto dalle dieci circa del
mattino fino al tramonto.
[16
La battaglia segnò la fine della guerra con i Veneti e i popoli di tutta
la costa. Infatti, tutti i giovani e anche tutti gli anziani più assennati
e autorevoli si erano là radunati e avevano raccolto in un sol luogo ogni
nave disponibile. Perduta la flotta, i superstiti non sapevano dove
rifugiarsi, né come difendere le loro città. Perciò, si arresero con tutti
i loro beni a Cesare ed egli decise di agire con più rigore nei loro
confronti, perché i barbari, per il futuro, imparassero a osservare con
maggior scrupolo il diritto che tutela gli ambasciatori. Così, ordinò di
mettere a morte tutti i senatori e di vendere come schiavi gli altri.
[17
Mentre accadono tali avvenimenti nella guerra con i Veneti, Q. Titurio
Sabino giunge nel territorio degli Unelli con le truppe fornitegli da
Cesare. Capo degli Unelli era Viridovice, che deteneva anche il comando
supremo di tutti i popoli in rivolta. Tra di essi aveva raccolto un
esercito e truppe numerose. In pochi giorni gli Aulerci Eburovici e i
Lexovi, uccisi i senatori, che non approvavano la guerra, sbarrarono le
porte delle loro città e si allearono con Viridovice: inoltre, da ogni
parte della Gallia era giunta una gran quantità di disperati e deliquenti,
che avevano lasciato il lavoro dei campi e le occupazioni quotidiane
attratti dalla speranza di bottino e dal desiderio di combattere. Sabino
si teneva nell'accampamento, in un luogo ottimo da tutti i punti di vista,
mentre Viridovice, che si era stanziato lì di fronte, a una distanza di
due miglia, schierava ogni giorno le sue truppe a battaglia, offrendo ai
Romani la possibilità di combattere. Così, Sabino non solo si procurava il
disprezzo dei nemici, ma non veniva risparmiato neppure dai discorsi dei
nostri soldati. A tal punto diede l'impressione di aver paura, che i
nemici osavano addirittura avanzare fino al vallo dell'accampamento. Il
motivo del suo comportamento era il seguente: dinnanzi a tanti nemici,
soprattutto in assenza del comandante in capo, riteneva che un legato non
dovesse accettare lo scontro, se non su un terreno favorevole o in
circostanze vantaggiose.
[18
Sabino, quando l'impressione che avesse timore era ormai radicata, scelse
tra le truppe ausiliarie un Gallo adatto ed astuto. Con la promessa di
grandi ricompense lo convince a passare dalla parte del nemico e gli
illustra il suo piano. Il Gallo, giunto al campo nemico fingendosi un
fuggiasco, descrive il timore dei Romani, espone le difficoltà che i
Veneti procurano a Cesare e rivela che non più tardi della notte seguente
Sabino alla testa dell'esercito avrebbe lasciato di nascosto
l'accampamento e si sarebbe diretto da Cesare per portargli aiuto. A
queste notizie, tutti gridano che non si deve lasciar perdere una simile
occasione: bisogna marciare sul campo romano. Molti elementi spingevano i
Galli a decidere in tal senso: l'esitazione di Sabino nei giorni
precedenti, la conferma del fuggiasco, le scarse riserve di viveri, cui
non avevano provvisto con la dovuta cura, la speranza di una vittoria dei
Veneti e il fatto che, in genere, gli uomini sono inclini a credere vero
ciò che desiderano. Spinti da tali sentimenti, non permettono a Viridovice
e agli altri capi di lasciare l'assemblea prima di ottenere il consenso a
prendere le armi e ad assalire l'accampamento romano. Accordato il
consenso, lieti come se avessero già la vittoria in pugno, raccolgono
fascine e legname per riempire i fossati del campo romano e lì si
dirigono.
[19
L'accampamento si trovava in cima a un lieve pendio di circa mille passi.
I nemici mossero all'attacco per non dare ai Romani il tempo di radunarsi
e di prendere le armi, ma così giunsero senza fiato. Sabino, esortati i
suoi, impazienti ormai di combattere, dà il segnale e ordina di piombare
repentinamente dalle due porte sui nemici impacciati dal carico delle
fascine. Risultò che, per la posizione a noi vantaggiosa, per
l'inesperienza e la stanchezza degli avversari, per il valore e
l'addestramento dei nostri nelle battaglie precedenti, i nemici non
ressero neppure al primo assalto e volsero subito le spalle. I nostri,
ancora freschi, li raggiunsero mentre erano in difficoltà e ne fecero
strage; i superstiti li inseguirono, i cavalieri e se ne lasciarono
sfuggire ben pochi. Così, contemporaneamente, Sabino venne informato della
battaglia navale e Cesare della vittoria del suo legato. Immediatamente,
tutti gli altri popoli si sottomisero a Titurio. Infatti, lo spirito dei
Galli è entusiasta e pronto a dichiarare guerra, ma il loro animo è
fragile e privo di fermezza nel sopportare le disgrazie.
[20
All'incirca nello stesso tempo P. Crasso giunse in Aquitania, regione che,
come si è visto, deve essere considerata, per estensione e per numero di
abitanti, una delle tre parti della Gallia. Crasso, conscio di dover
affrontare un conflitto nella regione dove, pochi anni prima, era stato
ucciso il legato L. Valerio Preconino e sconfitto il suo esercito e da
dove aveva cercato scampo il proconsole L. Manlio, dopo aver perduto le
salmerie, si rendeva conto di dover operare con non poca attenzione.
Perciò, provvide alle scorte di grano, si procurò contingenti ausiliari e
cavalleria, arruolò molti soldati valorosi chiamati individualmente da
Tolosa e Narbona, città della limitrofa provincia romana, dopodiché
penetrò nella regione dei Soziati. Saputo del suo arrivo, i Soziati, dopo
aver radunato ingenti truppe di fanteria e la cavalleria, che costituiva
il loro punto di forza, attaccarono il nostro esercito in marcia. Si
scontrarono subito le due cavallerie: la loro venne messa in fuga e la
nostra si lanciò all'inseguimento. Allora i nemici all'improvviso
dispiegarono la fanteria, che avevano piazzato in un vallone per tendere
un'imboscata. Si gettarono addosso ai nostri che si erano disuniti e
riaccesero la mischia.
[21
La battaglia fu lunga e aspra: i Soziati, forti delle vittorie del
passato, ritenevano che dal loro valore dipendesse la salvezza di tutta
l'Aquitania; i nostri, invece, volevano mostrare di che cos'erano capaci
sotto la guida di un giovane, pur senza il comandante e le altre legioni.
Alla fine i nemici, fiaccati dai colpi ricevuti, si ritirarono. Crasso ne
fece strage e, appena giunto alla città dei Soziati, la cinse d'assedio.
Di fronte all'aspra resistenza dei nemici, ricorse alle vinee e alle
torri. I Soziati tentarono prima una sortita, poi provarono a scavare fino
al terrapieno e alle vinee cunicoli (specialità in cui gli Aquitani sono i
più esperti in assoluto, perché nella loro regione si trovano molte
miniere di rame e cave di pietra). Quando, però, si resero conto che i
loro sforzi erano vanificati dalla sorveglianza dei nostri, mandano a
Crasso un'ambasceria per offrire la resa. La loro richiesta viene accolta
ed essi, dietro suo ordine, consegnano le armi.
[22
Ma mentre l'attenzione dei nostri era concentrata sulla consegna delle
armi, dalla parte opposta della città tentò una sortita Adiatuano, il capo
supremo, insieme a seicento fedelissimi, i solduri, come li chiamano i
Galli. La condizione dei solduri è la seguente: fruiscono di tutti gli agi
dell'esistenza insieme alle persone alla cui amicizia si sono votati, ma
se quest'ultime periscono in modo violento, essi devono affrontare lo
stesso destino oppure suicidarsi; finora, a memoria d'uomo, non risulta
che nessuno si sia rifiutato di morire, dopo che era stata uccisa la
persona a cui si era votato. Adiatuano, dunque, tentò una sortita con i
solduri, ma dalla zona fortificata dove si era diretto si levarono grida e
i nostri corsero alle armi. La lotta fu accanita: alla fine Adiatuano
venne ricacciato in città e tuttavia ottenne da Crasso la resa alle stesse
condizioni degli altri.
[23
Ricevute armi e ostaggi, Crasso partì per la regione dei Vocati e dei
Tarusati. Allora i barbari, molto scossi per aver saputo che una città ben
fornita di difese naturali e fortificazioni era caduta nei pochi giorni
successivi all'arrivo dei Romani, iniziarono a mandare ambascerie in tutte
le direzioni, a stringere leghe, a scambiarsi ostaggi, a mobilitare
truppe. Emissari vengono inviati anche ai popoli della Spagna citeriore,
al confine con l'Aquitania: da lì giungono rinforzi e comandanti. Grazie
al loro arrivo riescono a intraprendere le operazioni di guerra con molta
autorità e molte truppe. Come capi, poi, scelgono gli ufficiali che erano
stati sempre al fianco di Q. Sertorio, dotati, si riteneva, di grande
esperienza militare. Costoro, secondo la tecnica dei Romani, incominciano
a occupare i punti chiave, a fortificare l'accampamento, a tagliare i
rifornimenti ai nostri. Crasso, quando si rese conto che non poteva
dividere le sue truppe, troppo esigue, mentre il nemico aveva libertà di
movimento, presidiava le vie di comunicazione, lasciava nell'accampamento
un presidio sufficiente, ostacolava i rifornimenti di grano e di viveri
per i Romani e aumentava ogni giorno i suoi effettivi, ritenne di non
dover ritardare lo scontro. Riferite le sue intenzioni al consiglio di
guerra, quando vide che tutti condividevano il suo parere, fissò il
combattimento per il giorno seguente.
[24
All'alba Crasso spiegò le truppe fuori dal campo e le schierò su duplice
fila, con al centro gli ausiliari, in attesa delle mosse del nemico. Essi,
pur convinti di non correre rischi, vista la loro superiorità numerica, la
loro antica gloria militare e le esigue forze dei nostri, tuttavia
pensavano ancor più sicuro di ottenere la vittoria, senza colpo ferire,
presidiando le vie e tagliando ai nostri i rifornimenti. Se, poi, i
Romani, spinti dalla mancanza di grano, avessero tentato la ritirata, si
proponevano di assalirli mentre, impacciati dalla marcia e dal peso dei
bagagli, erano meno ardimentosi. Tale fu il loro piano, perciò non si
mossero quando i capi romani portarono le truppe fuori dall'accampamento.
Avendo preso atto della situazione, Crasso, visto che la tattica di attesa
dei nemici, scambiata per timore, aveva reso i nostri soldati più animosi
(tutti gridavano che non bisognava perdere altro tempo e che si doveva
marciare sul campo avversario), esortò i suoi tra il fervore generale e
puntò sui nemici.
[25
I nostri, parte riempiendo i fossati, parte lanciando un nugolo di frecce,
costrinsero i difensori ad abbandonare il vallo e le fortificazioni. Pure
gli ausiliari, sul cui apporto Crasso non faceva troppo affidamento,
rifornendo i soldati di pietre e frecce e portando zolle per elevare un
terrapieno, davano l'effettiva impressione di combattere. Ma anche il
nemico lottava con tenacia e coraggio e i dardi, scagliati dall'alto, non
andavano a vuoto. A quel punto i cavalieri, che avevano fatto il giro del
campo nemico, riferirono a Crasso che la porta decumana non era
altrettanto ben difesa ed era facile penetrarvi.
[26
Crasso, esortati i capi della cavalleria a spronare i loro con la promessa
di grandi ricompense, espose il suo piano. Costoro, secondo gli ordini,
portarono fuori dal campo le coorti che lo presidiavano, fresche e
riposate, compirono una lunga deviazione per non essere visti
dall'accampamento nemico e, mentre gli occhi e gli animi di tutti erano
intenti alla battaglia, raggiunsero rapidamente le fortificazioni di cui
si è parlato, le abbatterono e penetrarono nell'accampamento prima che i
nemici potessero scorgerli o capire che cosa stesse accadendo. E quando i
nostri sentirono levarsi da lì clamori, ripresero forza, come spesso
succede quando si spera di vincere, e iniziarono ad attaccare con maggior
vigore. I nemici, circondati da tutti i lati e persa ogni speranza,
cercarono di gettarsi giù dalle fortificazioni e di darsi alla fuga. La
nostra cavalleria li inseguì nei campi, pianeggianti e privi di
vegetazione: di cinquantamila nemici - tali erano stimate le forze
provenienti dall'Aquitania e dai Cantabri - appena un quarto si mise in
salvo. I nostri cavalieri rientrarono all'accampamento a notte fonda.
[27
L'eco della battaglia spinse ad arrendersi e a consegnare spontaneamente
ostaggi a Crasso la maggior parte dei popoli dell'Aquitania. Tra di essi
ricordiamo i Tarbelli, i Bigerrioni, i Ptiani, i Vocati, i Tarusati, gli
Elusati, i Gati, gli Ausci, i Garunni, i Sibuzati e i Cocosati. Poche
genti e le più lontane, confidando nella stagione - l'inverno si stava
avvicinando - trascurarono di farlo.
[28
Quasi contemporaneamente Cesare, sebbene l'estate stesse ormai per finire,
condusse l'esercito nei territori dei Morini e dei Menapi: era convinto di
poter concludere rapidamente le operazioni contro di essi, gli unici due
popoli che, in tutta la Gallia ormai pacificata, ancora erano in armi e
non gli avevano mai mandato ambascerie per chiedere pace. I nemici
adottarono una tattica ben diversa rispetto agli altri Galli. Avevano
visto che, in campo aperto, nazioni molto potenti erano state respinte e
battute dai Romani; perciò, visto che nei loro territori si trovavano
selve e paludi a non finire, vi si radunarono con tutti i loro averi.
Cesare giunse sul limitare di quei boschi e cominciò a fortificare il
campo senza che si scorgesse l'ombra del nemico. Di colpo, mentre i
nostri, sparpagliati, erano intenti ai lavori, i nemici sbucarono da ogni
anfratto della foresta e li assalirono. I Romani presero rapidamente le
armi e li respinsero nelle boscaglie, uccidendone molti. Ma, protratto
eccessivamente l'inseguimento, finirono in luoghi più intricati e subirono
perdite di lieve entità.
[29
Nei giorni seguenti Cesare decise di disboscare la zona e, per impedire al
nemico di attaccare ai fianchi i nostri, inermi e mentre non se
l'aspettavano, dette ordine di ammassare dinnanzi al nemico tutto il
legname tagliato e di disporlo come un vallo su entrambi i lati. In pochi
giorni, con velocità incredibile, era già stato aperto un grande varco. I
nostri tenevano ormai in pugno il bestiame e i primi bagagli dei nemici,
che si ritiravano sempre più nel cuore della foresta, quando scoppiarono
temporali così violenti, da costringere a sospendere i lavori, e le piogge
ininterrotte ci impedirono di tenere più a lungo i soldati sotto le tende.
Così, devastati tutti i campi, incendiati i villaggi e le case isolate,
Cesare ritirò l'esercito e lo acquartierò per l'inverno nella regione
degli Aulerci, dei Lexovi e degli altri popoli che di recente gli avevano
mosso guerra.
|
LIBER QUARTUS
[1] Ea quae secuta est hieme, qui fuit annus Cn. Pompeio, M. Crasso consulibus, Usipetes Germani et item Tencteri magna
[cum] multitudine hominum flumen Rhenum transierunt, non longe a mari, quo Rhenus influit. Causa transeundi fuit quod ab Suebis complures annos exagitati bello premebantur et agri cultura prohibebantur. Sueborum gens est longe maxima et bellicosissima Germanorum omnium. Hi centum pagos habere dicuntur, ex quibus quotannis singula milia armatorum bellandi causa ex finibus educunt. Reliqui, qui domi manserunt, se atque illos alunt; hi rursus in vicem anno post in armis sunt, illi domi remanent. Sic neque agri cultura nec ratio atque usus belli intermittitur. Sed privati ac separati agri apud eos nihil est, neque longius anno remanere uno in loco colendi causa licet. Neque multum frumento, sed maximam partem lacte atque pecore vivunt multum sunt in venationibus; quae res et cibi genere et cotidiana exercitatione et libertate vitae, quod a pueris nullo officio aut disciplina adsuefacti nihil omnino contra voluntatem faciunt, et vires alit et immani corporum magnitudine homines efficit. Atque in eam se consuetudinem adduxerunt ut locis frigidissimis neque vestitus praeter pelles habeant quicquam, quarum propter exiguitatem magna est corporis pars aperta, et laventur in fluminibus.
[2] Mercatoribus est aditus magis eo ut quae bello ceperint quibus vendant habeant, quam quo ullam rem ad se importari desiderent. Quin etiam iumentis, quibus maxime Galli delectantur quaeque impenso parant pretio, Germani importatis non utuntur, sed quae sunt apud eos nata, parva atque deformia, haec cotidiana exercitatione summi ut sint laboris efficiunt. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur, equos eodem remanere vestigio adsuefecerunt, ad quos se celeriter, cum usus est, recipiunt: neque eorum moribus turpius quicquam aut inertius habetur quam ephippiis uti. Itaque ad quemvis numerum ephippiatorum equitum quamvis pauci adire audent. Vinum omnino ad se importari non patiuntur, quod ea re ad laborem ferendum remollescere homines atque effeminari arbitrantur.
[3] Publice maximam putant esse laudem quam latissime a suis finibus vacare agros: hac re significari magnum numerum civitatum suam vim sustinere non posse. Itaque una ex parte a Suebis circiter milia passuum C agri vacare dicuntur. Ad alteram partem succedunt Ubii, quorum fuit civitas ampla atque florens, ut est captus Germanorum; ii paulo, quamquam sunt eiusdem generis, sunt ceteris humaniores, propterea quod Rhenum attingunt multum ad eos mercatores ventitant et ipsi propter propinquitatem
[quod] Gallicis sunt moribus adsuefacti. Hos cum Suebi multis saepe bellis experti propter amplitudinem gravitatem civitatis finibus expellere non potuissent, tamen vectigales sibi fecerunt ac multo humiliores infirmiores redegerunt.
[4] In eadem causa fuerunt Usipetes et Tencteri, quos supra diximus; qui complures annos Sueborum vim sustinuerunt, ad extremum tamen agris expulsi et multis locis Germaniae triennium vagati ad Rhenum pervenerunt, quas regiones Menapii incolebant. Hi ad utramque ripam fluminis agros, aedificia vicosque habebant; sed tantae multitudinis adventu perterriti ex iis aedificiis quae trans flumen habuerant demigraverant, et cis Rhenum dispositis praesidiis Germanos transire prohibebant. Illi omnia experti, cum neque vi contendere propter inopiam navium neque clam transire propter custodias Menapiorum possent, reverti se in suas sedes regionesque simulaverunt et tridui viam progressi rursus reverterunt atque omni hoc itinere una nocte equitatu confecto inscios inopinantes Menapios oppresserunt, qui de Germanorum discessu per exploratores certiores facti sine metu trans Rhenum in suos vicos remigraverant. His interfectis navibus eorum occupatis, prius quam ea pars Menapiorum quae citra Rhenum erat certior fieret, flumen transierunt atque omnibus eorum aedificiis occupatis reliquam partem hiemis se eorum copiis aluerunt.
[5] His de rebus Caesar certior factus et infirmitatem Gallorum veritus, quod sunt in consiliis capiendis mobiles et novis plerumque rebus student, nihil his committendum existimavit. Est enim hoc Gallicae consuetudinis, uti et viatores etiam invitos consistere cogant et quid quisque eorum de quaque re audierit aut cognoverit quaerant et mercatores in oppidis vulgus circumsistat quibus ex regionibus veniant quas ibi res cognoverint pronuntiare cogat. His rebus atque auditionibus permoti de summis saepe rebus consilia ineunt, quorum eos in vestigio paenitere necesse est, cum incertis rumoribus serviant et pleri ad voluntatem eorum ficta respondeant.
[6] Qua consuetudine cognita Caesar, ne graviori bello, occurreret, maturius quam consuerat ad exercitum proficiscitur. Eo cum venisset, ea quas fore suspicatus erat facta cognovit: missas legationes ab non nullis civitatibus ad Germanos invitatos eos uti ab Rheno discederent: omnia quae
[que] postulassent ab se fore parata. Qua spe adducti Germani latius iam vagabantur et in fines Eburonum et Condrusorum, qui sunt Treverorum clientes, pervenerant. Principibus Gallice evocatis Caesar ea quae cognoverat dissimulanda sibi existimavit, eorumque animis permulsis et confirmatis equitatu imperato bellum cum Germanis gerere constituit.
[7] Re frumentaria comparata equitibusque delectis iter in ea loca facere coepit, quibus in locis esse Germanos audiebat. A quibus cum paucorum dierum iter abesset, legati ab iis venerunt, quorum haec fuit oratio: Germanos neque priores populo Romano bellum inferre neque tamen recusare, si lacessantur, quin armis contendant, quod Germanorum consuetudo
[haec] sit a maioribus tradita, Quicumque bellum inferant, resistere neque deprecari. Haec tamen dicere venisse invitos, eiectos domo; si suam gratiam Romani velint, posse iis utiles esse amicos; vel sibi agros attribuant vel patiantur eos tenere quos armis possederint: sese unis Suebis concedere, quibus ne di quidem immortales pares esse possint; reliquum quidem in terris esse neminem quem non superare possint.
[8] Ad haec Caesar quae visum est respondit; sed exitus fuit orationis: sibi nullam cum iis amicitiam esse posse, si in Gallia remanerent; neque verum esse, qui suos fines tueri non potuerint alienos occupare; neque ullos in Gallia vacare agros qui dari tantae praesertim multitudini sine iniuria possint; sed licere, si velint, in Ubiorum finibus considere, quorum sint legati apud se et de Sueborum iniuriis querantur et a se auxilium petant: hoc se Ubiis imperaturus.
[9] Legati haec se ad suos relaturos dixerunt et re deliberata post diem tertium ad Caesarem reversuros: interea ne propius se castra moveret petierunt. Ne id quidem Caesar ab se impetrari posse dixit. Cognoverat enim magnam partem equitatus ab iis aliquot diebus ante praedandi frumentandi causa ad Ambivaritos trans Mosam missam: hos expectari equites atque eius rei causa moram interponi arbitrabatur.
[10]
[Mosa profluit ex monte Vosego, qui est in finibus Lingonum, et parte quadam ex Rheno recepta, quae appellatur Vacalus insulam efficit Batavorum, in Oceanum influit neque longius ab Oceano milibus passuum LXXX in Rhenum influit. Rhenus autem oritur ex Lepontiis, qui Alpes incolunt, et longo spatio per fines Nantuatium, Helvetiorum, Sequanorum, Mediomatricorum, Tribocorum, Treverorum citatus fertur et, ubi Oceano adpropinquavit, in plures diffluit partes multis ingentibus insulis effectis, quarum pars magna a feris barbaris nationibus incolitur, ex quibus sunt qui piscibus atque ovis avium vivere existimantur, multis capitibus in Oceanum influit.]
[11] Caesar cum ab hoste non amplius passuum XII milibus abesset, ut erat constitutum, ad eum legati revertuntur; qui in itinere congressi magnopere ne longius progrederetur orabant. Cum id non impetrassent, petebant uti ad eos
[equites] qui agmen antecessissent praemitteret eos pugna prohiberet, sibique ut potestatem faceret in Ubios legatos mittendi; quorum si principes ac senatus sibi iure iurando fidem fecisset, ea condicione quae a Caesare ferretur se usuros ostendebant: ad has res conficiendas sibi tridui spatium daret. Haec omnia Caesar eodem illo pertinere arbitrabatur ut tridui mora interposita equites eorum qui abessent reverterentur; tamen sese non longius milibus passuum IIII aquationis causa processurum eo die dixit: huc postero die quam frequentissimi convenirent, ut de eorum postulatis cognosceret. Interim ad praefectos, qui cum omni equitatu antecesserant, mittit qui nuntiarent ne hostes proelio lacesserent, et si ipsi lacesserentur, sustinerent quoad ipse cum exercitu propius accessisset.
[12] At hostes, ubi primum nostros equites conspexerunt, quorum erat V milium numerus, cum ipsi non amplius DCCC equites haberent, quod ii qui frumentandi causa erant trans Mosam profecti nondum redierant, nihil timentibus nostris, quod legati eorum paulo ante a Caesare discesserant atque is dies indutiis erat ab his petitus, impetu facto celeriter nostros perturbaverunt; rursus his resistentibus consuetudine sua ad pedes desiluerunt subfossis equis compluribus nostris deiectis reliquos in fugam coniecerunt atque ita perterritos egerunt ut non prius fuga desisterent quam in conspectum agminis nostri venissent. In eo proelio ex equitibus nostris interficiuntur IIII et LXX, in his vir fortissimus Piso Aquitanus, amplissimo genere natus, cuius avus in civitate sua regnum obtinuerat amicus a senatu nostro appellatus. Hic cum fratri intercluso ab hostibus auxilium ferret, illum ex periculo eripuit, ipse equo vulnerato deiectus, quoad potuit, fortissime restitit; cum circumventus multis vulneribus acceptis cecidisset atque id frater, qui iam proelio excesserat, procul animadvertisset, incitato equo se hostibus obtulit atque interfectus est.
[13] Hoc facto proelio Caesar neque iam sibi legatos audiendos neque condiciones accipiendas arbitrabatur ab iis qui per dolum atque insidias petita pace ultro bellum intulissent; expectare vero dum hostium copiae augerentur equitatus reverteretur summae dementiae esse iudicabat, et cognita Gallorum infirmitate quantum iam apud eos hostes uno proelio auctoritatis essent consecuti sentiebat; quibus ad consilia capienda nihil spatii dandum existimabat. His constitutis rebus et consilio cum legatis et quaestore communicato, ne quem diem pugnae praetermitteret, oportunissima res accidit, quod postridie eius diei mane eadem et perfidia et simulatione usi Germani frequentes, omnibus principibus maioribusque natu adhibitis, ad eum in castra venerunt, simul, ut dicebatur, sui purgandi causa, quod contra atque esset dictum et ipsi petissent, proelium pridie commisissent, simul ut, si quid possent, de indutiis fallendo impetrarent. Quos sibi Caesar oblatos gavisus illos retineri iussit; ipse omnes copias castris D eduxit equitatumque, quod recenti proelio perterritum esse existimabat, agmen subsequi iussit.
[14] Acie triplici instituta et celeriter VIII milium itinere confecto, prius ad hostium castra pervenit quam quid ageretur Germani sentire possent. Qui omnibus rebus subito perterriti et celeritate adventus nostri et discessu suorum, neque consilii habendi neque arma capiendi spatio dato perturbantur, copiasne adversus hostem ducere an castra defendere an fuga salutem petere praestaret. Quorum timor cum fremitu et concursu significaretur, milites nostri pristini diei perfidia incitati in castra inruperunt. Quo loco qui celeriter arma capere potuerunt paulisper nostris restiterunt atque inter carros impedimentaque proelium commiserunt; at reliqua multitudo puerorum mulierumque (nam cum omnibus suis domo excesserant Rhenum transierant) passim fugere coepit, ad quos consectandos Caesar equitatum misit.
[15] Germani post tergum clamore audito, cum suos interfiei viderent, armis abiectis signis militaribus relictis se ex castris eiecerunt, et cum ad confluentem Mosae et Rheni pervenissent, reliqua fuga desperata, magno numero interfecto, reliqui se in flumen praecipitaverunt atque ibi timore, lassitudine, vi fluminis oppressi perierunt. Nostri ad unum omnes incolumes, perpaucis vulneratis, ex tanti belli timore, cum hostium numerus capitum CCCCXXX milium fuisset, se in castra receperunt. Caesar iis quos in castris retinuerat discedendi potestatem fecit. Illi supplicia cruciatusque Gallorum veriti, quorum agros vexaverant, remanere se apud eum velle dixerunt. His Caesar libertatem concessit.
[16] Germanico bello confecto multis de causis Caesar statuit sibi Rhenum esse transeundum; quarum illa fuit iustissima quod, cum videret Germanos tam facile impelli ut in Galliam venirent, suis quoque rebus eos timere voluit, cum intellegerent et posse et audere populi Romani exercitum Rhenum transire. Accessit etiam quod illa pars equitatus Usipetum et Tencterorum, quam supra commemoravi praedandi frumentandi causa Mosam transisse neque proelio interfuisse, post fugam suorum se trans Rhenum in fines Sugambrorum receperat seque cum his coniunxerat. Ad quos cum Caesar nuntios misisset, qui postularent eos qui sibi Galliae bellum intulissent sibi dederent, responderunt: populi Romani imperium Rhenum finire; si se invito Germanos in Galliam transire non aequum existimaret, cur sui quicquam esse imperii aut potestatis trans Rhenum postularet? Ubii autem, qui uni ex Transrhenanis ad Caesarem legatos miserant, amicitiam fecerant, obsides dederant, magnopere orabant ut sibi auxilium ferret, quod graviter ab Suebis premerentur; vel, si id facere occupationibus rei publicae prohiberetur, exercitum modo Rhenum transportaret: id sibi ad auxilium spemque reliqui temporis satis futurum. Tantum esse nomen atque opinionem eius exercitus Ariovisto pulso et hoc novissimo proelio facto etiam ad ultimas Germanorum nationes, uti opinione et amicitia populi Romani tuti esse possint. Navium magnam copiam ad transportandum exercitum pollicebantur.
[17] Caesar his de causis quas commemoravi Rhenum transire decrevat; sed navibus transire neque satis tutum esse arbitrabatur neque suae neque populi Romani dignitatis esse statuebat. Itaque, etsi summa difficultas faciendi pontis proponebatur propter latitudinem, rapiditatem altitudinemque fluminis, tamen id sibi contendendum aut aliter non traducendum exercitum existimabat. Rationem pontis hanc instituit. Tigna bina sesquipedalia. paulum ab imo praeacuta dimensa ad altitudinem fluminis intervallo pedum duorum inter se iungebat. Haec cum machinationibus immissa in flumen defixerat fistucisque adegerat, non sublicae modo derecte ad perpendiculum, sed prone ac fastigate, ut secundum naturam fluminis procumberent, iis item contraria duo ad eundem modum iuncta intervallo pedum quadragenum ab inferiore parte contra vim atque impetu fluminis conversa statuebat. Haec utraque insuper bipedalibus trabibus immissis, quantum eorum tignorum iunctura distabat, binis utrimque fibulis ab extrema parte distinebantur; quibus disclusis atque in contrariam partem revinctis, tanta erat operis firmitudo atque ea rerum natura ut, quo maior vis aquae se incitavisset, hoc artius inligata tenerentur. Haec derecta materia iniecta contexebantur ac longuriis cratibusque consternebantur; ac nihilo setius sublicae et ad inferiorem partem fluminis oblique agebantur, quae pro ariete subiectae et cum omni opere coniunctae vim fluminis exciperent, et aliae item supra pontem mediocri spatio, ut, si arborum trunci sive naves deiciendi operis causa essent a barbaris missae, his defensoribus earum rerum vis minueretur neu ponti nocerent.
[18] Diebus X, quibus materia coepta erat comportari, omni opere effecto exercitus traducitur. Caesar ad utramque partem pontis firmo praesidio relicto in fines Sugambrorum contendit. Interim a compluribus civitatibus ad eum legati veniunt; quibus pacem atque amicitiam petentibus liberaliter respondet obsidesque ad se adduci iubet. At Sugambri, ex eo tempore quo pons institui coeptus est fuga comparata, hortantibus iis quos ex Tencteris atque Usipetibus apud se habebant, finibus suis excesserant suaque omnia exportaverant seque in solitudinem ac silvas abdiderant.
[19] Caesar paucos dies in eorum finibus moratus, omnibus vicis aedificiisque incensis frumentisque succisis, se in fines Ubiorum recepit atque his auxilium suum pollicitus, si a Suebis premerentur, haec ab iis cognovit: Suebos, postea quam per exploratores pontem fieri comperissent, more suo concilio habito nuntios in omnes partes dimisisse, uti de oppidis demigrarent, liberos, uxores suaque omnia in silvis deponerent atque omnes qui arma ferre possent unum in locum convenirent. Hunc esse delectum medium fere regionum earum quas Suebi obtinerent; hic Romanorum adventum expectare atque ibi decertare constituisse. Quod ubi Caesar comperit, omnibus iis rebus confectis, quarum rerum causa exercitum traducere constituerat, ut Germanis metum iniceret, ut Sugambros ulcisceretur, ut Ubios obsidione liberaret, diebus omnino XVIII trans Rhenum consumptis, satis et ad laudem et ad utilitatem profectum arbitratus se in Galliam recepit pontemque rescidit.
[20] Exigua parte aestatis reliqua Caesar, etsi in his locis, quod omnis Gallia ad septentriones vergit, maturae sunt hiemes, tamen in Britanniam proficisci contendit, quod omnibus fere Gallicis bellis hostibus nostris inde subministrata auxilia intellegebat, et si tempus anni ad bellum gerendum deficeret, tamen magno sibi usui fore arbitrabatur, si modo insulam adiisset, genus hominum perspexisset, loca, portus, aditus cognovisset; quae omnia fere Gallis erant incognita. Neque enim temere praeter mercatores illo adit quisquam, neque his ipsis quicquam praeter oram maritimam atque eas regiones quae sunt contra Galliam notum est. Itaque vocatis ad se undique mercatoribus, neque quanta esset insulae magnitudo neque quae aut quantae nationes incolerent, neque quem usum belli haberent aut quibus institutis uterentur, neque qui essent ad maiorem navium multitudinem idonei portus reperire poterat.
[21] Ad haec cognoscenda, prius quam periculum faceret, idoneum esse arbitratus C. Volusenum cum navi longa praemittit. Huic mandat ut exploratis omnibus rebus ad se quam primum revertatur. Ipse cum omnibus copiis in Morinos proficiscitur, quod inde erat brevissimus in Britanniam traiectus. Huc naves undique ex finitimis regionibus et quam superiore aestate ad Veneticum bellum fecerat classem iubet convenire. Interim, consilio eius cognito et per mercatores perlato ad Britannos, a compluribus insulae civitatibus ad eum legati veniunt, qui polliceantur obsides dare atque imperio populi Romani obtemperare. Quibus auditis, liberaliter pollicitus hortatusque ut in ea sententia permanerent, eos domum remittit et cum iis una Commium, quem ipse Atrebatibus superatis regem ibi constituerat, cuius et virtutem et consilium probabat et quem sibi fidelem esse arbitrabatur cuiusque auctoritas in his regionibus magni habebatur, mittit. Huic imperat quas possit adeat civitates horteturque ut populi Romani fidem sequantur seque celeriter eo venturum nuntiet. Volusenus perspectis regionibus omnibus quantum ei facultatis dari potuit, qui navi egredi ac se barbaris committere non auderet, V. die ad Caesarem revertitur quaeque ibi perspexisset renuntiat.
[22] Dum in his locis Caesar navium parandarum causa moratur, ex magna parte Morinorum ad eum legati venerunt, qui se de superioris temporis consilio excusarent, quod homines barbari et nostrae consuetudinis imperiti bellum populo Romano fecissent, seque ea quae imperasset facturos pollicerentur. Hoc sibi Caesar satis oportune accidisse arbitratus, quod neque post tergum hostem relinquere volebat neque belli gerendi propter anni tempus facultatem habebat neque has tantularum rerum occupationes Britanniae anteponendas iudicabat, magnum iis numerum obsidum imperat. Quibus adductis eos in fidem recipit. Navibus circiter LXXX onerariis coactis contractisque, quot satis esse ad duas transportandas legiones existimabat, quod praeterea navium longarum habebat quaestori, legatis praefectisque distribuit. Huc accedebant XVIII onerariae naves, quae ex eo loco a milibus passuum VIII vento tenebantur quo minus in eundem portum venire possent: has equitibus tribuit. Reliquum exercitum Q. Titurio Sabino et L. Aurunculeio Cottae legatis in Menapios atque in eos pagos Morinorum a quibus ad eum legati non venerant ducendum dedit. P. Sulpicium Rufum legatum cum eo praesidio quod satis esse arbitrabatur portum tenere iussit.
[23] His constitutis rebus, nactus idoneam ad navigandum tempestatem III. fere vigilia solvit equitesque in ulteriorem portum progredi et naves conscendere et se sequi iussit. A quibus cum paulo tardius esset administratum, ipse hora diei circiter IIII. cum primis navibus Britanniam attigit atque ibi in omnibus collibus eitas hostium copias armatas conspexit. Cuius loci haec erat natura atque ita montibus angustis mare continebatur, uti ex locis superioribus in litus telum adigi posset. Hunc ad egrediendum nequaquam idoneum locum arbitratus, dum reliquae naves eo convenirent ad horam nonam in ancoris expectavit. Interim legatis tribunisque militum convocatis et quae ex Voluseno cognovisset et quae fieri vellet ostendit monuitque, ut rei militaris ratio, maximeque ut maritimae res postularent, ut, cum celerem atque instabilem motum haberent, ad nutum et ad tempus D omnes res ab iis administrarentur. His dimissis, et VII ab eo loco progressus aperto ac plano litore naves constituit.
[24] At barbari, consilio Romanorum cognito praemisso equitatu et essedariis, quo plerumque genere in proeliis uti consuerunt, reliquis copiis subsecuti nostros navibus egredi prohibebant. Erat ob has causas summa difficultas, quod naves propter magnitudinem nisi in alto constitui non poterant, militibus autem, ignotis locis, impeditis manibus, magno et gravi onere armorum oppressis simul et de navibus desiliendum et in auctibus consistendum et cum hostibus erat pugnandum, cum illi aut ex arido aut paulum in aquam progressi omnibus membris expeditis, notissimis locis, audacter tela coicerent et equos insuefactos incitarent. Quibus rebus nostri perterriti atque huius omnino generis pugnae imperiti, non eadem alacritate ac studio quo in pedestribus uti proeliis consuerant utebantur.
[25] Quod ubi Caesar animadvertit, naves longas, quarum et species erat barbaris inusitatior et motus ad usum expeditior, paulum removeri ab onerariis navibus et remis incitari et ad latus apertum hostium constitui atque inde fundis, sagittis, tormentis hostes propelli ac submoveri iussit; quae res magno usui nostris fuit. Nam et navium figura et remorum motu et inusitato genere tormentorum permoti barbari constiterunt ac paulum modo pedem rettulerunt. Atque nostris militibus cunctantibus, maxime propter altitudinem maris, qui X legionis aquilam gerebat, obtestatus deos, ut ea res legioni feliciter eveniret, ' desilite', inquit, ' milites, nisi vultis aquilam hostibus prodere; ego certe meum rei publicae atque imperatori officium praestitero.' Hoc cum voce magna dixisset, se ex navi proiecit atque in hostes aquilam ferre coepit. Tum nostri cohortati inter se, ne tantum dedecus admitteretur, universi ex navi desiluerunt. Hos item ex proximis primi navibus cum conspexissent, subsecuti hostibus adpropinquaverunt.
[26] Pugnatum est ab utrisque acriter. Nostri tamen, quod neque ordines servare neque firmiter insistere neque signa subsequi poterant atque alius alia ex navi quibuscumque signis occurrerat se adgregabat, magnopere perturbabantur; hostes vero, notis omnibus vadii, ubi ex litore aliquos singulares ex navi egredientes conspexerant, incitatis equis impeditos adoriebantur, plures paucos circumsistebant, alii ab latere aperto in universos tela coiciebant. Quod cum animadvertisset Caesar, scaphas longarum navium, item speculatoria navigia militibus compleri iussit, et quos laborantes conspexerat, his subsidia submittebat. Nostri, simul in arido constiterunt, suis omnibus consecutis, in hostes impetum fecerunt atque eos in fugam dederunt; neque longius prosequi potuerunt, quod equites cursum tenere atque insulam capere non potuerant. Hoc unum ad pristinam fortunam Caesari defuit.
[27] Hostes proelio superati, simul atque se ex fuga receperunt, statim ad Caesarem legatos de pace miserunt; obsides sese daturos quaeque imperasset facturos polliciti sunt. Una cum his legatis Commius Atrebas venit, quem supra demonstraveram a Caesare in Britanniam praemissum. Hunc illi e navi egressum, cum ad eos oratoris modo Caesaris mandata deferret, comprehenderant atque in vincula coniecerant; tum proelio facto remiserunt et in petenda pace eius rei culpam in multitudinem contulerunt et propter imprudentiam ut ignosceretur petiverunt. Caesar questus quod, cum ultro in continentem legatis missis pacem ab se petissent, bellum sine causa intulissent, ignoscere se imprudentiae dixit obsidesque imperavit; quorum illi partem statim dederunt, partem ex longinquioribus locis arcessitam paucis diebus sese daturos dixerunt. Interea suos in agros remigrare iusserunt, principesque undique convenire et se civitatesque suas Caesari commendare coeperunt.
[28] His rebus pace confirmata, post diem quartum quam est in Britanniam ventum naves XVIII, de quibus supra demonstratum est, quae equites sustulerant, ex superiore portu leni vento solverunt. Quae cum adpropinquarent Britanniae et ex castris viderentur, tanta tempestas subito coorta est ut nulla earum cursum tenere posset, sed aliae eodem unde erant profectae referrentur, aliae ad inferiorem partem insulae, quae est propius solis occasum, magno suo cum periculo deicerentur; quae tamen ancoris iactis cum fluctibus complerentur, necessario adversa nocte in altum provectae continentem petierunt.
[29] Eadem nocte accidit ut esset luna plena, qui dies a maritimos aestus maximos in Oceano efficere consuevit, nostrisque id erat incognitum. Ita uno tempore et longas naves,
[quibus Caesar exercitum transportandum curaverat,] quas Caesar in aridum subduxerat, aestus complebat, et onerarias, quae ad ancoras erant deligatae, tempestas adflictabat, neque ulla nostris facultas aut administrandi aut auxiliandi dabatur. Compluribus navibus fractis, reliquae cum essent funibus, ancoris reliquisque armamentis amissis ad navigandum inutiles, magna, id quod necesse erat accidere, totius exercitus perturbatio facta est. Neque enim naves erant aliae quibus reportari possent, et omnia deerant quae ad reficiendas naves erant usui, et, quod omnibus constabat hiemari in Gallia oportere, frumentum in his locis in hiemem provisum non erat.
[30] Quibus rebus cognitis, principes Britanniae, qui post proelium ad Caesarem convenerant, inter se conlocuti, cum et equites et naves et frumentum Romanis deesse intellegerent et paucitatem militum ex castrorum exiguitate cognoscerent, quae hoc erant etiam angustior quod sine impedimentis Caesar legiones transportaverat, optimum factu esse duxerunt rebellione facta frumento commeatuque nostros prohibere et rem in hiemem producere, quod his superatis aut reditu interclusis neminem postea belli inferendi causa in Britanniam transiturum confidebant. Itaque rursus coniuratione facta paulatim ex castris discedere et suos clam ex agris deducere coeperunt.
[31] At Caesar, etsi nondum eorum consilia cognoverat, tamen et ex eventu navium suarum et ex eo quod obsides dare intermiserant fore id quod accidit suspicabatur. Itaque ad omnes casus subsidia comparabat. Nam et frumentum ex agris cotidie in castra conferebat et, quae gravissime adflictae erant naves, earum materia atque aere ad reliquas reficiendas utebatur et quae ad eas res erant usui ex continenti comportari iubebat. Itaque, cum summo studio a militibus administraretur, XII navibus amissis, reliquis ut navigari satis commode posset effecit.
[32] Dum ea geruntur, legione ex consuetudine una frumentatum missa, quae appellabatur VII, neque ulla ad id tempus belli suspicione interposita, cum pars hominum in agris remaneret, pars etiam in castra ventitaret, ii qui pro portis castrorum in statione erant Caesari nuntiaverunt pulverem maiorem quam consuetudo ferret in ea parte videri quam in partem legio iter fecisset. Caesar id quod erat suspicatus aliquid novi a barbaris initum consilii, cohortes quae in statione erant secum in eam partem proficisci, ex reliquis duas in stationem succedere, reliquas armari et confestim sese subsequi iussit. Cum paulo longius a castris processisset, suos ab hostibus premi atque aegre sustinere et conferta legione ex omnibus partibus tela coici animadvertit. Nam quod omni ex reliquis partibus demesso frumento pars una erat reliqua, suspicati hostes huc nostros esse venturos noctu in silvis delituerant; tum dispersos depositis armis in metendo occupatos Subito adorti paucis interfectis reliquos incertis ordinibus perturbaverant, simul equitatu atque essedis circumdederant.
[33] Genus hoc est ex essedis pugnae. Primo per omnes partes perequitant et tela coiciunt atque ipso terrore equorum et strepitu rotarum ordines plerumque perturbant, et cum se inter equitum turmas insinuaverunt, ex essedis desiliunt et pedibus proeliantur. Aurigae interim paulatim ex proelio excedunt atque ita currus conlocant ut, si illi a multitudine hostium premantur, expeditum ad quos receptum habeant. Ita mobilitatem equitum, stabilitatem peditum in proeliis praestant, ac tantum usu cotidiano et exercitatione efficiunt uti in declivi ac praecipiti loco incitatos equos sustinere et brevi moderari ac flectere et per temonem percurrere et in iugo insistere et se inde in currus citissime recipere consuerint.
[34] Quibus rebus perturbatis nostris
[novitate pugnae] tempore oportunissimo Caesar auxilium tulit: namque eius adventu hostes constiterunt, nostri se ex timore receperunt. Quo facto, ad lacessendum hostem et committendum proelium alienum esse tempus arbitratus suo se loco continuit et brevi tempore intermisso in castra legiones reduxit. Dum haec geruntur, nostris omnibus occupatis qui erant in agris reliqui discesserunt. Secutae sunt continuos complures dies tempeststes, quae et nostros in castris continerent et hostem a pugna prohiberent. Interim barbari nuntios in omnes partes dimiserunt paucitatemque nostrorum militum suis praedicaverunt et quanta praedae faciendae atque in perpetuum sui liberandi facultas daretur, si Romanos castris expulissent, demonstraverunt. His rebus celeriter magna multitudine peditatus equitatusque coacta ad castra venerunt.
[35] Caesar, etsi idem quod superioribus diebus acciderat fore videbat, ut, si essent hostes pulsi, celeritate periculum effugerent, tamen nactus equites circiter XXX, quos Commius Atrebas, de quo ante dictum est, secum transportaverat, legiones in acie pro castris constituit. Commisso proelio diutius nostrorum militum impetum hostes ferre non potuerunt ac terga verterunt. Quos tanto spatio secuti quantum cursu et viribus efficere potuerunt, complures ex iis occiderunt, deinde omnibus longe lateque aedificiis incensis se in castra receperunt.
[36] Eodem die legati ab hostibus missi ad Caesarem de pace venerunt. His Caesar numerum obsidum quem ante imperaverat duplicavit eosque in continentem adduci iussit, quod propinqua die aequinoctii infirmis navibus hiemi navigationem subiciendam non existimabat. Ipse idoneam tempestatem nactus paulo post mediam noctem naves solvit, quae omnes incolumes ad continentem pervenerunt; sed ex iis onerariae duae eosdem portus quos reliquae capere non potuerunt et paulo infra delatae sunt.
[37] Quibus ex navibus cum essent eiti milites circiter CCC atque in castra contenderent, Morini, quos Caesar in Britanniam proficiscens pacatos reliquerat, spe praedae adducti primo non ita magno suorum numero circumsteterunt ac, si sese interfici nollent, arma ponere iusserunt. Cum illi orbe facto sese defenderent, celeriter ad clamorem hominum circiter milia VI convenerunt; qua re nuntiata, Caesar omnem ex castris equitatum suis auxilio misit. Interim nostri milites impetum hostium sustinuerunt atque amplius horis IIII fortissime pugnaverunt et paucis vulneribus acceptis complures ex iis occiderunt. Postea vero quam equitatus noster in conspectum venit, hostes abiectis armis terga verterunt magnusque eorum numerus est occisus.
[38] Caesar postero die T. Labienum legatum cum iis legionibus quas ex Britannia reduxerat in Morinos qui rebellionem fecerant misit. Qui cum propter siccitates paludum quo se reciperent non haberent, quo perfugio superiore anno erant usi, omnes fere in potestatem Labieni venerunt. At Q. Titurius et L. Cotta legati, qui in Menapiorum fines legiones duxerant, omnibus eorum agris vastatis, frumentis succisis, aedificiis incensis, quod Menapii se omnes in densissimas silvas abdiderant, se ad Caesarem receperunt. Caesar in Belgis omnium legionum hiberna constituit. Eo duae omnino civitates ex Britannia obsides miserunt, reliquae neglexerunt. His rebus gestis ex litteris Caesaris dierum XX supplicatio a senatu decreta est. |
LIBRO QUARTO
[1
L'inverno successivo, nell'anno di consolato di Cn. Pompeo e M. Crasso,
gli Usipeti e pure i Tenteri, popoli germanici, con un gran numero di
uomini oltrepassarono il Reno, non lontano dal mare in cui il fiume
sfocia. Motivo della loro migrazione fu che, tormentati per molti anni
dagli attacchi degli Svevi, si trovavano in difficoltà e non potevano
coltivare i loro campi. Gli Svevi, tra tutti i Germani, sono il popolo più
numeroso ed agguerrito in assoluto. Si dice che siano formati da cento
tribù: ognuna fornisce annualmente mille soldati, che vengono portati a
combattere fuori dai loro territori contro i popoli vicini. Chi è rimasto
a casa, provvede a mantenere sé e gli altri; l'anno seguente si
avvicendano: quest'ultimi vanno a combattere, i primi rimangono in patria.
Così non tralasciano né l'agricoltura, né la teoria e la pratica delle
armi. E non hanno terreni privati o divisi, nessuno può rimanere più di un
anno nello stesso luogo per praticare l'agricoltura. Si nutrono poco di
frumento, vivono soprattutto di latte e carne ovina, praticano molto la
caccia. Il tipo di alimentazione, l'esercizio quotidiano e la vita libera
che conducono (fin da piccoli, infatti, non sono sottoposti ad alcun
dovere o disciplina e non fanno assolutamente. nulla contro la propria
volontà) accrescono le loro forze e li rendono uomini dal fisico
imponente. Sono abituati a lavarsi nei fiumi e a portare come vestito, in
quelle regioni freddissime, solo delle pelli che, piccole come sono,
lasciano scoperta gran parte del corpo.
[2
Concedono libero accesso ai mercanti, più per aver modo di vendere il loro
bottino di guerra che per desiderio di comprare prodotti d'importazione.
Anzi, i Germani non fanno uso di puledri importati (al contrario dei
Galli, che per essi hanno una vera passione e li acquistano a caro
prezzo), ma sfruttano i cavalli della loro regione, piccoli e sgraziati,
rendendoli con l'esercizio quotidiano robustissimi animali da fatica.
Durante gli scontri di cavalleria spesso smontano da cavallo e combattono
a piedi; hanno addestrato a rimanere sul posto i cavalli, presso i quali
rapidamente riparano, se necessario; secondo il loro modo di vedere, non
c'è niente di più vergognoso o inerte che usare la sella. Così, per quanto
pochi siano, osano attaccare qualsiasi gruppo di cavalieri che montino su
sella, non importa quanto numeroso. Non permettono assolutamente
l'importazione del vino, perché ritengono che indebolisca la capacità di
sopportare la fatica e che infiacchisca gli animi.
[3
Reputano vanto principale per la propria nazione che le regioni di
confine, per il tratto più ampio possibile, siano disabitate: è segno che
moltissimi popoli non sono in grado di resistere alla loro forza militare.
A tal proposito corre voce che, in una zona di confine degli Svevi, le
campagne siano spopolate per seicento miglia. Un'altra parte del loro
territorio confina con gli Ubi, popolo un tempo numeroso e fiorente, per
quanto possano esserlo i Germani. Gli Ubi sono un po' più civili rispetto
alle altre genti della loro razza perché, vivendo lungo il Reno, sono
visitati di frequente dai mercanti e, per ragioni di vicinanza, hanno
assorbito i costumi dei Galli. Gli Svevi li avevano spesso affrontati in
guerra, ma non erano riusciti a scacciarli dalle loro terre per via del
loro numero e della loro importanza; tuttavia, li avevano costretti a
versare tributi, rendendoli molto meno potenti e forti.
[4
Nella stessa situazione si trovarono gli Usipeti e i Tenteri, già
nominati, che ressero per parecchi anni agli assalti degli Svevi, ma alla
fine vennero scacciati dai loro territori e, dopo aver vagato tre anni per
molte regioni della Germania, giunsero al Reno, nel paese dei Menapi che
possedevano campi, case e villaggi su entrambe le rive del fiume; i
Menapi, atterriti dall'arrivo di una massa così numerosa, abbandonarono
gli edifici sull'altra sponda del fiume e, disposti presidi al di qua del
Reno, cercavano di impedire il passaggio ai Germani. Quest'ultimi, dopo
tentativi d'ogni sorta, non potendo combattere perché a corto di navi, né
riuscendo a passare di nascosto per la sorveglianza dei Menapi, finsero di
rientrare in patria, ma dopo tre giorni di cammino tornarono indietro: in
una sola notte la cavalleria coprì tutto il tragitto e piombò inattesa
sugli ignari Menapi, che erano rientrati nei loro villaggi d'oltre Reno
senza timore, perché i loro esploratori avevano confermato la partenza dei
nemici. I Germani fecero strage dei Menapi e, impadronitisi delle loro
navi, attraversarono il fiume prima che sull'altra sponda giungesse
notizia dell'accaduto; occupati tutti gli edifici dei Menapi, si servirono
delle loro provviste per la restante parte dell'inverno.
[5
Informato di tali avvenimenti, Cesare, che temeva la debolezza di
carattere dei Galli, volubili nel prendere decisioni e per lo più
desiderosi di rivolgimenti, stimò di non doversi assolutamente fidare di
essi. I Galli, infatti, hanno la seguente abitudine: costringono, anche
loro malgrado, i viandanti a fermarsi e si informano su ciò che ciascuno
di essi ha saputo o sentito su qualsiasi argomento; nelle città, la gente
attornia i mercanti e li obbliga a dire da dove provengano e che cosa lì
abbiano saputo; poi, sulla scorta delle voci e delle notizie udite, spesso
decidono su questioni della massima importanza e devono ben presto
pentirsene, perché prestano fede a dicerie infondate, in quanto la maggior
parte degli interpellati risponde cose non vere pur di compiacerli.
[6
Cesare, che conosceva tale abitudine, per non andare incontro a una guerra
troppo pesante, partì alla volta dell'esercito prima del solito. Appena
giunto, apprese che i suoi sospetti si erano avverati: parecchi popoli
avevano inviato ambascerie ai Germani, chiedendo che varcassero il Reno e
promettendo di esaudire ogni loro richiesta. I Germani, attratti da tali
speranze, già si stavano spingendo più lontano ed erano pervenuti nelle
terre degli Eburoni e dei Condrusi, clienti dei Treveri. Cesare convocò i
principi della Gallia, ma ritenne opportuno dissimulare ciò di cui era
invece al corrente; li blandì, li rassicurò, chiese i contingenti di
cavalleria e prese la risoluzione di muovere guerra ai Germani.
[7
Preparate le scorte di grano e arruolati i cavalieri, marciò verso i
territori in cui era segnalata la presenza dei Germani. Cesare si trovava
a pochi giorni di distanza, quando gli si presentarono emissari dei
Germani che parlarono nei termini seguenti: non erano i Germani a muovere
per primi guerra al popolo romano, ma non avrebbero rinunciato allo
scontro, se provocati, perché avevano la consuetudine, tramandata dai
padri, di difendersi e di non implorare gli aggressori, chiunque essi
fossero. Tuttavia precisavano di esser giunti contro il loro volere,
scacciati dalla patria; se i Romani volevano il loro sostegno, i Germani
avrebbero potuto diventare utili alleati; chiedevano l'assegnazione di
nuovi territori oppure il permesso di mantenere le regioni occupate con le
armi. Erano inferiori solo agli Svevi, che neppure gli dèi immortali
potevano uguagliare; ma di tutti gli altri popoli sulla terra non ce n'era
uno che i Germani non potessero superare.
[8
A tali parole Cesare rispose come gli sembrò più opportuno; ma ecco come
terminò il suo discorso: non poteva stringere con loro alcuna alleanza, se
rimanevano in Gallia; e non era giusto che occupasse le terre altrui chi
non era riuscito a difendere le proprie; in Gallia non c'erano regioni
libere da poter assegnare - tanto meno a un gruppo così numeroso - senza
danneggiare nessuno, ma concedeva loro, se lo volevano, di stabilirsi nei
territori degli Ubi, che gli avevano inviato emissari per lamentarsi dei
soprusi degli Svevi e per chiedergli aiuto: ne avrebbe dato ordine agli
Ubi.
[9
I membri dell'ambasceria dissero che avrebbero riferito e che si sarebbero
ripresentati dopo tre giorni con la risposta. Chiesero a Cesare, però, di
non avanzare ulteriormente nel frattempo. Cesare dichiarò di non poter
concedere neppure questo. Era venuto a conoscenza, infatti, che i Germani,
alcuni giorni prima, avevano inviato gran parte della cavalleria al di là
della Mosa, nella regione degli Ambivariti, a scopo di razzia e in cerca
di grano. Riteneva, dunque, che stessero aspettando i loro cavalieri e
che, a tal fine, cercassero di prendere tempo.
[10
La Mosa nasce dai monti Vosgi, nella regione dei Lingoni; a non più di
ottanta miglia di distanza dall'Oceano, si getta nel Reno. Il Reno nasce
nella regione dei Leponzi, un popolo delle Alpi, scorre vorticoso per
lungo tratto nelle terre dei Nantuati, degli Elvezi, dei Sequani, dei
Mediomatrici, dei Triboci e dei Treveri; poi, nei pressi dell'Oceano, si
divide in diversi rami e forma molte isole di notevoli dimensioni, per la
maggior parte abitate da genti incolte e barbare, alcune delle quali si
ritiene che vivano di pesci e di uova d'uccelli. Sfocia con molte
diramazioni nell'Oceano.
[11
Cesare non distava più di dodici miglia dal nemico, quando i membri
dell'ambasceria ritornarono, secondo gli accordi. Gli si presentarono che
era in marcia e lo pregavano, invano, di non avanzare ulteriormente. Gli
chiedevano, allora, di dar ordine alla cavalleria, posta all'avanguardia,
di non aprire le ostilità e gli domandavano il permesso di inviare
un'ambasceria agli Ubi: se i capi e il senato degli Ubi avessero fornito
garanzie mediante un giuramento solenne, si dichiaravano pronti ad
accettare le condizioni proposte da Cesare. Ma, per condurre a termine le
operazioni necessarie, chiedevano tre giorni di tempo. Cesare riteneva che
la richiesta mirasse sempre a consentire, nei tre giorni di tregua, il
rientro dei cavalieri che si erano allontanati; tuttavia, disse che per
quel giorno si sarebbe spinto in avanti non oltre le quattro miglia, al
solo scopo di rifornirsi d'acqua, ma comandò che l'indomani si
presentassero lì nel maggior numero possibile per conoscere la sua
risposta. Al tempo stesso, ai prefetti della cavalleria, che precedeva
l'esercito, manda dei messi con l'ordine di non provocare a battaglia i
nemici e di difendersi, in caso di attacco, fino al suo arrivo con le
legioni.
[12
Ma i nemici, non appena videro la nostra cavalleria - benché contasse
circa cinquemila unità, mentre essi non erano più di ottocento, non
essendo ancora rientrati i cavalieri che avevano varcato la Mosa in cerca
di grano - si lanciarono all'attacco e scompaginarono in breve tempo i
nostri, che non nutrivano alcun timore, in quanto l'ambasceria dei Germani
aveva appena lasciato Cesare chiedendo, per quel giorno, tregua. Quando i
nostri riuscirono a opporre resistenza, gli avversari, secondo la loro
tecnica abituale, balzarono a terra e, ferendo al ventre i cavalli,
disarcionarono molti dei nostri e costrinsero alla fuga i superstiti,
premendoli e terrorizzandoli al punto che non cessarono la ritirata se non
quando furono in vista del nostro esercito in marcia. Nello scontro
perdono la vita settantaquattro nostri cavalieri, tra cui l'aquitano
Pisone, uomo di grandissimo valore e di alto lignaggio: un suo avo aveva
tenuto la suprema autorità tra la sua gente e ricevuto dal senato di Roma
il titolo di amico. Pisone, accorso in aiuto del fratello circondato dai
nemici, era riuscito a liberarlo; disarcionato - il suo cavallo era stato
colpito - resistette con estremo valore finché ebbe forza: poi, circondato
da molti avversari, cadde. Il fratello, che aveva già lasciato la mischia,
lo vide da lontano: sferzato il cavallo, si gettò sui nemici e rimase
ucciso.
[13
Dopo tale scontro, Cesare ormai non stimava giusto ascoltare gli
ambasciatori o accogliere le proposte di un popolo che, dopo aver chiesto
pace, aveva deliberatamente aperto le ostilità con agguati e imboscate;
d'altro canto, considerava pura follia aspettare che il numero dei nemici
aumentasse con il rientro della cavalleria e, ben conoscendo la volubilità
dei Galli, intuiva quanto prestigio i Germani avessero già acquisito con
una sola battaglia; perciò, riteneva di non dover assolutamente concedere
loro il tempo di prendere decisioni. Aveva già assunto tali risoluzioni e
informato i legati e il questore che non intendeva differire l'attacco
neppure di un giorno, quando si presentò un'occasione veramente
favorevole: proprio la mattina seguente i Germani, sempre con la stessa
perfida ipocrisia, si presentarono al campo di Cesare, in gran numero, con
tutti i principi e i più anziani. Volevano, a detta loro, sia chiedere
perdono per l'attacco sferrato il giorno precedente contro gli accordi e
le loro stesse richieste, sia ottenere, se possibile, una dilazione: ma il
solo scopo era di tendere una trappola. Cesare, lieto che gli si fossero
offerti, ordinò di trattenerli, portò fuori dall'accampamento tutte le sue
truppe e ordinò alla cavalleria di chiudere lo schieramento, ritenendola
ancora scossa per la recente sconfitta.
[14
Disposto l'esercito su tre file, percorse rapidamente otto miglia e piombò
sul campo nemico prima che i Germani potessero rendersi conto di cosa
stava accadendo. I nemici, atterriti per più di una ragione, dall'arrivo
improvviso dei nostri, dall'assenza dei loro, dal non avere il tempo di
prendere alcuna decisione, né di correre alle armi, erano incerti se
conveniva affrontare i Romani, difendere l'accampamento o darsi alla fuga.
I rumori e la confusione davano il segno del timore che regnava tra i
nemici; i nostri, irritati dal proditorio attacco del giorno precedente,
fecero irruzione nel campo avversario. Qui, chi riuscì ad armarsi in
fretta, per un po' oppose resistenza, combattendo tra i carri e le
salmerie; gli altri, invece, ossia le donne e i bambini (infatti, avevano
abbandonato le loro terre e attraversato il Reno con le famiglie) si
diedero a una fuga disordinata. Al loro inseguimento Cesare inviò la
cavalleria.
[15
I Germani, uditi i clamori alle spalle, quando videro che i loro venivano
massacrati, gettarono le armi, abbandonarono le insegne e fuggirono
dall'accampamento. Giunti alla confluenza della Mosa con il Reno, dove non
avevano più speranze di fuga, molti vennero uccisi, gli altri si gettarono
nel fiume e qui, vinti dalla paura, dalla stanchezza, dalla forte
corrente, morirono. I nostri, tutti salvi dal primo all'ultimo, con
pochissimi feriti, rientrarono al campo dopo le apprensioni nutrite per
uno scontro così rischioso, considerando che il nemico contava
quattrocentotrentamila persone. Ai Germani prigionieri nell'accampamento
Cesare permise di allontanarsi, ma costoro, temendo atroci supplizi da
parte dei Galli di cui avevano saccheggiato i campi, dissero di voler
rimanere presso di lui. Cesare concesse loro la libertà.
[16
Terminata la guerra con i Germani, Cesare decise che doveva varcare il
Reno, per molte ragioni, di cui una importantissima: vedendo con quale
facilità i Germani tendevano a passare in Gallia, voleva che nutrissero
timore anche per il proprio paese, quando si fossero resi conto che
l'esercito del popolo romano poteva e osava oltrepassare il Reno. Si
aggiungeva un'altra considerazione: la parte della cavalleria degli
Usipeti e dei Tenteri che, come abbiamo detto, attraversata la Mosa a
scopo di razzia e in cerca di grano, non aveva partecipato alla battaglia,
dopo la fuga dei suoi si era rifugiata al di là del Reno, nelle terre dei
Sigambri, unendosi a essi. Cesare, per chiedere la consegna di chi aveva
mosso guerra a lui e alla Gallia, mandò suoi emissari ai Sigambri, che
così risposero: il Reno segnava i confini del dominio di Roma; se egli
riteneva ingiusto che i Germani, contro il suo volere, passassero in
Gallia, perché pretendeva di aver dominio o potere al di là del Reno? Gli
Ubi, poi, l'unico popolo d'oltre Reno che avesse inviato a Cesare
emissari, stringendo alleanza e consegnando ostaggi, lo scongiuravano di
intervenire in loro aiuto perché incombevano su di loro, pesantemente, gli
Svevi; oppure, se ne era impedito dagli affari di stato, lo pregavano,
almeno, di condurre l'esercito al di là del Reno: sarebbe stato un ausilio
sufficiente per il presente e una speranza per il futuro. Il nome e la
fama dell'esercito romano, dopo la vittoria su Ariovisto e il recentissimo
successo, aveva raggiunto anche le più lontane genti germane: considerati
alleati del popolo romano, gli Ubi sarebbero stati al sicuro. Promettevano
una flotta numerosa per trasportare l'esercito.
[17
Per i motivi che ho ricordato, Cesare aveva deciso di oltrepassare il
Reno, ma riteneva che l'impiego delle navi non fosse abbastanza sicuro e
non lo giudicava consono alla dignità sua e del popolo romano. Così,
sebbene si presentassero gravi difficoltà per costruire un ponte - come la
larghezza e la profondità del fiume, la rapidità della corrente - egli
tuttavia stimava necessario adottare tale soluzione oppure rinunciare
all'impresa. Ecco come progettò la struttura dei ponte. A distanza di due
piedi univa, a due per volta, travi lievemente appuntite in basso, del
diametro di un piede e mezzo di altezza commisurata alla profondità del
fiume; poi, mediante macchinari le calava in acqua e con battipali le
conficcava sul fondo del fiume, non a perpendicolo, come le travi delle
palafitte, ma oblique e in pendenza, in modo da inclinare nel senso della
corrente; più in basso, alla distanza di quaranta passi e dirimpetto alle
prime travi, ne poneva altre, sempre legate a due a due, con inclinazione
opposta all'impeto e alla corrente del fiume. Nell'interstizio collocava
pali dello spessore di due piedi - pari alla distanza delle travi
accoppiate - e, fissandoli con due arpioni, impediva che esse in cima si
toccassero; perciò, poggiando su travi separate e ben ribadite in
direzione contraria, la struttura del ponte risultava tale, da reggere,
per necessità naturale, tanto più saldamente, quanto più impetuosa fosse
la corrente. Sui pali venivano disposte, in senso orizzontale, altre travi
su cui poggiavano tavole e graticci; inoltre, come sostegno, a valle
venivano aggiunti, obliqui, pali fissati al resto della struttura per
resistere alla corrente impetuosa; così pure altre travi, a monte,
venivano collocate non lontano dal ponte, allo scopo di frenare eventuali
tronchi o navi che i barbari avessero lanciato contro la costruzione per
distruggerla: l'impatto sarebbe stato attutito e i danni al ponte
limitati.
[18
Da quando ebbe inizio la raccolta del materiale, in dieci giorni il lavoro
fu portato a termine e l'esercito oltrepassò il fiume. Lasciati saldi
presidi su entrambe le sponde, Cesare marciò verso il territorio dei
Sigambri. Frattanto gli si presentano ambascerie di parecchie nazioni,
alle cui richieste di pace e alleanza egli risponde benevolmente e ordina
la consegna di ostaggi. Da quando erano incominciati i lavori per il
ponte, i Sigambri, su pressione dei Tenteri e degli Usipeti che erano con
loro, avevano preparato la fuga ed evacuato i loro territori, portando con
sé tutti i loro beni e rifugiandosi in foreste disabitate.
[19
Cesare si trattenne pochi giorni nella regione dei Sigambri, dove diede
alle fiamme tutti i villaggi e le singole abitazioni e distrusse i
raccolti, quindi ripiegò nei territori degli Ubi, a cui aveva promesso il
suo aiuto in caso di attacco degli Svevi. Dagli Ubi venne a sapere quanto
segue: gli Svevi, messi al corrente dai loro esploratori che si costruiva
un ponte, tenuta un'assemblea, secondo il loro costume, avevano poi
inviato emissari in tutte le direzioni, con l'ordine di evacuare le città
e di mettere al sicuro nelle selve i figli, le mogli e ogni loro bene,
mentre tutti gli uomini in grado di combattere dovevano radunarsi in un
solo luogo, quasi al centro delle regioni controllate dagli Svevi: si era
stabilito che lì avrebbero atteso l'arrivo dei Romani e combattuto.
Cesare, quando lo seppe, avendo raggiunto gli scopi che lo avevano spinto
ad attraversare il Reno (incutere timore ai Germani, punire i Sigambri,
liberare gli Ubi dall'oppressione degli Svevi) e ritenendo, inoltre, che i
diciotto giorni, in tutto, trascorsi al di là del Reno gli avessero
procurato fama e vantaggi sufficienti, rientrò in Gallia e distrusse il
ponte.
[20
Non rimaneva che un'esigua parte dell'estate, tuttavia, benché in quelle
regioni l'inverno sia precoce, dato che la Gallia è volta a settentrione,
Cesare decise di partire per la Britannia, perché capiva che da lì
giungevano ai nostri nemici aiuti in quasi tutte le guerre in Gallia;
inoltre, anche se la stagione non bastava per le operazioni belliche,
riteneva molto utile raggiungere almeno l'isola, vedere che genere di
uomini l'abitasse, rendersi conto di luoghi, approdi, accessi, notizie
quasi tutte ignorate anche dai Galli. È difficile, infatti, che uno si
spinga fin là, a eccezione dei mercanti, e pure essi, all'infuori della
costa e delle regioni prospicienti la Gallia, non conoscono altro.
Infatti, pur avendo convocato mercanti da ogni parte, Cesare non riuscì a
sapere quanto fosse estesa l'isola, quali e quanti popoli l'abitassero,
che tecniche di combattimento adottassero, che genere di istituzioni
avessero e quali fossero i porti in grado di accogliere una flotta di navi
di stazza superiore.
[21
Allo scopo di raccogliere informazioni in proposito, prima di affrontare
l'impresa, Cesare manda in avanscoperta una nave da guerra agli ordini di
C. Voluseno, ritenendolo adatto per la missione. Lo incarica di rientrare
al più presto, una volta terminata la ricognizione. Dal canto suo, con
l'esercito al completo si dirige nei territori dei Morini, perché da lì il
tragitto verso la Britannia era il più breve. Ordina che qui si radunino
le navi provenienti da tutte le regioni limitrofe e la flotta allestita
l'estate precedente per la guerra contro i Veneti. Nel frattempo, le sue
manovre vengono risapute e i mercanti le riferiscono ai Britanni: da parte
di molti popoli dell'isola giungono messi per promettere che avrebbero
consegnato ostaggi e si sarebbero sottomessi al dominio del popolo romano.
Cesare li ascolta e, esortandoli a non mutare parere, con benevoli
promesse li rimanda in patria accompagnati da Commio, che in Britannia
godeva di grande autorità: Cesare ne stimava il valore e l'intelligenza e
lo riteneva fedele al punto che lo aveva designato re degli Atrebati dopo
averli sconfitti in battaglia. A Commio dà ordine di prendere contatti con
il maggior numero di popoli per sollecitarli a mettersi sotto la
protezione di Roma e per annunciare che presto Cesare sarebbe giunto.
Voluseno, compiuta la ricognizione in tutte le zone, per quanto gli fu
possibile, dato che non volle correre il rischio di sbarcare e di entrare
in contatto con i barbari, raggiunge Cesare quattro giorni dopo e gli
riferisce ciò che aveva osservato.
[22
Mentre per preparare la flotta Cesare si attardava nei territori dei
Morini, molte tribù della regione gli inviarono emissari per scusarsi
della loro condotta passata, quando, barbari e ignari delle nostre
consuetudini, avevano mosso guerra al popolo romano: adesso promettevano
ubbidienza ai suoi ordini. Cesare la giudicò una circostanza veramente
favorevole, perché non voleva lasciarsi un nemico alle spalle e, con
l'estate che volgeva al termine, non aveva il tempo di sostenere una
guerra; inoltre, stimava di non dover anteporre un problema di così lieve
entità alla Britannia; pretese, allora, la consegna di un alto numero di
ostaggi. Ricevuti i quali, pose i Morini sotto la propria protezione.
Circa ottanta navi da carico, numero che giudicava sufficiente per il
trasporto delle legioni, vennero radunate e munite di tolde. Le navi da
guerra di cui disponeva vennero suddivise tra il questore, i legati e i
prefetti. A esse si aggiungevano altre diciotto navi da carico, che erano
a otto miglia di distanza e non riuscivano a raggiungere il porto per via
del vento: le riservò alla cavalleria. Ai legati Q. Titurio Sabino e L.
Aurunculeio Cotta affidò il resto dell'esercito col compito di guidarlo
contro i Menapi e le tribù dei Morini che non avevano inviato ambascerie.
Lasciò al legato P. Sulpicio Rufo una guarnigione giudicata sufficiente,
con l'ordine di presidiare il porto.
[23
Presi tali provvedimenti, approfittando del tempo favorevole alla
navigazione, salpò all'incirca dopo mezzanotte e comandò alla cavalleria
di raggiungere il porto successivo per imbarcarsi e seguirlo. I cavalieri
eseguirono gli ordini troppo lentamente; Cesare, invece, con le prime navi
pervenne alle coste della Britannia verso le nove di mattina e lì vide le
truppe nemiche, in armi, schierate su tutte le alture circostanti. La
natura del luogo era tale e le scogliere erano così a precipizio sul mare,
che i dardi scagliati dall'alto potevano raggiungere il litorale. Avendo
giudicato il luogo assolutamente inadatto per uno sbarco, gettò l'ancora e
fino alle due del pomeriggio attese l'arrivo delle altre navi. Nel
frattempo, convocati i legati e i tribuni militari, espose le informazioni
raccolte da Voluseno e il suo piano, invitandoli a compiere tutte le
manovre al primo cenno e istantaneamente, come richiede la tecnica
militare, soprattutto negli scontri navali, dove i movimenti sono rapidi e
variano continuamente. Dopo averli congedati, sfruttando il contemporaneo
favore della marea e del vento, diede il segnale e levò le ancore. Avanzò
per circa sette miglia e mise le navi alla fonda in un punto in cui il
litorale era aperto e piano.
[24
Ma i barbari, avendo inteso i propositi dei Romani, avevano mandato in
avanti, seguiti dal resto dell'esercito, i cavalieri e gli essedari -
reparti che di solito impiegano in battaglia - impedendo lo sbarco ai
nostri, che incontravano enormi difficoltà: le navi, per le loro
dimensioni, potevano fermarsi solo al largo; i soldati, poi, non
conoscevano i luoghi, non avevano le mani libere, erano appesantiti dalle
armi e dovevano, contemporaneamente, scendere dalle navi, resistere alle
onde, combattere contro i nemici. I barbari, invece, liberi nei movimenti,
combattevano dalla terraferma o entravano appena in acqua, conoscevano
alla perfezione i luoghi, con audacia scagliavano frecce e lanciavano alla
carica i loro cavalli, abituati a tali operazioni. I nostri, sgomenti per
tutto ciò, trovandosi di fronte a una tecnica di combattimento del tutto
nuova, non si battevano con il solito zelo e ardore dimostrato in campo
aperto.
[25
Quando se ne accorse, Cesare ordinò che le navi da guerra, di forma
inconsueta per i barbari e facilmente manovrabili, si staccassero un po'
dalle imbarcazioni da carico e, accelerando a forza di remi, si
disponessero sul fianco destro del nemico e, da qui, azionassero le
fionde, gli archi, le macchine da lancio per costringere gli avversari
alla ritirata. La manovra si rivelò molto utile. Infatti, i barbari,
scossi dalla forma delle navi, dal movimento dei remi e dall'insolito
genere di macchine da lancio, si arrestarono e ripiegarono leggermente.
Ma, visto che i nostri soldati, soprattutto per la profondità dell'acqua,
esitavano, l'aquilifero della decima legione, dopo aver pregato gli dèi di
dare felice esito all'impresa, gridò: "Saltate giù, commilitoni, se non
volete consegnare l'aquila al nemico: io, per parte mia, avrò fatto il mio
dovere verso la repubblica e il comandante". Lo disse a gran voce, poi
saltò giù dalla nave e cominciò a correre contro i nemici. Allora i
nostri, vicendevolmente spronandosi a non permettere un'onta così grave,
saltarono giù dalla nave, tutti quanti. Anche i soldati delle navi vicine,
come li videro, li seguirono e avanzarono contro i nemici.
[26
Si combatté con accanimento da entrambe le parti. I nostri, tuttavia,
erano in preda allo scompiglio, non riuscendo a mantenere lo schieramento,
ad attestarsi saldamente, a seguire le proprie insegne, in quanto
ciascuno, appena sbarcato, si univa alle prime in cui si imbatteva. I
nemici, invece, che conoscevano tutti i bassifondi, non appena dal
litorale vedevano alcuni dei nostri sbarcare isolati dalle navi,
lanciavano i cavalli al galoppo e alla carica dei legionari in difficoltà:
molti dei loro circondavano pochi dei nostri, mentre altri dal fianco
destro, scagliavano un nugolo di frecce sul grosso dello schieramento.
Cesare, appena se ne accorse, ordinò di riempire di soldati le scialuppe
delle navi da guerra e i battelli da ricognizione e li inviò in aiuto di
chi aveva visto in difficoltà. I nostri, non appena riuscirono ad
attestarsi sulla terraferma, formati i ranghi, passarono al contrattacco e
costrinsero alla fuga gli avversari, ma non ebbero modo di protrarre
l'inseguimento, perché le navi con la cavalleria avevano perso la rotta e
non erano riuscite a raggiungere l'isola: solo questo mancò alla solita
buona stella di Cesare.
[27
I nemici, vinti in battaglia, non appena si riebbero dall'affanno della
fuga, immediatamente inviarono messi a Cesare per offrirgli la resa,
promettendo la consegna di ostaggi e il rispetto degli ordini che volesse
impartire. Insieme a loro giunse l'atrebate Commio, l'uomo mandato da
Cesare in Britannia in avanscoperta, come in precedenza avevo chiarito.
Non appena Commio era sceso dalla nave e aveva riferito, come portavoce,
le richieste di Cesare, i Britanni lo avevano fatto prigioniero e messo in
catene; ora, dopo la battaglia, lo avevano liberato e, nel domandare pace,
attribuivano la responsabilità dell'accaduto al popolo, chiedendo di
perdonare una colpa dovuta alla leggerezza. Cesare si lamentò che i
Britanni, dopo aver spontaneamente inviato ambascerie sul continente per
domandare pace, gli avevano poi mosso guerra senza motivo, ma disse che
perdonava la loro leggerezza e chiese ostaggi. Una parte venne consegnata
immediatamente, altri invece, fatti venire da regioni lontane. li
avrebbero consegnati - dissero - entro pochi giorni. Nel frattempo,
diedero disposizione ai loro di ritornare alle campagne; i principi di
tutte le regioni si riunirono e cominciarono a pregare Cesare di aver
riguardo per loro e per i rispettivi popoli.
[28
Con tali misure la pace era assicurata: quattro giorni dopo il nostro
arrivo in Britannia, le diciotto navi di cui si è parlato, su cui era
imbarcata la cavalleria, dal porto più settentrionale salparono con una
leggera brezza. Si stavano avvicinando alla Britannia ed erano già state
avvistate dall'accampamento, quando all'improvviso si levò una tempesta
così violenta, che nessuna delle navi riuscì a tenere la rotta: alcune
vennero risospinte verso il porto di partenza, altre con grave pericolo
vennero spinte verso la parte sud-occidentale dell'isola. Tentarono di
gettare l'ancora, ma, sommerse dalla violenza dei flutti, furono
costrette, sebbene fosse notte, a prendere il largo e a dirigersi verso il
continente.
[29
Capitò che quella notte stessa ci fosse luna piena, momento in cui la
marea nell'Oceano è più alta, e i nostri non lo sapevano. Così, nello
stesso tempo, la marea sommerse le navi da guerra impiegate per
trasportare l'esercito e poi tirate in secco, mentre la tempesta sbatteva
l'una contro l'altra le imbarcazioni da carico, che erano all'àncora,
senza che i nostri avessero la minima possibilità di manovrare o porvi
rimedio. Molte navi rimasero danneggiate, le altre, perse le funi, le
ancore e il resto dell'attrezzatura, erano inutilizzabili: un profondo
turbamento, com'era inevitabile, si impadronì di tutto l'esercito. Non
c'erano, infatti, altre navi con cui ritornare, mancava tutto il
necessario per riparare le barche danneggiate e, poiché tutti pensavano
che si dovesse svernare in Gallia, sull'isola non si era provvisto il
grano per l'inverno.
[30
Appena ne furono informati, i principi britanni, che si erano recati da
Cesare dopo la battaglia, presero accordi: rendendosi conto che i Romani
non avevano né cavalleria, né navi, né frumento e constatando che dovevano
essere ben pochi, viste le dimensioni dell'accampamento, ancor più ridotto
del solito in quanto Cesare aveva trasportato le legioni senza bagagli,
ritennero che la cosa migliore fosse ribellarsi, ostacolare i nostri
nell'approvvigionamento di grano e viveri, protrarre le ostilità fino
all'inverno, perché erano sicuri che, sconfiggendo i Romani o impedendo
loro il ritorno, nessuno in futuro sarebbe penetrato in Britannia per
portarvi guerra. Così, formata nuovamente una lega, a poco a poco
cominciarono a lasciare l'accampamento romano e a radunare di nascosto i
loro uomini dalle campagne.
[31
Cesare non conosceva ancora il loro piano, ma dopo il disastro capitato
alle navi e visto che non gli venivano più consegnati ostaggi, sospettava
quello che sarebbe poi accaduto. Perciò, si premuniva per qualsiasi
evenienza. Ogni giorno, infatti, disponeva che dalle campagne portassero
grano all'accampamento, si serviva del legname e del bronzo delle navi più
danneggiate per riparare le altre e ordinava di procurarsi dal continente
il materiale necessario a tale scopo. Così, grazie allo straordinario
impegno dei nostri soldati, pur risultando perdute dodici navi, mise le
altre in condizione di navigare senza problemi.
[32
Mentre accadevano tali fatti, come di consueto una legione, la settima,
era stata inviata in cerca di grano (fino ad allora non si nutriva alcun
sospetto di guerra, visto che parte dei Britanni si trovava nelle
campagne, parte frequentava ancora l'accampamento romano). Le guardie
dislocate alle porte del campo annunziarono a Cesare che, nella direzione
in cui si era mossa la nostra legione, si vedeva levarsi più polvere del
solito. Cesare, sospettando che i barbari, come in effetti era, stessero
tentando qualche novità, ordinò alle coorti di guardia di partire con lui
in quella direzione, e a due delle altre di prendere il loro posto: le
rimanenti avrebbero dovuto armarsi e seguirlo al più presto. A una certa
distanza dal campo, vide che i suoi erano pressati dal nemico e
resistevano a fatica: sulla legione, serrata, piovevano frecce da tutti i
lati. Ecco che cosa era accaduto: poiché il grano era stato raccolto in
tutti i campi tranne uno, i nemici, supponendo che i nostri si sarebbero
qui diretti, di notte si erano nascosti nelle selve; poi, erano piombati
all'improvviso sui nostri, che si erano sparpagliati e avevano deposto le
armi per attendere alla mietitura. Ne avevano uccisi pochi, ma gli altri,
che non riuscivano a riformare i ranghi ed erano in pieno scompiglio, li
avevano accerchiati contemporaneamente con i cavalieri e gli essedari.
[33
La loro tecnica di combattimento con i carri è la seguente: prima corrono
in tutte le direzioni, scagliano frecce e con i loro cavalli e lo strepito
delle ruote gettano il panico, in genere, tra le file avversarie, che si
disuniscono; poi, quando riescono a penetrare tra gli squadroni di
cavalleria, scendono dai carri e combattono a piedi. Nel frattempo, gli
aurighi a poco a poco si allontanano dalla mischia e piazzano i carri in
modo tale che i loro compagni, nel caso siano incalzati da un gran numero
di nemici, abbiano la possibilità di mettersi rapidamente al sicuro. Così,
nelle battaglie si assicurano la mobilità dei cavalieri e la stabilità dei
fanti. Grazie alla pratica e all'esercizio quotidiano sono capaci di
frenare, anche in pendii a precipizio, i cavalli lanciati al galoppo, di
moderarne la velocità e di cambiare direzione in poco spazio, di correre
sopra il timone del carro, di tenersi fermi sul giogo dei cavalli e poi,
da qui, di ritornare sui carri in un attimo.
[34
Perciò, mentre i nostri erano disorientati dall'insolita tattica di
combattimento, Cesare giunse in aiuto nel momento più opportuno: con il
suo arrivo, infatti, i nemici si arrestarono, i nostri ripresero coraggio.
Tuttavia, Cesare ritenne che non fosse il momento adatto per sfidare gli
avversari e attaccar battaglia, perciò tenne le proprie posizioni e, poco
dopo, ricondusse le legioni all'accampamento. Mentre si svolgono questi
fatti, tenendo impegnati tutti i nostri, si ritirarono gli altri Britanni
che si trovavano nelle campagne. Per parecchi giorni si rovesciarono
piogge senza interruzione, che costrinsero i nostri nell'accampamento e
impedirono ai nemici di attaccare. Nel frattempo, i barbari inviarono
messaggeri in tutte le direzioni, continuando a insistere sul fatto che i
nostri erano ben pochi e a spiegare quale bottino, quale possibilità di
rendersi per sempre liberi li attendesse, se avessero scacciato i Romani
dal loro campo. Così, dopo aver radunato un gran numero di fanti e
cavalieri, mossero sull'accampamento romano.
[35
Cesare si rendeva conto che si sarebbe verificata la stessa situazione
delle battaglie precedenti: il nemico, in caso fosse stato battuto, si
sarebbe sottratto a ogni pericolo grazie alla sua rapidità di movimento.
Tuttavia, disponendo di circa trenta cavalieri che l'atrebate Commio, di
cui si è già parlato, aveva condotto con sé, Cesare decise di schierare
dinanzi all'accampamento le legioni, pronte alla battaglia. Lo scontro
ebbe luogo: i nemici non riuscirono a reggere all'attacco dei legionari a
lungo e si volsero in fuga. I nostri li inseguirono finché ebbero la forza
di correre; dopo averne uccisi molti, incendiarono gli edifici in lungo e
in largo e rientrarono al campo.
[36
Quel giorno stesso a Cesare si presentarono emissari per chiedere pace.
Egli raddoppiò il numero di ostaggi chiesti in precedenza e ne ordinò la
consegna sul continente, perché non riteneva opportuno affrontare
d'inverno la traversata - l'equinozio era vicino - con le navi in cattivo
stato. Approfittando di un tempo favorevole, salpò poco dopo la
mezzanotte: tutte le navi raggiunsero senza danni il continente; solo due
imbarcazioni da carico non riuscirono ad approdare agli stessi porti delle
altre e vennero sospinte un po' più a sud.
[37
Da queste due navi sbarcarono circa trecento dei nostri, che si diressero
verso l'accampamento. I Morini, che Cesare al momento della partenza per
la Britannia aveva lasciato pacificati, spinti dalla speranza di bottino,
circondarono dapprima in numero non altissimo i nostri e intimarono loro
la resa, se volevano aver salva la vita. Mentre i legionari, disposti in
cerchio, si difendevano, alle grida dei Morini sopraggiunsero rapidamente
altri seimila uomini circa. Appena ne fu informato, Cesare, a sostegno dei
suoi, inviò tutta la cavalleria presente al campo. Nel frattempo, i nostri
ressero all'urto dei nemici e si batterono con estremo valore per più di
quattro ore: subirono poche perdite e uccisero molti nemici. E non appena
comparve la cavalleria, i nemici gettarono le armi e si diedero alla fuga:
i nostri ne fecero strage.
[38
Il giorno seguente, contro i Morini che si erano ribellati, Cesare inviò
il legato T. Labieno alla testa delle legioni rientrate dalla Britannia.
Le paludi erano in secca e i nemici, che non potevano rifugiarvisi come
l'anno precedente, non sapevano dove ripiegare, perciò si sottomisero
quasi tutti all'autorità di Labieno. E i legati Q. Titurio e L. Cotta, che
avevano guidato le legioni nella regione dei Menapi, ritornarono da Cesare
dopo aver devastato tutti i campi, distrutto i raccolti, incendiato gli
edifici, in quanto la popolazione si era rifugiata in massa nel folto dei
boschi. Cesare stabilì che tutte le legioni ponessero i quartieri
d'inverno nelle terre dei Belgi. Lì pervennero gli ostaggi di due popoli
britanni in tutto; gli altri contravvennero all'impegno di inviarli. In
seguito a tali imprese, comunicate per lettera da Cesare, il senato
decretò venti giorni di feste solenni di ringraziamento. |
LIBER QUINTUS
[1] L. Domitio Ap. Claudio consulibus, discedens ab hibernis Caesar in Italiam, ut quotannis facere consuerat, legatis imperat quos legionibus praefecerat uti quam plurimas possent hieme naves aedificandas veteresque reficiendas curarent. Earum modum formamque demonstrat. Ad celeritatem onerandi subductionesque paulo facit humiliores quam quibus in nostro mari uti consuevimus, atque id eo magis, quod propter crebras commutationes aestuum minus magnos ibi fluctus fieri cognoverat; ad onera, ad multitudinem iumentorum transportandam paulo latiores quam quibus in reliquis utimur maribus. Has omnes actuarias imperat fieri, quam ad rem multum humilitas adiuvat. Ea quae sunt usui ad armandas naves ex Hispania apportari iubet. Ipse conventibus Galliae citeribris peractis in Illyricum proficiscitur, quod a Pirustis finitimam partem provinciae incursionibus vastari audiebat. Eo cum venisset, civitatibus milites imperat certumque in locum convenire iubet. Qua re nuntiata Pirustae legatos ad eum mittunt qui doceant nihil earum rerum publico factum consilio, seseque paratos esse demonstrant omnibus rationibus de iniuriis satisfacere. Accepta oratione eorum Caesar obsides imperat eosque ad certam diem adduci iubet; nisi ita fecerint, sese bello civitatem persecuturum demonstrat. Eis ad diem adductis, ut imperaverat, arbitros inter civitates dat qui litem aestiment poenamque constituant.
[2] His confectis rebus conventibusque peractis, in citeriorem Galliam revertitur atque inde ad exercitum proficiscitur. Eo cum venisset, circuitis omnibus hibernis, singulari militum studio in summa omnium rerum inopia circiter sescentas eius generis cuius supra demonstravimus naves et longas XXVIII invenit instructas neque multum abesse ab eo quin paucis diebus deduci possint. Collaudatis militibus atque eis qui negotio praefuerant, quid fieri velit ostendit atque omnes ad portum Itium convenire iubet, quo ex portu commodissimum in Britanniam traiectum esse cognoverat, circiter milium passuum XXX transmissum a continenti: huic rei quod satis esse visum est militum reliquit. Ipse cum legionibus expeditis IIII et equitibus DCCC in fines Treverorum proficiscitur, quod hi neque ad concilia veniebant neque imperio parebant Germanosque Transrhenanos sollicitare dicebantur.
[3] Haec civitas longe plurimum totius Galliae equitatu valet magnasque habet copias peditum Rhenumque, ut supra demonstravimus, tangit. In ea civitate duo de principatu inter se contendebant, Indutiomarus et Cingetorix; e quibus alter, simul atque de Caesaris legionumque adventu cognitum est, ad eum venit, se suosque omnes in officio futuros neque ab amicitia populi Romani defecturos confirmavit quaeque in Treveris gererentur ostendit. At Indutiomarus equitatum peditatumque cogere, eisque qui per aetatem in armis esse non poterant in silvam Arduennam abditis, quae ingenti magnitudine per medios fines Treverorum a flumine Rheno ad initium Remorum pertinet, bellum parare instituit. Sed posteaquam nonnulli principes ex ea civitate et familiaritate Cingetorigis adducti et adventu nostri exercitus perterriti ad Caesarem venerunt et de suis privatim rebus ab eo petere coeperunt, quoniam civitati consulere non possent, veritus ne ab omnibus desereretur Indutiomarus legatos ad Caesarem mittit: sese idcirco ab suis discedere atque ad eum venire noluisse, quo facilius civitatem in officio contineret, ne omnis nobilitatis discessu plebs propter imprudentiam laberetur: itaque esse civitatem in sua potestate, seseque, si Caesar permitteret, ad eum in castra venturum, suas civitatisque fortunas eius fidei permissurum.
[4] Caesar, etsi intellegebat qua de causa ea dicerentur quaeque eum res ab instituto consilio deterreret, tamen, ne aestatem in Treveris consumere cogeretur omnibus ad Britannicum bellum rebus comparatis, Indutiomarum ad se cum CC obsidibus venire iussit. His adductis, in eis filio propinquisque eius omnibus, quos nominatim evocaverat, consolatus Indutiomarum hortatusque est uti in officio maneret; nihilo tamen setius principibus Treverorum ad se convocatis hos singillatim Cingetorigi conciliavit, quod cum merito eius a se fieri intellegebat, tum magni interesse arbitrabatur eius auctoritatem inter suos quam plurimum valere, cuius tam egregiam in se voluntatem perspexisset. Id tulit factum graviter Indutiomarus, suam gratiam inter suos minui, et, qui iam ante inimico in nos animo fuisset, multo gravius hoc dolore exarsit.
[5] His rebus constitutis Caesar ad portum Itium cum legionibus pervenit. Ibi cognoscit LX naves, quae in Meldis factae erant, tempestate reiectas cursum tenere non potuisse atque eodem unde erant profectae revertisse; reliquas paratas ad navigandum atque omnibus rebus instructas invenit. Eodem equitatus totius Galliae convenit, numero milium quattuor, principesque ex omnibus civitatibus; ex quibus perpaucos, quorum in se fidem perspexerat, relinquere in Gallia, reliquos obsidum loco secum ducere decreverat, quod, cum ipse abesset, motum Galliae verebatur.
[6] Erat una cum ceteris Dumnorix Aeduus, de quo ante ab nobis dictum est. Hunc secum habere in primis constituerat, quod eum cupidum rerum novarum, cupidum imperi, magni animi, magnae inter Gallos auctoritatis cognoverat. Accedebat huc quod in concilio Aeduorum Dumnorix dixerat sibi a Caesare regnum civitatis deferri; quod dictum Aedui graviter ferebant, neque recusandi aut deprecandi causa legatos ad Caesarem mittere audebant. Id factum ex suis hospitibus Caesar cognoverat. Ille omnibus primo precibus petere contendit ut in Gallia relinqueretur, partim quod insuetus navigandi mare timeret, partim quod religionibus impediri sese diceret. Posteaquam id obstinate sibi negari vidit, omni spe impetrandi adempta principes Galliae sollicitare, sevocare singulos hortarique coepit uti in continenti remanerent: metu territare: non sine causa fieri, ut Gallia omni nobilitate spoliaretur; id esse consilium Caesaris, ut quos in conspectu Galliae interficere vereretur, hos omnes in Britanniam traductos necaret; fidem reliquis interponere, iusiurandum poscere, ut quod esse ex usu Galliae intellexissent communi consilio administrarent. Haec a compluribus ad Caesarem deferebantur.
[7] Qua re cognita Caesar, quod tantum civitati Aeduae dignitatis tribuebat, coercendum atque deterrendum quibuscumque rebus posset Dumnorigem statuebat; quod longius eius amentiam progredi videbat, prospiciendum, ne quid sibi ac rei publicae nocere posset. Itaque dies circiter XXV in eo loco commoratus, quod Corus ventus navigationem impediebat, qui magnam partem omnis temporis in his locis flare consuevit, dabat operam ut in officio Dumnorigem contineret, nihilo tamen setius omnia eius consilia cognosceret: tandem idoneam nactus tempestatem milites equitesque conscendere in naves iubet. At omnium impeditis animis Dumnorix cum equitibus Aeduorum a castris insciente Caesare domum discedere coepit. Qua re nuntiata Caesar intermissa profectione atque omnibus rebus postpositis magnam partem equitatus ad eum insequendum mittit retrahique imperat; si vim faciat neque pareat, interfici iubet, nihil hunc se absente pro sano facturum arbitratus, qui praesentis imperium neglexisset. Ille enim revocatus resistere ac se manu defendere suorumque fidem implorare coepit, saepe clamitans liberum se liberaeque esse civitatis. Illi, ut erat imperatum, circumsistunt hominem atque interficiunt: at equites Aedui ad Caesarem omnes revertuntur.
[8] His rebus gestis, Labieno in continente cum tribus legionibus et equitum milibus duobus relicto ut portus tueretur et rem frumentariam provideret quaeque in Gallia gererentur cognosceret consiliumque pro tempore et pro re caperet, ipse cum quinque legionibus et pari numero equitum, quem in continenti reliquerat, ad solis occasum naves solvit et leni Africo provectus media circiter nocte vento intermisso cursum non tenuit, et longius delatus aestu orta luce sub sinistra Britanniam relictam conspexit. Tum rursus aestus commutationem secutus remis contendit ut eam partem insulae caperet, qua optimum esse egressum superiore aestate cognoverat. Qua in re admodum fuit militum virtus laudanda, qui vectoriis gravibusque navigiis non intermisso remigandi labore longarum navium cursum adaequarunt. Accessum est ad Britanniam omnibus navibus meridiano fere tempore, neque in eo loco hostis est visus; sed, ut postea Caesar ex captivis cognovit, cum magnae manus eo convenissent, multitudine navium perterritae, quae cum annotinis privatisque quas sui quisque commodi fecerat amplius octingentae uno erant visae tempore, a litore discesserant ac se in superiora loca abdiderant.
[9] Caesar eito exercitu et loco castris idoneo capto, ubi ex captivis cognovit quo in loco hostium copiae consedissent, cohortibus decem ad mare relictis et equitibus trecentis, qui praesidio navibus essent, de tertia vigilia ad hostes contendit, eo minus veritus navibus, quod in litore molli atque aperto deligatas ad ancoram relinquebat, et praesidio navibus Q. Atrium praefecit. Ipse noctu progressus milia passuum circiter XII hostium copias conspicatus est. Illi equitatu atque essedis ad flumen progressi ex loco superiore nostros prohibere et proelium committere coeperuut. Repulsi ab equitatu se in silvas abdiderunt, locum nacti egregie et natura et opere munitum, quem domestici belli, ut videbantur, causa iam ante praeparaverant: nam crebris arboribus succisis omnes introitus erant praeclusi. Ipsi ex silvis rari propugnabant nostrosque intra munitiones ingredi prohibebant. At milites legionis septimae, testudine facta et aggere ad munitiones adiecto, locum ceperunt eosque ex silvis expulerunt paucis vulneribus acceptis. Sed eos fugientes longius Caesar prosequi vetuit, et quod loci naturam ignorabat, et quod magna parte diei consumpta munitioni castrorum tempus relinqui volebat.
[10] Postridie eius diei mane tripertito milites equitesque in expeditionem misit, ut eos qui fugerant persequerentur. His aliquantum itineris progressis, cum iam extremi essent in prospectu, equites a Quinto Atrio ad Caesarem venerunt, qui nuntiarent superiore nocte maxima coorta tempestate prope omnes naves adflictas atque in litore eiectas esse, quod neque ancorae funesque subsisterent, neque nautae gubernatoresque vim tempestatis pati possent; itaque ex eo concursu navium magnum esse incommodum acceptum.
[11] His rebus cognitis Caesar legiones equitatumque revocari atque in itinere resistere iubet, ipse ad naves revertitur; eadem fere quae ex nuntiis litterisque cognoverat coram perspicit, sic ut amissis circiter XL navibus reliquae tamen refici posse magno negotio viderentur. Itaque ex legionibus fabros deligit et ex continenti alios arcessi iubet; Labieno scribit, ut quam plurimas posset eis legionibus, quae sunt apud eum, naves instituat. Ipse, etsi res erat multae operae ac laboris, tamen commodissimum esse statuit omnes naves subduci et cum castris una munitione coniungi. In his rebus circiter dies X consumit ne nocturnis quidem temporibus ad laborem militum intermissis. Subductis navibus castrisque egregie munitis easdem copias, quas ante, praesidio navibus reliquit: ipse eodem unde redierat proficiscitur. Eo cum venisset, maiores iam undique in eum locum copiae Britannorum convenerant summa imperi bellique administrandi communi consilio permissa Cassivellauno, cuius fines a maritimis civitatibus fiumen dividit, quod appellatur Tamesis, a mari circiter milia passuum LXXX. Huic superiore tempore cum reliquis civitatibus continentia bella intercesserant; sed nostro adventu permoti Britanni hunc toti bello imperioque praefeceraut.
[12] Britanniae pars interior ab eis incolitur quos natos in insula ipsi memoria proditum dicunt, maritima ab eis, qui praedae ac belli inferendi causa ex Belgio transierunt (qui omnes fere eis nominibus civitatum appellantur, quibus orti ex civitatibus eo pervenerunt) et bello illato ibi permanserunt atque agros colere coeperunt. Hominum est infinita multitudo creberrimaque aedificia fere Gallicis consimilia, pecorum magnus numerus. Utuntur aut aere aut nummo aureo aut taleis ferreis ad certum pondus examinatis pro nummo. Nascitur ibi plumbum album in mediterraneis regionibus, in maritimis ferrum, sed eius exigua est copia; aere utuntur importato. Materia cuiusque generis ut in Gallia est, praeter fagum atque abietem. Leporem et gallinam et anserem gustare fas non putant; haec tamen alunt animi voluptatisque causa. Loca sunt temperatiora quam in Gallia, remissioribus frigoribus.
[13] Insula natura triquetra, cuius unum latus est contra Galliam. Huius lateris alter angulus, qui est ad Cantium, quo fere omnes ex Gallia naves appelluntur, ad orientem solem, inferior ad meridiem spectat. Hoc pertinet circiter mila passuum quingenta. Alterum vergit ad Hispaniam atque occidentem solem; qua ex parte est Hibernia, dimidio minor, ut aestimatur, quam Britannia, sed pari spatio transmissus atque ex Gallia est in Britanniam. In hoc medio cursu est insula, quae appellatur Mona: complures praeterea minores subiectae insulae existimantur, de quibus insulis nonnulli scripserunt dies continuos triginta sub bruma esse noctem. Nos nihil de eo percontationibus reperiebamus, nisi certis ex aqua mensuris breviores esse quam in continenti noctes videbamus. Huius est longitudo lateris, ut fert illorum opinio, septingentorum milium. Tertium est contra septentriones; cui parti nulla est obiecta terra, sed eius angulus lateris maxime ad Germaniam spectat. Hoc milia passuum octingenta in longitudinem esse existimatur. Ita omnis insula est in circuitu vicies centum milium passuum.
[14] Ex his omnibus longe sunt humanissimi qui Cantium incolunt, quae regio est maritima omnis, neque multum a Gallica differunt consuetudine. Interiores plerique frumenta non serunt, sed lacte et carne vivunt pellibusque sunt vestiti. Omnes vero se Britanni vitro inficiunt, quod caeruleum efficit colorem, atque hoc horridiores sunt in pugna aspectu; capilloque sunt promisso atque omni parte corporis rasa praeter caput et labrum superius. Uxores habent deni duodenique inter se communes et maxime fratres cum fratribus parentesque cum liberis; sed qui sunt ex his nati, eorum habentur liberi, quo primum virgo quaeque deducta est.
[15] Equites hostium essedariique acriter proelio cum equitatu nostro in itinere conflixerunt, tamen ut nostri omnibus partibus superiores fuerint atque eos in silvas collesque compulerint; sed compluribus interfectis cupidius insecuti nonnullos ex suis amiserunt. At illi intermisso spatio imprudentibus nostris atque occupatis in munitione castrorum subito se ex statione pro castris collocati, acriter pugnaverunt, duabusque missis subsidio cohortibus a Caesare atque eis primis legionum duarum, cum hae perexiguo intermisso loci spatio inter se constitissent, novo genere pugnae perterritis nostris per medios audacissime perruperunt seque inde incolumes receperunt. Eo die Quintus Laberius Durus, tribunus militum, interficitur. Illi pluribus submissis cohortibus repelluntur.
[16] Toto hoc in genere pugnae, cum sub oculis omnium ac pro castris dimicaretur, intellectum est nostros propter gravitatem armorum, quod neque insequi cedentes possent neque ab signis discedere auderent, minus aptos esse ad huius generis hostem, equites autem magno cum periculo proelio dimicare, propterea quod illi etiam consulto plerumque cederent et, cum paulum ab legionibus nostros removissent, ex essedis desilirent et pedibus dispari proelio contenderent. Equestris autem proeli ratio et cedentibus et insequentibus par atque idem periculum inferebat. Accedebat huc ut numquam conferti sed rari magnisque intervallis proeliarentur stationesque dispositas haberent, atque alios alii deinceps exciperent, integrique et recentes defetigatis succederent.
[17] Postero die procul a castris hostes in collibus constiterunt rarique se ostendere et lenius quam pridie nostros equites proelio lacessere coeperunt. Sed meridie, cum Caesar pabulandi causa tres legiones atque omnem equitatum cum Gaio Trebonio legato misisset, repente ex omnibus partibus ad pabulatores advolaverunt, sic uti ab signis legionibusque non absisterent. Nostri acriter in eos impetu facto reppulerunt neque finem sequendi fecerunt, quoad subsidio confisi equites, cum post se legiones viderent, praecipites hostes egerunt magnoque eorum numero interfecto neque sui colligendi neque consistendi aut ex essedis desiliendi facultatem dederunt. Ex hac fuga protinus, quae undique convenerant, auxilia discesserunt, neque post id tempus umquam summis nobiscum copiis hostes contenderunt.
[18] Caesar cognito consilio eorum ad flumen Tamesim in fines Cassivellauni exercitum duxit; quod flumen uno omnino loco pedibus, atque hoc aegre, transiri potest. Eo cum venisset, animum advertit ad alteram fluminis ripam magnas esse copias hostium instructas. Ripa autem erat acutis sudibus praefixis munita, eiusdemque generis sub aqua defixae sudes flumine tegebantur. His rebus cognitis a captivis perfugisque Caesar praemisso equitatu confestim legiones subsequi iussit. Sed ea celeritate atque eo impetu milites ierunt, cum capite solo ex aqua exstarent, ut hostes impetum legionum atque equitum sustinere non possent ripasque dimitterent ac se fugae mandarent.
[19] Cassivellaunus, ut supra demonstravimus, omni deposita spe contentionis dimissis amplioribus copiis milibus circiter quattuor essedariorum relictis itinera nostra servabat paulumque ex via excedebat locisque impeditis ac silvestribus sese occultabat, atque eis regionibus quibus nos iter facturos cognoverat pecora atque homines ex agris in silvas compellebat et, cum equitatus noster liberius praedandi vastandique causa se in agros eiecerat, omnibus viis semitisque essedarios ex silvis emittebat et magno cum periculo nostrorum equitum cum eis confligebat atque hoc metu latius vagari prohibebat. Relinquebatur ut neque longius ab agmine legionum discedi Caesar pateretur, et tantum in agris vastandis incendiisque faciendis hostibus noceretur, quantum labore atque itinere legionarii milites efficere poterant.
[20] Interim Trinobantes, prope firmissima earum regionum civitas, ex qua Mandubracius adulescens Caesaris fidem secutus ad eum in continentem Galliam venerat, cuius pater in ea civitate regnum obtinuerat interfectusque erat a Cassivellauno, ipse fuga mortem vitaverat, legatos ad Caesarem mittunt pollicenturque sese ei dedituros atque imperata facturos; petunt, ut Mandubracium ab iniuria Cassivellauni defendat atque in civitatem mittat, qui praesit imperiumque obtineat. His Caesar imperat obsides quadraginta frumentumque exercitui Mandubraciumque ad eos mittit. Illi imperata celeriter fecerunt, obsides ad numerum frumentumque miserunt.
[21] Trinobantibus defensis adque ab omni militum niuria prohibitis Cenimagni, Segontiaci, Ancalites, Bibroci, Cassi legationibus missis sese Caesari dedumt. Ab his cognoscit non longe ex eo loco oppidum Cassivellauni abesse silvis paludibusque munitum, quo satis magnus hominum pecorisque numerus onvenerit. Oppidum autem Britanni vocant, cum silvas impeditas vallo atque fossa munierunt, quo incursionis hostium vitandae causa convenire consuerunt. Eo proficiscitur cum legionibus: locum reperit egregie natura atque opere munitum; tamen hunc duabus ex partibus oppugnare contendit. Hostes paulisper morati militum nostrorum impetum non tulerunt seseque alia ex parte oppidi eiecerunt. Magnus ibi numerus pecoris repertus, multique in fuga sunt comprehensi atque interfecti.
[22] Dum haec in his locis geruntur, Cassivellaunus ad Cantium, quod esse ad mare supra demonstravimus, quibus regionibus quattuor reges praeerant, Cingetorix, Carvilius, Taximagulus, Segovax, nuntios mittit atque eis imperat uti coactis omnibus copiis castra navalia de improviso adoriantur atque oppugent. Ei cum ad castra venissent, nostri eruptione facta multis eorum interfectis, capto etiam nobili duce Lugotorige suos incolumes reduxerunt. Cassivellaunus hoc proelio nuntiato tot detrimentis acceptis, vastatis finibus, maxime etiam permotus defectione civitatum legatos per Atrebatem Commium de deditione ad Caesarem mittit. Caesar, cum constituisset hiemare in continenti propter repentinos Galliae motus, neque multum aestatis superesset, atque id facile extrahi posse intellegeret, obsides imperat et quid in annos singulos vectigalis populo Romano Britannia penderet constituit; interdicit atque imperat Cassivellauno, ne Mandubracio neu Trinobantibus noceat.
[23] Obsidibus acceptis exercitum reducit ad mare, naves invenit refectas. His deductis, quod et captivorum magnum numerum habebat, et nonnullae tempestate deperierant naves, duobus commeatibus exercitum reportare instituit. Ac sic accidit, uti ex tanto navium numero tot navigationibus neque hoc neque superiore anno ulla omnino navis, quae milites portaret, desideraretur; at ex eis, quae inanes ex continenti ad eum remitterentur et prioris commeatus eitis militibus et quas postea Labienus faciendas curaverat numero LX, perpaucae locum caperent, reliquae fere omnes reicerentur. Quas cum aliquamdiu Caesar frustra exspectasset, ne anni tempore a navigatione excluderetur, quod aequinoctium suberat, necessario angustius milites collocavit ac summa tranquillitate consecuta, secunda inita cum solvisset vigilia, prima luce terram attigit omnesque incolumes naves perduxit.
[24] Subductis navibus concilioque Gallorum Samarobrivae peracto, quod eo anno frumentum in Gallia propter siccitates angustius provenerat, coactus est aliter ac superioribus annis exercitum in hibernis collocare legionesque in plures civitates distribuere. Ex quibus unam in Morinos ducendam Gaio Fabio legato dedit, alteram in Nervios Quinto Ciceroni, tertiam in Esubios Lucio Roscio; quartam in Remis cum Tito Labieno in confinio Treverorum hiemare iussit. Tres in Belgis collocavit: eis Marcum Crassum quaestorem et Lucium Munatium Plancum et Gaium Trebonium legatos praefecit. Unam legionem, quam proxime trans Padum conscripserat, et cohortes V in Eburones, quorum pars maxima est inter Mosam ac Rhenum, qui sub imperio Ambiorigis et Catuvolci erant, misit. Eis militibus Quintum Titurium Sabinum et Lucium Aurunculeium Cottam legatos praeesse iussit. Ad hunc modum distributis legionibus facillime inopiae frumentariae sese mederi posse existimavit. Atque harum tamen omnium legionum hiberna praeter eam, quam Lucio Roscio im pacatissimam et quietissimam partem ducendam dederat, milibus passuum centum continebantur. Ipse interea, quoad legiones collocatas munitaque hiberna cognovisset, in Gallia morari constituit.
[25] Erat in Carnutibus summo loco natus Tasgetius, cuius maiores in sua civitate regnum obtinuerant. Huic Caesar pro eius virtute atque in se benevolentia, quod in omnibus bellis singulari eius opera fuerat usus, maiorum locum restituerat. Tertium iam hunc annum regnantem inimici, multis palam ex civitate eius auctoribus, eum interfecerunt. Defertur ea res ad Caesarem. Ille veritus, quod ad plures pertinebat, ne civitas eorum impulsu deficeret, Lucium Plancum cum legione ex Belgio celeriter in Carnutes proficisci iubet ibique hiemare quorumque opera cognoverat Tasgetium interfectum, hos comprehensos ad se mittere. Interim ab omnibus legatis quaestoreque, quibus legiones tradiderat, certior factus est in hiberna perventum locumque hibernis esse munitum.
[26] Diebus circiter XV, quibus in hiberna ventum est, initium repentini tumultus ac defectionis ortum est ab Ambiorige et Catuvolco; qui, cum ad fines regni sui Sabino Cottaeque praesto fuissent frumentumque in hiberna comportavissent, Indutiomari Treveri nuntiis impulsi suos concitaverunt subitoque oppressis lignatoribus magna manu ad castra oppugnatum venerunt. Cum celeriter nostri arma cepissent vallumque adscendissent atque una ex parte Hispanis equitibus emissis equestri proelio superiores fuissent, desperata re hostes suos ab oppugnatione reduxerunt. Tum suo more conclamaverunt, uti aliqui ex nostris ad colloquium prodiret: habere sese, quae de re communi dicere vellent, quibus rebus controversias minui posse sperarent.
[27] Mittitur ad eos colloquendi causa Gaius Arpineius, eques Romanus, familiaris Quinti Tituri, et Quintus Iunius ex Hispania quidam, qui iam ante missu Caesaris ad Ambiorigem ventitare consuerat; apud quos Ambiorix ad hunc modum locutus est: Sese pro Caesaris in se beneficiis plurimum ei confiteri debere, quod eius opera stipendio liberatus esset, quod Aduatucis, finitimis suis, pendere consuesset, quodque ei et filius et fratris filius ab Caesare remissi essent, quos Aduatuci obsidum numero missos apud in servitute et catenis tenuissent; neque id, quod fecerit de oppugnatione castrorum, aut iudicio aut voluntate sua fecisse, sed coactu civitatis, suaque esse eiusmodi imperia, ut non minus haberet iuris in se multitudo quam ipse in multitudinem. Civitati porro hanc fuisse belli causam, quod repentinae Gallorum coniurationi resistere non potuerit. Id se facile ex humilitate sua probare posse, quod non adeo sit imperitus rerum ut suis copiis populum Romanum superari posse confidat. Sed esse Galliae commune consilium: omnibus hibernis Caesaris oppugnandis hunc esse dictum diem, ne qua legio alterae legioni subsidio venire posset. Non facile Gallos Gallis negare potuisse, praesertim cum de recuperanda communi libertate consilium initum videretur. Quibus quoniam pro pietate satisfecerit, habere nunc se rationem offici pro beneficiis Caesaris: monere, orare Titurium pro hospitio, ut suae ac militum saluti consulat. Magnam manum Germanorum conductam Rhenum transisse; hanc adfore biduo. Ipsorum esse consilium, velintne priusquam finitimi sentiant eductos ex hibernis milites aut ad Ciceronem aut ad Labienum deducere, quorum alter milia passuum circiter quinquaginta, alter paulo amplius ab eis absit. Illud se polliceri et iureiurando confirmare tutum iter per fines daturum. Quod cum faciat, et civitati sese consulere, quod hibernis levetur, et Caesari pro eius meritis gratiam referre. Hac oratione habita discedit Ambiorix.
[28] Arpineius et Iunius, quae audierunt, ad legatoc deferunt. Illi repentina re perturbati, etsi ab hoste ea dicebantur, tamen non neglegenda existimabant maximeque hac re permovebantur, quod civitatem ignobilem atque humilem Eburonum sua sponte populo Romano bellum facere ausam vix erat credendum. Itaque ad consilium rem deferunt magnaque inter eos exsistit controversia. Lucius Aurunculeius compluresque tribuni militum et primorum ordinum centuriones nihil temere agendum neque ex hibernis iniussu Caesaris discedendum existimabant: quantasvis
[magnas] copias etiam Germanorum sustineri posse munitis hibernis docebant: rem esse testimonio, quod primum hostium impetum multis ultro vulneribus illatis fortissime sustinuerint: re frumentaria non premi; interea et ex proximis hibernis et a Caesare conventura subsidia: postremo quid esse levius aut turpius, quam auctore hoste de summis rebus capere consilium?
[29] Contra ea Titurius sero facturos clamitabat, cum maiores manus hostium adiunctis Germanis convenissent aut cum aliquid calamitatis in proximis hibernis esset acceptum. Brevem consulendi esse occasionem. Caesarem arbitrari profectum in Italiam; neque aliter Calnutcs interficiendi Tasgeti consilium fuisse capturos, neque Eburones, si ille adesset, tanta contemptione nostri ad castra venturos esse. Non hostem auctorem, sed rem spectare: subesse Rhenum; magno esse Germanis dolori Ariovisti mortem et superiores nostras victorias; ardere Galliam tot contumeliis acceptis sub populi Romani imperium redactam superiore gloria rei militaris exstincta. Postremo quis hoc sibi persuaderet, sine certa re Ambiorigem ad eiusmodi consilium descendisse? Suam sententiam in utramque partem esse tutam: si nihil esset durius, nullo cum periculo ad proximam legionem perventuros; si Gallia omnis cum Germanis consentiret, unam esse in celeritate positam salutem. Cottae quidem atque eorum, qui dissentirent, consilium quem habere exitum? In quo si non praesens periculum, at certe longinqua obsidione fames esset timenda.
[30] Hac in utramque partem disputatione habita, cum a Cotta primisque ordinibus acriter resisteretur, "Vincite," inquit, "si ita vultis," Sabinus, et id clariore voce, ut magna pars militum exaudiret; "neque is sum," inquit, "qui gravissime ex vobis mortis periculo terrear: hi sapient; si gravius quid acciderit, abs te rationem reposcent, qui, si per te liceat, perendino die cum proximis hibernis coniuncti communem cum reliquis belli casum sustineant, non reiecti et relegati longe ab ceteris aut ferro aut fame intereant."
[31] Consurgitur ex consilio; comprehendunt utrumque et orant, ne sua dissensione et pertinacia rem in summum periculum deducat: facilem esse rem, seu maneant, seu proficiscantur, si modo unum omnes sentiant ac probent; contra in dissensione nullam se salutem perspicere. Res disputatione ad mediam noctem perducitur. Tandem dat Cotta permotus manus: superat sententia Sabini. Pronuntiatur prima luce ituros. Consumitur vigiliis reliqua pars noctis, cum sua quisque miles circumspiceret, quid secum portare posset, quid ex instrumento hibernorum relinquere cogeretur. Omnia excogitantur, quare nec sine periculo maneatur, et languore militum et vigiliis periculum augeatur. Prima luce sic ex castris proficiscuntur, ut quibus esset persuasum non ab hoste, sed ab homine amicissimo Ambiorige consilium datum, longissimo agmine maximisque impedimentis.
[32] At hostes, posteaquam ex nocturno fremitu vigiliisque de profectione eorum senserunt, collocatis insidiis bipertito in silvis opportuno atque occulto loco a milibus passuum circiter duobus Romanorum adventum exspectabant, et cum se maior pars agminis in magnam convallem demisisset, ex utraque parte eius vallis subito se ostenderunt novissimosque premere et primos prohibere ascensu atque iniquissimo nostris loco proelium committere coeperunt.
[33] Tum demum Titurius, qui nihil ante providisset, trepidare et concursare cohortesque disponere, haec tamen ipsa timide atque ut eum omnia deficere viderentur; quod plerumque eis accidere consuevit, qui in ipso negotio consilium capere coguntur. At Cotta, qui cogitasset haec posse in itinere accidere atque ob eam causam profectionis auctor non fuisset, nulla in re communi saluti deerat et in appellandis cohortandisque militibus imperatoris et in pugna militis officia praestabat. Cum propter longitudinem agminis minus facile omnia per se obire et, quid quoque loco faciendum esset, providere possent, iusserunt pronuntiare, ut impedimenta relinquerent atque in orbem consisterent. Quod consilium etsi in eiusmodi casu reprehendendum non est, tamen incommode accidit: nam et nostris militibus spem minuit et hostes ad pugnam alacriores effecit, quod non sine summo timore et desperatione id factum videbatur. Praeterea accidit, quod fieri necesse erat, ut vulgo milites ab signis discederent, quae quisque eorum carissima haberet, ab impedimentis petere atque arripere properaret, clamore et fletu omnia complerentur.
[34] At barbaris consilium non defuit. Nam duces eorum tota acie pronuntiare iusserunt, ne quis ab loco discederet: illorum esse praedam atque illis reservari quaecumque Romani reliquissent: proinde omnia in victoria posita existimarent. Erant et virtute et studio pugnandi pares; nostri, tametsi ab duce et a fortuna deserebantur, tamen omnem spem salutis in virtute ponebant, et quotiens quaeque cohors procurrerat, ab ea parte magnus numerus hostium cadebat. Qua re animadversa Ambiorix pronuntiari iubet, ut procul tela coniciant neu propius accedant et, quam in partem Romani impetum fecerint, cedant (levitate armorum et cotidiana exercitatione nihil eis noceri posse), rursus se ad signa recipientes insequantur.
[35] Quo praecepto ab eis diligentissime observato, cum quaepiam cohors ex orbe excesserat atque impetum fecerat, hostes velocissime refugiebant. Interim eam partem nudari necesse erat et ab latere aperto tela recipi. Rursus cum in eum locum unde erant egressi reverti coeperant, et ab eis qui cesserant et ab eis qui proximi steterant circumveniebantur; sin autem locum tenere vellent, nec virtuti locus relinquebatur, neque ab tanta multitudine coniecta tela conferti vitare poterant. Tamen tot incommodis conflictati, multis vulneribus acceptis resistebant et magna parte diei consumpta, cum a prima luce ad horam octavam pugnaretur, nihil quod ipsis esset indignum committebant. Tum Tito Balventio, qui superiore anno primum pilum duxerat, viro forti et magnae auctoritatis, utrumque femur tragula traicitur; Quintus Lucanius, eiusdem ordinis, fortissime pugnans, dum circumvento filio subvenit, interficitur; Lucius Cotta legatus omnes cohortes ordinesque adhortans in adversum os funda vulneratur.
[36] His rebus permotus Quintus Titurius, cum procul Ambiorigem suos cohortantem conspexisset, interpretem suum Gnaeum Pompeium ad eum mittit rogatum ut sibi militibusque parcat. Ille appellatus respondit: si velit secum colloqui, licere; sperare a multitudine impetrari posse, quod ad militum salutem pertineat; ipsi vero nihil nocitum iri, inque eam rem se suam fidem interponere. Ille cum Cotta saucio communicat, si videatur, pugna ut excedant et cum Ambiorige una colloquantur: sperare ab eo de sua ac militum salute impetrari posse. Cotta se ad armatum hostem iturum negat atque in eo perseverat.
[37] Sabinus quos in praesentia tribunos militum circum se habebat et primorum ordinum centuriones se sequi iubet et, cum propius Ambiorigem accessisset, iussus arma abicere imperatum facit suisque ut idem faciant imperat. Interim, dum de condicionibus inter se agunt longiorque consulto ab Ambiorige instituitur sermo, paulatim circumventus interficitur. Tum vero suo more victoriam conclamant atque ululatum tollunt impetuque in nostros facto ordines perturbant. Ibi Lucius Cotta pugnans interficitur cum maxima parte militum. Reliqui se in castra recipiunt unde erant egressi. Ex quibus Lucius Petrosidius aquilifer, cum magna multitudine hostium premeretur, aquilam intra vallum proiecit; ipse pro castris fortissime pugnans occiditur. Illi aegre ad noctem oppugnationem sustinent; noctu ad unum omnes desperata salute se ipsi interficiunt. Pauci ex proelio lapsi incertis itineribus per silvas ad Titum Labienum legatum in hiberna perveniunt atque eum de rebus gestis certiorem faciunt.
[38] Hac victoria sublatus Ambiorix statim cum equitatu in Aduatucos, qui erant eius regno finitimi, proficiscitur; neque noctem neque diem intermittit pedita tumque subsequi iubet. Re demonstrata Aduatucisque concitatis postero die in Nervios pervenit hortaturque, ne sui in perpetuum liberandi atque ulciscendi Romanos pro eis quas acceperint iniuriis occasionem dimittant: interfectos esse legatos duos magnamque partem exercitus interisse demonstrat; nihil esse negoti subito oppressam legionem quae cum Cicerone hiemet interfici; se ad eam rem profitetur adiutorem. Facile hac oratione Nerviis persuadet.
[39] Itaque confestim dimissis nuntiis ad Ceutrones, Grudios, Levacos, Pleumoxios, Geidumnos, qui omnes sub eorum imperio sunt, quam maximas manus possunt cogunt et de improviso ad Ciceronis hiberna advolant nondum ad eum fama de Tituri morte perlata. Huic quoque accidit, quod fuit necesse, ut nonnulli milites, qui lignationis munitionisque causa in silvas discessissent, repentino equitum adventu interciperentur. His circumventis magna manu Eburones, Nervii, Aduatuci atque horum omnium socii et clientes legionem oppugnare incipiunt. Nostri celeriter ad arma concurrunt, vallum conscendunt. Aegre is dies sustentatur, quod omnem spem hostes in celeritate ponebant atque hanc adepti victoriam in perpetuum se fore victores confidebant.
[40] Mittuntur ad Caesarem confestim ab Cicerone litterae magnis propositis praemiis, si pertulissent: obsessis omnibus viis missi intercipiuntur. Noctu ex materia, quam munitionis causa comportaverant, turres admodum CXX excitantur incredibili celeritate; quae deesse operi videbantur, perficiuntur. Hostes postero die multo maioribus coactis copiis castra oppugnant, fossam complent. Eadem ratione, qua pridie, ab nostris resistitur. Hoc idem reliquis deinceps fit diebus. Nulla pars nocturni temporis ad laborem intermittitur; non aegris, non vulneratis facultas quietis datur. Quaecumque ad proximi diei oppugnationem opus sunt noctu comparantur; multae praeustae sudes, magnus muralium pilorum numerus instituitur; turres contabulantur, pinnae loricaeque ex cratibus attexuntur. Ipse Cicero, cum tenuissima valetudine esset, ne nocturnum quidem sibi tempus ad quietem relinquebat, ut ultro militum concursu ae vocibus sibi parcere cogeretur.
[41] Tunc duces principesque Nerviorum qui aliquem sermonis aditum causamque amicitiae cum Cicerone habebant colloqui sese velle dicunt. Facta potestate eadem quae Ambiorix cum Titurio egerat commemorant: omnem esse in armis Galliam; Germanos Rhenum transisse; Caesaris reliquorumque hiberna oppugnari. Addunt etiam de Sabini morte: Ambiorigem ostentant fidei faciendae causa. Errare eos dicunt, si quidquam ab his praesidi sperent, qui suis rebus diffidant; sese tamen hoc esse in Ciceronem populumque Romanum animo, ut nihil nisi hiberna recusent atque hanc inveterascere consuetudinem nolint: licere illis incolumibus per se ex hibernis discedere et quascumque in partes velint sine metu proficisci. Cicero ad haec unum modo respondit: non esse consuetudinem populi Romani accipere ab hoste armato condicionem: si ab armis discedere velint, se adiutore utantur legatosque ad Caesarem mittant; sperare pro eius iustitia, quae petierint, impetraturos.
[42] Ab hac spe repulsi Nervii vallo pedum IX et fossa pedum XV hiberna cingunt. Haec et superiorum annorum consuetudine ab nobis cognoverant et, quos clam de exercitu habebant captivos, ab eis docebantur; sed nulla ferramentorum copia quae esset ad hunc usum idonea, gladiis caespites circumcidere, manibus sagulisque terram exhaurire nitebantur. Qua quidem ex re hominum multitudo cognosci potuit: nam minus horis tribus milium pedum XV in circuitu munitionem perfecerunt reliquisque diebus turres ad altitudinem valli, falces testudinesque, quas idem captivi docuerant, parare ac facere coeperunt.
[43] Septimo oppugnationis die maximo coorto vento ferventes fusili ex argilla glandes fundis et fervefacta iacula in casas, quae more Gallico stramentis erant tectae, iacere coeperunt. Hae celeriter ignem comprehenderunt et venti magnitudine in omnem locum castrorum distulerunt. Hostes maximo clamore sicuti parta iam atque explorata victoria turres testudinesque agere et scalis vallum ascendere coeperunt. At tanta militum virtus atque ea praesentia animi fuit, ut, cum undique flamma torrerentur maximaque telorum multitudine premerentur suaque omnia impedimenta atque omnes fortunas conflagrare intellegerent, non modo demigrandi causa de vallo decederet nemo, sed paene ne respiceret quidem quisquam, ac tum omnes acerrime fortissimeque pugnarent. Hic dies nostris longe gravissimus fuit; sed tamen hunc habuit eventum, ut eo die maximus numerus hostium vulneraretur atque interficeretur, ut se sub ipso vallo constipaverant recessumque primis ultimi non dabant. Paulum quidem intermissa flamma et quodam loco turri adacta et contingente vallum tertiae cohortis centuriones ex eo, quo stabant, loco recesserunt suosque omnes removerunt, nutu vocibusque hostes, si introire vellent, vocare coeperunt; quorum progredi ausus est nemo. Tum ex omni parte lapidibus coniectis deturbati, turrisque succensa est.
[44] Erant in ea legione fortissimi viri, centuriones, qui primis ordinibus appropinquarent, Titus Pullo et Lucius Vorenus. Hi perpetuas inter se controversias habebant, quinam anteferretur, omnibusque annis de locis summis simultatibus contendebant. Ex his Pullo, cum acerrime ad munitiones pugnaretur, "Quid dubitas," inquit, " Vorene? aut quem locum tuae probandae virtutis exspectas ? hic dies de nostris controversiis iudicabit." Haec cum dixisset, procedit extra munitiones quaque pars hostium confertissma est visa irrumpit. Ne Vorenus quidem tum sese vallo continet, sed omnium veritus existi mationem subsequitur. Mediocri spatio relicto Pullo pilum in hostes immittit atque unum ex multitudine procurrentem traicit; quo percusso et exanimato hunc scutis protegunt, in hostem tela universi coniciunt neque dant regrediendi facultatem. Transfigitur scutum Pulloni et verutum in balteo defigitur. Avertit hic casus vaginam et gladium educere conanti dextram moratur manum, impeditumque hostes circumsistunt. Succurrit inimicus illi Vorenus et laboranti subvenit. Ad hunc se confestim a Pullone omnis multitudo convertit: illum veruto arbitrantur occisum. Gladio comminus rem gerit Vorenus atque uno interfecto reliquos paulum propellit; dum cupidius instat, in locum deiectus inferiorem concidit. Huic rursus circumvento fert subsidium Pullo, atque ambo incolumes compluribus interfectis summa cum laude sese intra munitiones recipiunt. Sic fortuna in contentione et certamine utrumque versavit, ut alter alteri inimicus auxilio salutique esset, neque diiudicari posset, uter utri virtute anteferendus videretur.
[45] Quanto erat in dies gravior atque asperior oppugnatio, et maxime quod magna parte militum confecta vulneribus res ad paucitatem defensorum pervenerat, tanto crebriores litterae nuntiique ad Caesarem mittebantur; quorum pars deprehensa in conspectu nostrorum militum cum cruciatu necabatur. Erat unus intus Nervius nomine Vertico, loco natus honesto, qui a prima obsidione ad Ciceronem perfugerat suamque ei fidem praestiterat. Hic servo spe libertatis magnisque persuadet praemiis, ut litteras ad Caesarem deferat. Has ille in iaculo illigatas effert et Gallus inter Gallos sine ulla suspicione versatus ad Caesarem pervenit. Ab eo de periculis Ciceronis legionisque cognoscitur.
[46] Caesar acceptis litteris hora circiter XI diei statim nuntium in Bellovacos ad M. Crassum quaestorem mittit, cuius hiberna aberant ab eo milia passuum XXV; iubet media nocte legionem proficisci celeriterque ad se venire. Exit cum nuntio Crassus. Alterum ad Gaium Fabium legatum mittit, ut in Atrebatium fines legionem adducat, qua sibi iter faciendum sciebat. Scribit Labieno, si rei publicae commodo facere posset, cum legione ad fines Nerviorum veniat. Reliquam partem exercitus, quod paulo aberat longius, non putat exspectandam; equites circiter quadringentos ex proximis hibernis colligit.
[47] Hora circiter tertia ab antecursoribus de Crassi adventu certior factus eo die milia passuum XX pro cedit. Crassum Samarobrivae praeficit legionemque attribuit, quod ibi impedimenta exercitus, obsides civitatum, litteras publicas frumentumque omne quod eo tolerandae hiemis causa devexerat relinquebat. Fabius, ut imperatum erat, non ita multum moratus in itinere cum legione occurrit. Labienus interitu Sabini et caede cohortium cognita, cum omnes ad eum Treverorum copiae venissent, veritus, si ex hibernis fugae similem profectionem fecisset, ut hostium impetum sustinere posset, praesertim quos recenti victoria efferri sciret, litteras Caesari remittit, quanto cum periculo legionem ex hibernis educturus esset; rem gestam in Eburonibus perscribit; docet omnes equitatus peditatusque copias Treverorum tria milia passuum longe ab suis castris consedisse.
[48] Caesar consilio eius probato, etsi opinione trium legionum deiectus ad duas redierat, tamen unum communis salutis auxilium in celeritate ponebat. Venit magnis itineribus in Nerviorum fines. Ibi ex captivis cognoscit, quae apud Ciceronem gerantur, quantoque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis magnis praemiis persuadet uti ad Ciceronem epistolam deferat. Hanc Graecis conscriptam litteris mittit, ne intercepta epistola nostra ab hostibus consilia cognoscantur. Si adire non possit, monet ut tragulam cum epistola ad amentum deligata intra munitionem castrorum abiciat. In litteris scribit se cum legionibus profectum celeriter adfore; hortatur ut pristinam virtutem retineat. Gallus periculum veritus, ut erat praeceptum, tragulam mittit. Haec casu ad turrim adhaesit neque ab nostris biduo animadversa tertio die a quodam milite conspicitur, dempta ad Ciceronem defertur. Ille perlectam in conventu militum recitat maximaque omnes laetitia adficit. Tum fumi incendiorum procul videbantur; quae res omnem dubitationem adventus legionum expulit.
[49] Galli re cognita per exploratores obsidionem relinquunt, ad Caesarem omnibus copiis contendunt. Hae erant armata circiter milia LX. Cicero data facultate Gallum ab eodem Verticone, quem supra demonstravimus, repetit, qui litteras ad Caesarem deferat; hunc admonet, iter caute diligenterque faciat: perscribit in litteris hostes ab se discessisse omnemque ad eum multitudinem convertisse. Quibus litteris circiter media nocte Caesar adlatis suos facit certiores eosque ad dimicandum animo confirmat. Postero die luce prima movet castra et circiter milia passuum quattuor progressus trans vallem et rivum multitudinem hostium conspicatur. Erat magni periculi res tantulis copiis iniquo loco dimicare; tum, quoniam obsidione liberatum Ciceronem sciebat, aequo animo remittendum de celeritate existimabat: consedit et quam aequissimo loco potest castra communit atque haec, etsi erant exigua per se vix hominum milium septem praesertim nullis cum impedimentis, tamen angustiis viarum quam maxime potest contrahit, eo consilio, ut in summam contemptionem hostibus veniat. Interim speculatoribus in omnes partes dimissis explorat quo commodissime itinere vallem transire possit.
[50] Eo die parvulis equestribus proeliis ad aquam factis utrique sese suo loco continent: Galli, quod ampliores copias, quae nondum convenerant, exspectabant; Caesar, si forte timoris simulatione hostes in suum locum elicere posset, ut citra vallem pro castris proelio contenderet, si id efficere non posset, ut exploratis itineribus minore cum periculo vallem rivumque transiret. Prima luce hostium equitatus ad castra accedit proeliumque cum nostris equitibus committit. Caesar consulto equites cedere seque in castra recipere iubet, simul ex omnibus partibus castra altiore vallo muniri portasque obstrui atque in his administrandis rebus quam maxime concursari et cum simulatione agi timoris iubet.
[51] Quibus omnibus rebus hostes invitati copias traducunt aciemque iniquo loco constituunt, nostris vero etiam de vallo deductis propius accedunt et tela intra munitionem ex omnibus partibus coniciunt praeconibusque circummissis pronuntiari iubent, seu quis Gallus seu Romanus velit ante horam tertiam ad se transire, sine periculo licere; post id tempus non fore potestatem: ac sic nostros contempserunt, ut obstructis in speciem portis singulis ordinibus caespitum, quod ea non posse introrumpere videbantur, alii vallum manu scindere, alii fossas complere inciperent. Tum Caesar omnibus portis eruptione facta equitatuque emisso celeriter hostes in fugam dat, sic uti omnino pugnandi causa resisteret nemo, magnumque ex eis numerum occidit atque omnes armis exuit.
[52] Longius prosequi veritus, quod silvae paludesque intercedebant neque etiam parvulo detrimento illorum locum relinqui videbat, omnibus suis incolumibus copiis eodem die ad Ciceronem pervenit. Institutas turres, testudines munitionesque hostium admiratur; legione producta cognoscit non decimum quemque esse reliquum militem sine vulnere: ex his omnibus iudicat rebus, quanto cum periculo et quanta cum virtute res sint administratae. Ciceronem pro eius merito legionemque collaudat; centuriones singillatim tribunosquc militum appellat, quorum egregiam fuisse virtutem testimonio Ciceronis cognoverat. De casu Sabini et Cottae certius ex captivis cognoscit. Postero die contione habita rem gestam proponit, milites consolatur et confirmat: quod detrimentum culpa et temeritate legati sit acceptum, hoc aequiore animo ferendum docet, quod beneficio deorum immortalium et virtute eorum expiato incommodo neque hostibus diutina laetatio neque ipsis longior dolor relinquatur.
[53] Interim ad Labienum per Remos incredibili celeritate de victoria Caesaris fama perfertur, ut, cum ab hibernis Ciceronis milia passuum abesset circiter LX, eoque post horam nonam diei Caesar pervenisset, ante mediam noctem ad portas castrorum clamor oreretur, quo clamore significatio victoriae gratulatioque ab Remis Labieno fieret. Hac fama ad Treveros perlata Indutiomarus, qui postero die castra Labieni oppugnare decreverat, noctu profugit copiasque omnes in Treveros reducit. Caesar Fabium cum sua legione remittit in hiberna, ipse cum tribus legionibus circum Samarobrivam trinis hibernis hiemare constituit et, quod tanti motus Galliae exstiterant, totam hiemem ipse ad exercitum manere decrevit. Nam illo incommodo de Sabini morte perlato omnes fere Galliae civitates de bello consultabant, nuntios legationesque in omnes partes dimittebant et quid reliqui consili caperent atque unde initium belli fieret explorabant nocturnaque in locis desertis concilia habebant. Neque ullum fere totius hiemis tempus sine sollicitudine Caesaris intercessit, quin aliquem de consiliis ac motu Gallorum nuntium acciperet. In his ab Lucio Roscio, quem legioni tertiae decimae praefecerat, certior factus est magnas Gallorum copias earum civitatum, quae Armoricae appellantur, oppugnandi sui causa convenisse neque longius milia passuum octo ab hibernis suis afuisse, sed nuntio allato de victoria Caesaris discessisse, adeo ut fugae similis discessus videretur.
[54] At Caesar principibus cuiusque civitatis ad se evocatis alias territando, cum se scire quae fierent denuntiaret, alias cohortando magnam partem Galliae in officio tenuit. Tamen Senones, quae est civitas in primis firma et magnae inter Gallos auctoritatis, Cavarinum, quem Caesar apud eos regem constituerat, cuius frater Moritasgus adventu in Galliam Caesaris cuiusque maiores regnum obtinuerant, interficere publico consilio conati, cum ille praesensisset ac profugisset, usque ad fines insecuti regno domoque expulerunt et, missis ad Caesarem satisfaciendi causa legatis, cum is omnem ad se senatum venire iussisset, dicto audientes non fuerunt. Tantum apud homines barbaros valuit esse aliquos repertos principes inferendi belli tantamque omnibus voluntatum commutationem attulit, ut praeter Aeduos et Remos, quos praecipuo semper honore Caesar habuit, alteros pro vetere ac perpetua erga populum Romanum fide, alteros pro recentibus Gallici belli officiis, nulla fere civitas fuerit non suspecta nobis. Idque adeo haud scio mirandumne sit, cum compluribus aliis de causis, tum maxime quod ei, qui virtute belli omnibus gentibus praeferebantur, tantum se eius opinionis deperdidisse ut a populo Romano imperia perferrent gravissime dolebant.
[55] Treveri vero atque Indutiomarus totius hiemis nullum tempus intermiserunt, quin trans Rhenum legatos mitterent, civitates sollicitarent, pecunias pollicerentur, magna parte exercitus nostri interfecta multo minorem superesse dicerent partem. Neque tamen ulli civitati Germanorum persuaderi potuit, ut Rhenum transiret, cum se bis expertos dicerent, Ariovisti bello et Tencterorum transitu: non esse amplius fortunam temptaturos. Hac spe lapsus Indutiomarus nihilo minus copias cogere, exercere, a finitimis equos parare, exules damnatosque tota Gallia magnis praemiis ad se allicere coepit. Ac tantam sibi iam his rebus in Gallia auctoritatem comparaverat ut undique ad eum legationes concurrerent, gratiam atque amicitiam publice privatimque peterent.
[56] Ubi intellexit ultro ad se veniri, altera ex parte Senones Carnutesque conscientia facinoris instigari, altera Nervios Aduatucosque bellum Romanis parare, neque sibi voluntariorum copias defore, si ex finibus suis progredi coepisset, armatum concilium indicit. Hoc more Gallorum est initium belli, quo lege communi omnes puberes armati convenire consuerunt; qui ex eis novissimus convenit, in conspectu multitudinis omnibus cruciatibus affectus necatur. In eo concilio Cingetorigem, alterius principem factionis, generum suum, quem supra demonstravimus Caesaris secutum fidem ab eo non discessisse, hostem iudicat bonaque eius publicat. His rebus confectis, in concilio pronuntiat arcessitum se a Senonibus et Carnutibus aliisque compluribus Galliae civitatibus; huc iturum per fines Remorum eorumque agros popula turum ac, priusquam id faciat, castra Labieni oppugnaturum. Quae fieri velit praecipit.
[57] Labienus, cum et loci natura et manu munitissumis castris sese teneret, de suo ac legionis periculo nihil timebat; ne quam occasionem rei bene gerendae dimitteret, cogitabat. Itaque a Cingetorige atque eius propinquis oratione Indutiomari cognita, quam in concilio habuerat, nuntios mittit ad finitimas civitates equitesque undique evocat: his certum diem conveniendi dicit. Interim prope cotidie cum omni equitatu Indutiomarus sub castris eius vagabatur, alias ut situm castrorum cognosceret, alias colloquendi aut territandi causa: equites plerumque omnes tela intra vallum coniciebant. Labienus suos intra munitionem continebat timorisque opinionem, quibuscumque poterat rebus, augebat.
[58] Cum maiore in dies contemptione Indutiomarus ad castra accederet, nocte una intromissis equitibus omnium finitimarum civitatum quos arcessendos curaverat, tanta diligentia omnes suos custodiis intra castra continuit, ut nulla ratione ea res enuntiari aut ad Treveros perferri posset. Interim ex consuetudine cotidiana Indutiomarus ad castra accedit atque ibi magnam partem diei consumit; equites tela coniciunt et magna cum contumelia verborum nostros ad pugnam evocant. Nullo ab nostris dato responso, ubi visum est, sub vesperum dispersi ac dissipati discedunt. Subito Labienus duabus portis omnem equitatum emittit; praecipit atque interdicit, proterritis hostibus atque in fugam coniectis (quod fore, sicut accidit, videbat) unum omnes peterent Indutiomarum, neu quis quem prius vulneret, quam illum interfectum viderit, quod mora reliquorum spatium nactum illum effugere nolebat; magna proponit eis qui occiderint praemia; summittit cohortes equitibus subsidio. Comprobat hominis consilium fortuna, et cum unum omnes peterent, in ipso fluminis vado deprehensus Indutiomarus interficitur, caputque eius refertur in castra: redeuntes equites quos possunt consectantur atque occidunt. Hac re cognita omnes Eburonum et Nerviorum quae convenerant copiae discedunt, pauloque habuit post id factum Caesar quietiorem Galliam. |
LIBRO QUINTO
[1
Sotto il consolato di L. Domizio e Ap. Claudio, Cesare, al momento di
lasciare i quartieri invernali per recarsi in Italia, come di consueto
ogni anno, ordina ai legati preposti alle legioni di costruire, durante
l'inverno, il maggior numero possibile di navi e di riparare le vecchie.
Ne indica la struttura e la forma: per garantire rapide operazioni di
imbarco e per tirarle con facilità in secco, le costruisce lievemente più
basse delle navi di solito impiegate nel nostro mare e, tanto più perché
aveva saputo che qui, per il frequente alternarsi delle maree, le onde
sono meno alte, allo scopo di facilitare il trasporto del carico e dei
giumenti, le rende un po' più larghe delle imbarcazioni che usiamo negli
altri mari. Ordina di costruirle tutte leggere, e a tale scopo
contribuiscono molto i bordi bassi. Comanda di far pervenire dalla Spagna
tutto il necessario per equipaggiarle. Dal canto suo, tenute le sessioni
giudiziarie in Gallia cisalpina, parte per l'Illirico, perché aveva
sentito che i Pirusti, con scorrerie, stavano devastando le regioni di
confine della nostra provincia. Una volta sul posto, chiede alle
popolazioni truppe in rinforzo e ordina di concentrarle in un luogo
stabilito. I Pirusti, appena lo sanno, inviano a Cesare emissari: gli
spiegano che tutto era accaduto senza una deliberazione ufficiale e si
dichiarano pronti a qualsiasi risarcimento dei danni. Dopo averli
ascoltati, Cesare esige ostaggi e fissa il giorno della consegna; in caso
contrario, dichiara che avrebbe mosso guerra. Secondo gli ordini,
consegnano gli ostaggi il giorno stabilito ed egli, per dirimere le
controversie tra le città, nomina dei giudici incaricati di calcolare i
danni e di stabilire i risarcimenti.
[2
Dopo tali provvedimenti e tenute le sessioni giudiziarie, Cesare ritorna
nella Gallia cisalpina e, da qui, parte alla volta dell'esercito. Appena
giunto, ispeziona tutti i campi invernali e trova che, nonostante la
carenza estrema di materiale, i soldati, grazie al loro straordinario
impegno, avevano costruito circa seicento imbarcazioni del tipo già
descritto e ventotto navi da guerra, in grado di essere varate entro pochi
giorni. Elogiati i soldati e gli ufficiali preposti ai lavori, impartisce
le istruzioni e ordina a tutti di radunarsi a Porto Izio, da dove sapeva
che il passaggio in Britannia era assai agevole, perché la distanza dal
continente era di circa trenta miglia: lasciò un presidio giudicato
sufficiente per tale operazione. Egli, alla testa di quattro legioni senza
bagagli e di ottocento cavalieri, punta sui territori dei Treveri, popolo
che non si presentava alle assemblee, non ubbidiva agli ordini e, a quel
che si diceva, sollecitava l'intervento dei Germani d'oltre Reno.
[3
I Treveri possiedono, tra tutti i Galli, la cavalleria più forte in
assoluto e una fanteria numerosa. I loro territori raggiungono, come si è
detto in precedenza, il Reno. Tra i Treveri due uomini lottavano per il
potere: Induziomaro e Cingetorige. Quest'ultimo, non appena giunge notizia
dell'arrivo di Cesare con le legioni, gli si presenta e, confermandogli
che lui e tutti i suoi avrebbero rispettato gli impegni assunti senza
tradire l'amicizia del popolo romano, lo mette al corrente della
situazione. Induziomaro, invece, inizia a raccogliere cavalieri e fanti e
a prepararsi alla guerra; chi, per ragioni d'età, non poteva combattere,
era stato posto al sicuro nella selva delle Ardenne, una foresta enorme,
che dal Reno attraverso la regione dei Treveri si estende sino al confine
dei Remi. Ma quando alcuni principi dei Treveri, spinti dai loro legami di
amicizia con Cingetorige e spaventati dall'arrivo del nostro esercito, si
recarono da Cesare e, non potendo provvedere per la nazione, cominciarono
a presentargli richieste per se stessi, anche Induziomaro, nel timore di
rimaner completamente solo, gli inviò emissari: non aveva voluto
abbandonare i suoi e presentarsi di persona a Cesare soltanto per poter
garantire, con maggior facilità, il rispetto degli impegni assunti; c'era
il rischio che il popolo, una volta lontani tutti i nobili, commettesse
imprudenze; i Treveri, dunque, erano sotto la sua autorità ed egli, se
Cesare lo permetteva, si sarebbe recato nell'accampamento romano per porre
se stesso e la propria gente sotto la sua protezione.
[4
Cesare, anche se capiva i motivi che avevano spinto Induziomaro a parlare
in tali termini e che cosa lo inducesse a rinunciare al piano intrapreso,
tuttavia, per non trovarsi costretto, con la spedizione per la Britannia
già pronta, a passare l'estate nelle terre dei Treveri, gli ordinò di
presentarsi con duecento ostaggi. Dopo che Induziomaro ebbe consegnato gli
ostaggi, tra cui suo figlio e tutti i suoi parenti, espressamente
richiesti, Cesare lo trattò con benevolenza, lo invitò a rispettare gli
impegni; comunque, convocati i capi dei Treveri, li riconciliò uno a uno
con Cingetorige, non solo in considerazione dei meriti da lui acquisiti,
ma anche perché riteneva molto importante favorire al massimo l'autorità
di Cingetorige tra i Treveri, data la straordinaria devozione del Gallo
nei suoi confronti. Fu un duro colpo per Induziomaro veder diminuito il
suo prestigio tra i Treveri: se già prima il suo animo ci era ostile,
adesso l'ira lo inasprì maggiormente.
[5
Sistemata la questione, Cesare con le legioni raggiunse Porto Izio. Qui
apprese che sessanta navi, costruite nelle terre dei Meldi, erano state
respinte da una tempesta e non avevano potuto tenere la rotta, per cui
erano rientrate alla base di partenza; trovò, però, le altre pronte a
salpare ed equipaggiate di tutto punto. Qui lo raggiunsero contingenti di
cavalleria da ogni parte della Gallia, per un complesso di circa
quattromila uomini, insieme ai principi dei vari popoli: ne lasciò in
Gallia ben pochi, quelli di provata lealtà; gli altri aveva deliberato di
portarseli dietro in qualità di ostaggi, perché temeva, in sua assenza,
una sollevazione della Gallia.
[6
Tra gli altri c'era l'eduo Dumnorige, di cui abbiamo già parlato. Fu uno
dei primi che Cesare decise di tenere con sé, conoscendone il desiderio di
rivolgimento, l'ambizione di comandare, la forza d'animo e il grande
prestigio tra i Galli. Inoltre, nell'assemblea degli Edui, Dumnorige aveva
detto che Cesare gli aveva offerto il regno: ciò non piaceva affatto agli
Edui, ma non osavano inviare messi a Cesare per opporsi o per invitarlo a
desistere. Della faccenda Cesare era stato informato dai suoi ospiti.
Dumnorige, in un primo tempo, ricorse a ogni sorta di preghiere per
riuscire a restare in Gallia: disse di aver paura del mare, inesperto
com'era di navigazione, addusse come scusa un impedimento d'ordine
religioso. Quando vide le sue richieste tenacemente respinte, persa ogni
speranza di raggiungere il suo scopo, cominciò a sobillare i principi
della Gallia e a terrorizzarli; li prendeva in disparte, li spingeva a non
lasciare il continente: non era un caso se la Gallia veniva privata di
tutti i nobili; si trattava di un piano di Cesare, che, non avendo il
coraggio di eliminarli sotto gli occhi dei Galli, li portava in Britannia
per ucciderli; come garanzia per loro, Dumnorige dava la propria parola,
ma ne esigeva la promessa, con giuramento solenne, di provvedere di comune
accordo a ciò che ritenevano l'interesse della Gallia. Le mosse di
Dumnorige vennero riferite a Cesare da più d'uno.
[7
Non appena lo seppe, Cesare, in quanto attribuiva molto prestigio al
popolo eduo, stimava necessario tenere a freno e dissuadere Dumnorige con
qualsiasi mezzo. E vedendo che la follia del Gallo non faceva che crescere
sempre di più, passò alle misure necessarie per evitare danni a sé e alla
repubblica. Così, nel periodo in cui fu costretto a rimanere a Porto Izio,
circa venticinque giorni, perché il vento coro, che in quella regione
soffia pressoché costante in ogni epoca dell'anno, impediva la
navigazione, Cesare si adoperava per tenere al suo posto Dumnorige e per
conoscerne, al tempo stesso, tutti i piani. Alla fine, sfruttando il tempo
propizio alla navigazione, ordina ai soldati e ai cavalieri di imbarcarsi.
Ma mentre tutti erano intenti a tale operazione, Dumnorige, alla testa dei
cavalieri edui, si allontana dal campo e si dirige in patria, all'insaputa
di Cesare. Appena informato, sospesa la partenza e rimandata ogni altra
faccenda, Cesare lancia all'inseguimento di Dumnorige il grosso della
cavalleria e comanda di ricondurlo all'accampamento; se si fosse ribellato
e non avesse eseguito gli ordini, dà disposizione di ucciderlo, non
attendendosi nulla di sensato, in propria assenza, da un uomo che aveva
dissubbidito al suo cospetto. All'intimazione di tornare indietro,
Dumnorige comincia a opporre resistenza, si difende con la forza,
scongiura i suoi di osservare i patti, proclamandosi più volte, a gran
voce, uomo libero di un popolo libero. I Romani, conforme agli ordini, lo
circondano e lo uccidono: tutti i cavalieri edui ritornano da Cesare.
[8
Dopo tali avvenimenti, Cesare lasciò Labieno sul continente con tre
legioni e duemila cavalieri, per difendere i porti, provvedere alle scorte
di grano, tenersi al corrente della situazione in Gallia e prendere
decisioni sulla base del momento e delle circostanze. Dal canto suo, salpò
alla testa di cinque legioni e di tanti cavalieri, quanti ne aveva
lasciati in terraferma; fece vela verso il tramonto, al soffio leggero
dell'africo, che però cessò verso mezzanotte, impedendogli di tenere la
rotta: spinto piuttosto lontano dalla marea, all'alba vide che aveva
lasciato la Britannia alla sua sinistra. Allora, sfruttando, adesso, la
marea, che aveva cambiato direzione, a forza di remi cercò di raggiungere
la zona dell'isola che - lo sapeva dall'estate precedente - consentiva un
comodissimo accesso. Nel corso della manovra, veramente lodevole fu
l'impegno dei soldati: pur con navi da trasporto appesantite dai carichi,
senza mai smettere di remare, riuscirono a uguagliare la velocità delle
navi da guerra. Approdò in Britannia con tutte le navi verso mezzogiorno,
senza alcun nemico in vista; come apprese in seguito dai prigionieri, i
Britanni, giunti sul luogo con truppe numerose, erano rimasti atterriti
alla vista della nostra flotta: erano apparse, contemporaneamente, più di
ottocento unità, comprese le navi dell'anno precedente e le imbarcazioni
private che alcuni avevano costruito per propria comodità. Quindi, i
nemici avevano abbandonato il litorale e si erano rifugiati sulle alture.
[9
Cesare provvide allo sbarco dell'esercito e alla scelta di un luogo adatto
per il campo. Non appena dai prigionieri seppe dove si erano attestate le
truppe nemiche, lasciò nella zona costiera dieci coorti e trecento
cavalieri a presidio delle navi e, dopo mezzanotte, mosse contro i nemici,
senza alcun timore per le imbarcazioni, lasciate all'ancora su un litorale
in lieve pendio e senza scogli; lasciò a capo del distaccamento e delle
navi Q. Atrio. Dopo aver percorso, di notte, circa dodici miglia, Cesare
avvistò i nemici, che dalle alture, con la cavalleria e i carri,
avanzarono verso il fiume: qui, stando in posizione più elevata,
impedirono ai nostri di procedere e attaccarono battaglia. Respinti dalla
cavalleria, cercarono rifugio nelle selve, sfruttando una zona
egregiamente difesa dalla conformazione naturale e da fortificazioni
allestite già in passato, probabilmente in occasione di guerre interne:
avevano abbattuto molti alberi, disponendoli in modo da precludere ogni
accesso. I Britanni, disseminati qua e là, combattevano dall'interno delle
selve e ostacolavano l'ingresso dei nostri nella loro roccaforte. Ma i
soldati della settima legione, dopo aver formato la testuggine ed essere
riusciti a costruire un terrapieno fino ai baluardi nemici, presero la
postazione dei Britanni e, subendo poche perdite, li costrinsero a
lasciare le selve. Ma Cesare ordinò di non proseguire l'inseguimento, sia
perché non conosceva la zona, sia perché era già giorno inoltrato e voleva
dedicare le ultime ore di luce a rinsaldare le difese del proprio campo.
[10
La mattina successiva, inviò all'inseguimento del nemico in fuga tre
colonne di legionari e cavalieri. I nostri avevano già percorso un certo
tratto ed erano ormai in vista dei primi fuggiaschi, quando alcuni
cavalieri inviati da Q. Atrio raggiunsero Cesare per riferirgli che la
notte precedente era scoppiata una violentissima tempesta: quasi tutte le
navi avevano subito danni ed erano state sbattute sul litorale; non
avevano retto né le ancore, né le gomene; nulla avevano potuto marinai e
timonieri contro la violenza della tempesta: le navi avevano cozzato le
une contro le altre, riportando gravi danni.
[11
Informato dell'accaduto, Cesare ordina alle legioni e alla cavalleria di
ritornare e di resistere durante il rientro; lui personalmente raggiunge
le navi. Constata, con i suoi occhi, che la situazione all'incirca
corrispondeva alle informazioni ricevute dalla lettera e dai messi:
risultavano perdute circa quaranta navi, ma le altre sembravano
riparabili, sia pur con grandi fatiche. Così, tra i legionari sceglie dei
carpentieri e ne fa arrivare altri dal continente. Scrive a Labieno di
costruire, con le legioni a sua disposizione, quante più navi possibile.
Sebbene l'operazione risultasse molto complicata e faticosa, decide che la
soluzione migliore consisteva nel tirare in secco tutte le navi e
congiungerle all'accampamento con una fortificazione unica. I lavori
richiedono circa dieci giorni, durante i quali i soldati non si concedono
mai una sosta, neppure di notte. Tirate in secco le imbarcazioni e ben
munito il campo, lascia a presidio delle navi le stesse truppe di prima e
ritorna da dove era venuto. Appena giunto, vede che già si erano lì
radunate, ben più numerose di prima, truppe nemiche provenienti da tutte
le regioni: il comando supremo delle operazioni era stato affidato, per
volontà comune, a Cassivellauno, sovrano di una regione separata dai
popoli che abitavano lungo il mare da un fiume chiamato Tamigi e distante
dal mare circa ottanta miglia. In passato, tra Cassivellauno e gli altri
popoli c'era stata continua guerra, ma adesso i Britanni, preoccupati per
il nostro arrivo, gli avevano conferito il comando supremo delle
operazioni.
[12
Nella parte interna della Britannia gli abitanti, secondo quanto essi
stessi dicono per remota memoria, sono autoctoni, mentre nelle regioni
costiere vivono genti venute dal Belgio a scopo di bottino e di guerra e
che, dopo la guerra, si erano qui insediate dandosi all'agricoltura: quasi
tutte queste genti conservano i nomi dei gruppi di origine. La popolazione
è numerosissima, molto fitte le case, abbastanza simili alle abitazioni
dei Galli, elevato il numero dei capi di bestiame. Come denaro usano rame
o monete d'oro, oppure, in sostituzione, sbarrette di ferro di un
determinato peso. Le regioni dell'interno sono ricche di stagno, sulla
costa si trova ferro, ma in piccola quantità; usano rame importato. Ci
sono alberi d'ogni genere, come in Gallia, tranne faggi e abeti. La loro
religione vieta di mangiare lepri, galline e oche, animali che essi,
comunque, allevano per proprio piacere. Il clima è più temperato che in
Gallia, il freddo meno intenso.
[13
L'isola ha forma triangolare, con un lato posto di fronte alla Gallia: un
angolo di questo lato, verso il Canzio, dove approdano quasi tutte le navi
provenienti dalla Gallia, è rivolto a oriente; l'altro, più basso, guarda
a meridione. Questo lato è lungo circa cinquecento miglia. Un altro lato è
volto verso la Spagna e occidente: su questo versante c'è l'Ibernia,
un'isola che si reputa circa la metà della Britannia e che da essa dista
tanto quanto la Britannia stessa dalla Gallia. A metà strada si trova
un'isola chiamata Mona; inoltre, si ritiene che ci siano molte altre isole
minori lungo la costa: alcuni hanno scritto che in esse, nel periodo del
solstizio d'inverno, la notte dura trenta giorni consecutivi. Noi non
siamo riusciti a raccogliere altre notizie in proposito, malgrado le
nostre domande; abbiamo solo constatato che qui le notti, misurate con
precisione mediante clessidre ad acqua, sono più brevi rispetto al
continente. La lunghezza di questo lato, secondo l'opinione degli autori
citati, è di settecento miglia. Il terzo lato è rivolto a settentrione:
nessuna terra gli sta di fronte, ma un suo lembo guarda essenzialmente
verso la Germania. Si ritiene che si estenda per ottocento miglia. Così,
il perimetro totale dell'isola risulta di duemila miglia.
[14
Tra tutti i popoli della Britannia, i più civili in assoluto sono gli
abitanti del Canzio, una regione completamente marittima non molto
dissimile per usi e costumi dalla Gallia. Gli abitanti dell'interno, per
la maggior parte, non seminano grano, ma si nutrono di latte e carne e si
vestono di pelli. Tutti i Britanni, poi, si tingono col guado, che produce
un colore turchino, e perciò in battaglia il loro aspetto è ancor più
terrificante; portano i capelli lunghi e si radono in ogni parte del
corpo, a eccezione della testa e del labbro superiore. Hanno le donne in
comune, vivendo in gruppi di dieci o dodici, soprattutto fratelli con
fratelli e genitori con figli; se nascono dei bambini, sono considerati
figli dell'uomo che per primo si è unito alla donna.
[15
I cavalieri e gli essedari nemici si scontrarono duramente con la nostra
cavalleria in marcia, che però ebbe il sopravvento in ogni settore e li
respinse nelle selve e sui colli. I nostri, però, dopo averne uccisi
molti, li inseguirono con eccessiva foga e riportarono alcune perdite. I
Britanni per un po' attesero, poi, all'improvviso, dalle selve si
precipitarono sui nostri, che non se l'aspettavano ed erano intenti ai
lavori di fortificazione: assalite le guardie di fronte all'accampamento,
si batterono accanitamente. Cesare inviò in aiuto due coorti - le prime di
due legioni - che si schierarono a brevissima distanza l'una dall'altra.
Ma mentre i nostri erano atterriti dalla nuova tattica di combattimento
degli avversari, i Britanni, con estrema audacia, sfondarono il fronte tra
le due coorti e, quindi, ripararono in salvo. Quel giorno perde la vita Q.
Laberio Duro, tribuno militare. I nemici vengono respinti grazie all'invio
di altre coorti a rinforzo.
[16
Nel suo insieme, il tipo di battaglia, svoltasi sotto gli occhi di tutti,
davanti all'accampamento, ci permise di capire che i nostri non erano
preparati ad affrontare un avversario del genere: appesantiti
dall'armamento, i Romani non erano in grado di inseguire i nemici in fuga,
né osavano allontanarsi dalle insegne. I cavalieri, poi, correvano grossi
rischi nella mischia, perché gli avversari per lo più cedevano, anche di
proposito: quando erano riusciti a portare i nostri cavalieri abbastanza
lontano dalle legioni, scendevano dai carri e, a piedi, combattevano in
posizione di vantaggio. Così, la natura degli scontri di cavalleria era
identica per chi inseguiva e per chi si ritirava, presentando pari
pericolo per entrambi. Inoltre, i nemici non lottavano mai in formazione
serrata, ma a piccoli gruppi molto distanziati, disponendo postazioni di
riserva: a turno gli uni subentravano agli altri, soldati freschi e
riposati davano il cambio a chi era stanco.
[17
L'indomani i nemici si attestarono sui colli, lontano dall'accampamento.
Cominciarono ad avanzare in ordine sparso e a sfidare la nostra cavalleria
con minor foga del giorno precedente. Ma nel pomeriggio, dopo che Cesare
aveva inviato in cerca di foraggio tre legioni e tutta la cavalleria agli
ordini del legato C. Trebonio, all'improvviso i nemici piombarono su di
essi da ogni direzione, stringendosi attorno alle insegne e alle legioni.
I nostri, con un veemente assalto, li respinsero e li incalzarono: i
cavalieri, contando sull'appoggio delle legioni, che vedevano alle spalle,
costrinsero i nemici a una fuga precipitosa, ne fecero strage e non
diedero loro la possibilità né di raccogliersi, né di attestarsi o di
scendere dai carri. Questa fuga provocò subito la dispersione delle truppe
ausiliarie dei Britanni, che erano giunte da ogni regione: in seguito, il
nemico non ci avrebbe più affrontato con l'esercito al completo.
[18
Cesare, informato delle intenzioni dei Britanni, condusse l'esercito nelle
terre di Cassivellauno, verso il Tamigi, fiume che può essere guadato a
piedi solo in un punto, e a stento. Appena giunto, si rese conto che
sull'altra sponda erano schierate ingenti forze nemiche. La riva, poi, era
difesa da pali aguzzi piantati nel terreno, così come altri simili,
sott'acqua, erano celati dal fiume. Messo al corrente di ciò dai
prigionieri e dai fuggiaschi, Cesare mandò in avanti la cavalleria e
ordinò alle legioni di seguirla senza indugio. I nostri, pur riuscendo a
tenere fuori dall'acqua solo la testa, avanzarono con una rapidità e un
impeto tale, che gli avversari, non essendo in grado di reggere
all'assalto delle legioni e della cavalleria, abbandonarono la riva e
fuggirono.
[19
Cassivellauno - lo abbiamo detto in precedenza - persa ogni speranza di
proseguire nello scontro aperto, aveva congedato il grosso dell'esercito e
con solo circa quattromila essedari sorvegliava i nostri movimenti: si
teneva a poca distanza dalle strade, nascosto in luoghi di difficile
accesso e fitti di boschi; nelle zone per cui sapeva che dovevamo
transitare cacciava via bestiame e popolazione dalle campagne nelle
foreste. Quando la nostra cavalleria si spingeva troppo in là nei campi,
per saccheggiare e devastare, lungo tutte le strade e i sentieri, dai
boschi Cassivellauno lanciava all'attacco i carri e combatteva con i
nostri con tale rischio per loro, da costringerli, per il timore di
scontri, a non spingersi troppo distante. A Cesare non restava che
impedire alla cavalleria di allontanarsi troppo dal grosso delle legioni
in marcia, e accontentarsi di danneggiare i nemici devastandone le
campagne e appiccando incendi, per quanto lo potevano i legionari,
impegnati in marce faticose.
[20
Nel frattempo giunge a Cesare un'ambasceria da parte dei Trinovanti, il
più potente, o quasi, tra i popoli di quelle regioni. In passato, uno di
essi, il giovane Mandubracio, si era posto sotto la protezione di Cesare e
lo aveva raggiunto sul continente: suo padre era diventato re ed era stato
ucciso da Cassivellauno, mentre lui si era salvato con la fuga. Gli
ambasciatori dei Trinovanti, promettendo resa e obbedienza, chiedono a
Cesare di tutelare Mandubracio dai soprusi di Cassivellauno e di inviarlo
al suo popolo per diventarne il capo e assumere il potere. Cesare esige da
loro quaranta ostaggi e grano per l'esercito e invia Mandubracio. I
Trinovanti eseguirono rapidamente gli ordini e mandarono gli ostaggi,
secondo il numero fissato, e il grano.
[21
Vedendo i Trinovanti protetti e al sicuro da ogni attacco militare, i
Cenimagni, i Segontiaci, gli Ancaliti, i Bibroci e i Cassi mandarono a
Cesare ambascerie per arrendersi. Da essi seppe che, non lontano, sorgeva
la roccaforte di Cassivellauno difesa da selve e paludi, dove erano stati
concentrati uomini e bestiame in numero ragguardevole. I Britanni, in
effetti, chiamano roccaforte una selva impraticabile munita da vallo e
fossa, dove di solito si raccolgono per sottrarsi alle incursioni dei
nemici. Lì Cesare si diresse con le legioni: si imbatté in un luogo
estremamente ben protetto sia dalla conformazione naturale, sia dall'opera
dell'uomo. Nonostante ciò, intraprese l'assedio su due fronti. I nemici
opposero una breve resistenza, ma non riuscirono a frenare l'assalto dei
nostri e cercarono di mettersi in salvo da un'altra parte della
roccaforte. Qui venne trovato un gran numero di capi di bestiame e molti
dei fuggiaschi furono catturati e uccisi.
[22
Nel corso di tali avvenimenti, Cassivellauno invia dei messi nel Canzio,
regione che si affaccia sul mare - lo si è già ricordato - e che era
governata da quattro re: Cingetorige, Carvilio, Taximagulo e Segovace. A
essi ordina di raccogliere tutte le loro truppe e di sferrare un
improvviso attacco all'accampamento navale romano, ponendolo sotto
assedio. Appena i nemici giunsero al campo, i nostri effettuarono una
sortita e ne fecero strage: catturato anche il loro capo, Lugotorige, di
nobile stirpe, rientrarono sani e salvi. Quando gli fu annunciato l'esito
della battaglia, Cassivellauno, visti i tanti rovesci, i territori
devastati e scosso, soprattutto, dalle defezioni, invia, tramite
l'atrebate Commio, una legazione a Cesare per trattare la resa. Cesare
aveva deciso di svernare sul continente per prevenire repentine
sollevazioni in Gallia e si rendeva conto che, volgendo ormai l'estate al
termine, i nemici potevano con facilità temporeggiare. Perciò, chiede
ostaggi e fissa il tributo che la Britannia avrebbe dovuto pagare
annualmente al popolo romano. A Cassivellauno proibisce formalmente di
arrecar danno a Mandubracio o ai Trinovanti.
[23
Consegnati gli ostaggi, riconduce l'esercito sulla costa, dove trova le
navi riparate. Dopo averle calate in acqua, decise di trasportare
l'esercito in due viaggi, poiché aveva molti prigionieri e alcune navi
erano state distrutte dalla tempesta. Ma ecco che cosa capitò: di tante
navi, in tante traversate, non ne era andata perduta neppure una che
trasportasse soldati, né quell'anno, né l'anno precedente; delle
imbarcazioni, invece, che gli venivano rinviate vuote dal continente (che
si trattasse delle navi di ritorno dal primo viaggio dopo aver sbarcato le
truppe, oppure delle sessanta costruite in un secondo tempo da Labieno),
pochissime erano giunte a destinazione, quasi tutte le altre erano state
ributtate sulla costa. Cesare le attese per un po' inutilmente; poi, per
evitare che la stagione - l'equinozio era vicino - impedisse la
navigazione, fu costretto a stipare i soldati un po' più allo stretto del
solito. Levate le ancore subito dopo le nove di sera, trovò il mare molto
calmo e all'alba prese terra: aveva portato in salvo tutte le navi.
[24
Dopo aver tratto in secca le navi e tenuto l'assemblea dei Galli a
Samarobriva, vista la magra annata per il grano a causa della siccità, fu
costretto a disporre i quartieri d'inverno in modo diverso rispetto agli
anni precedenti e a ripartire le legioni su più territori. Ne inviò una
presso i Morini sotto la guida del legato C. Fabio, un'altra con Q.
Cicerone dai Nervi, una terza con L. Roscio nella regione degli Esuvi;
ordinò che una quarta legione, al comando di T. Labieno, svernasse nei
territori dei Remi, al confine con i Treveri; ne stanziò tre nel paese dei
Belgi, alle dipendenze del questore M. Crasso e dei legati L. Munazio
Planco e C. Trebonio. Una legione, di recente arruolata al di là del Po,
venne mandata, insieme a cinque coorti, fra gli Eburoni, che per la
maggior parte abitano tra la Mosa e il Reno e sui quali regnavano
Ambiorige e Catuvolco. Il comando ne fu affidato ai legati Q. Titurio
Sabino e L. Aurunculeio Cotta. Ripartite così le truppe, stimava di poter
ovviare, con grande facilità, alla penuria di grano. Gli accampamenti
invernali di tutte le legioni non distavano, comunque, più di cento miglia
l'uno dall'altro, eccezion fatta per le milizie di L. Roscio, che però
doveva condurle in una zona del tutto tranquilla e sicura. Dal canto suo,
Cesare decise di fermarsi in Gallia fino a conferma ricevuta che le
legioni erano stanziate nelle rispettive zone e che gli accampamenti erano
stati fortificati.
[25
Tra i Carnuti viveva una persona di nobili natali, Tasgezio, i cui
antenati avevano regnato sul paese: Cesare gli aveva restituito il rango
degli avi, in considerazione del suo valore e della sua fedeltà, dato che
in tutte le guerre Cesare si era avvalso del suo contributo incomparabile.
Tasgezio era già al suo terzo anno di regno, quando i suoi oppositori lo
eliminarono con una congiura, mentre anche molti cittadini avevano
appoggiato apertamente il piano. La cosa viene riferita a Cesare, che,
temendo una defezione dei Carnuti sotto la spinta degli oppositori -
parecchi erano implicati nella vicenda - ordina a L. Planco di partire al
più presto dal Belgio alla testa della sua legione, di raggiungere il
territorio dei Carnuti e di passarvi l'inverno: chiunque gli risultasse
implicato nell'uccisione di Tasgezio, doveva essere arrestato e inviato a
Cesare. Nello stesso tempo, tutti gli ufficiali preposti alle legioni
informano Cesare che erano giunti ai quartieri d'inverno e che le
fortificazioni erano ormai ultimate.
[26
Circa quindici giorni dopo l'arrivo agli accampamenti invernali,
improvvisamente scoppiò un'insurrezione guidata da Ambiorige e Catuvolco.
Costoro si erano presentati al confine dei loro territori, a disposizione
di Sabino e di Cotta e avevano consegnato grano all'accampamento; in
seguito, però, spinti dai messi del trevero Induziomaro, avevano chiamato
i loro a raccolta e, sopraffatti i nostri legionari in cerca di legna, con
ingenti forze avevano stretto d'assedio il campo. Mentre i nostri
impugnavano rapidamente le armi e salivano sul vallo, i cavalieri
spagnoli, usciti da una porta del campo, sferravano un attacco in cui
ebbero la meglio: gli avversari, persa ogni speranza di vittoria, furono
costretti a togliere l'assedio. Poi, a gran voce, come è loro costume,
chiesero che qualcuno dei nostri si facesse avanti per parlamentare:
avevano da riferire informazioni d'interesse comune, grazie alle quali
speravano di poter risolvere i contrasti.
[27
Al colloquio viene inviato C. Arpineio, cavaliere romano, parente di Q.
Titurio, insieme a uno Spagnolo, un certo Q. Giunio, che in passato, per
incarico di Cesare, si era già più volte recato da Ambiorige. A essi
Ambiorige parlò come segue: ammetteva i molti debiti di riconoscenza nei
confronti di Cesare (grazie al suo intervento era stato sollevato dal
tributo che pagava abitualmente agli Atuatuci, popolo limitrofo; Cesare
gli aveva restituito suo figlio e il figlio di suo fratello, che, inclusi
nel novero degli ostaggi, erano tenuti asserviti in catene dagli
Atuatuci); quanto all'assedio al campo romano, aveva agito non di
iniziativa o volontà propria, ma costretto dal popolo, e la sua sovranità
stava in questi termini: la sua gente aveva nei suoi confronti gli stessi
diritti che aveva lui nei confronti della sua gente. Il popolo, d'altro,
canto, era insorto perché non aveva potuto opporsi alla repentina
formazione di una lega dei Galli. E prova evidente di ciò era la sua
debolezza: non era tanto sprovveduto da confidare, con le proprie truppe,
in una vittoria sul popolo romano. Si trattava, piuttosto, di un piano
comune a tutti i Galli: era stato deciso di assediare, in quel giorno,
tutti i campi invernali di Cesare, in modo che nessuna legione fosse in
grado di soccorrerne un'altra. Come potevano dei Galli, con facilità,
opporre un rifiuto alla proposta di altri Galli, soprattutto quando
sembrava mirare alla riconquista della libertà comune? Se, dunque, prima
aveva aderito alla lega dei Galli per amor di patria, adesso teneva conto
del suo dovere per i benefici ricevuti da Cesare: avvertiva, supplicava
Titurio, in nome dei loro vincoli d'ospitalità, di provvedere a porsi in
salvo con i propri soldati. Un forte esercito di mercenari germani aveva
attraversato il Reno: sarebbero giunti nell'arco di due giorni. Spettava
ai Romani la decisione di far uscire dall'accampamento i soldati prima che
i Galli vicini se ne accorgessero, e condurli da Cicerone o da Labieno,
distanti l'uno circa cinquanta miglia, l'altro poco più. Prometteva e
giurava dar via libera sul proprio territorio. Agendo così, avrebbe
provveduto al bene della propria gente, perché veniva liberata dal campo
romano, e ricambiato i servigi di Cesare. Ciò detto, Ambiorige si
allontana.
[28
Arpineio e Giunio riferiscono le parole di Ambiorige ai legati, che,
turbati dagli eventi repentini, stimavano di dover dar peso alle
informazioni, per quanto fornite dal nemico. Li spingeva, soprattutto, una
considerazione: era ben poco credibile che un popolo così oscuro e debole
come gli Eburoni avesse osato, di propria iniziativa, muovere guerra a
Roma. Perciò, rimandano la questione al consiglio di guerra, dove si
verificano forti contrasti. L. Aurunculeio, seguito da molti tribuni
militari e dai centurioni più alti in grado, era dell'avviso di non
prendere iniziative avventate e di non lasciare i quartieri d'inverno
senza ordine di Cesare; spiegavano che, essendo il campo fortificato, era
possibile tener testa alle truppe dei Germani, per quanto numerose; lo
testimoniava il fatto che avevano retto con grandissimo vigore al primo
assalto e avevano inflitto al nemico gravi perdite; la situazione delle
scorte di grano non era preoccupante; nel frattempo, sia dai campi più
vicini, sia da Cesare sarebbero arrivati rinforzi; infine, cosa c'era di
più avventato o vergognoso che deliberare su questioni gravissime, per
suggerimento dei nemici?
[29
A ciò Titurio obiettava, gridando, che si sarebbero mossi tardi, con le
forze avversarie ormai più consistenti per l'arrivo dei Germani oppure
dopo qualche disastro negli accampamenti vicini. Avevano poco tempo per
decidere. Riteneva che Cesare fosse partito per l'Italia, altrimenti i
Carnuti non avrebbero preso la decisione di eliminare Tasgezio, né gli
Eburoni, se lui era presente in Gallia, avrebbero marciato sul campo con
tanto disprezzo per le nostre forze. Le proposte del nemico non
c'entravano, si trattava di valutare la situazione: il Reno era vicino; la
morte di Ariovisto e le nostre precedenti vittorie avevano costituito un
gran dolore per i Germani; la Gallia bruciava per le molte umiliazioni
subite, per dover sottostare al dominio del popolo romano, per l'antica
gloria militare oscurata. Infine, ma chi poteva convincersi che Ambiorige
avesse assunto una decisione del genere senza uno scopo ben preciso? La
sua proposta era sicura in entrambi i casi: se non si verificava nulla di
grave, avrebbero raggiunto la legione più vicina, senza rischi; se,
invece, la Gallia era tutta d'accordo con i Germani, l'unica speranza di
salvezza era riposta nella rapidità. Il parere di Cotta e di chi
dissentiva, a cosa portava? Se per il presente non rappresentava un
pericolo, certo avrebbero dovuto temere la fame, in un lungo assedio.
[30
Mentre così si discuteva, da una parte e dall'altra, visto che Cotta e i
centurioni più alti in grado si opponevano con tenacia, Sabino disse: "E
va bene, se proprio lo volete", e a voce più alta, per essere sentito da
un gran numero di soldati, proseguì: "Non sarò certo io quello che, in
mezzo voi, si lascia spaventare di più dalla paura della morte; ma saranno
loro a giudicare e a chiedere conto a te, se succede qualcosa di grave,
loro, che se tu lo consentissi, potrebbero raggiungere dopodomani
l'accampamento più vicino e affrontare le vicende della guerra insieme
agli altri, invece di crepare per mano nemica o sfiniti dalla fame,
abbandonati e lontani da tutti".
[31
Si alzano dal consiglio, prendono nel mezzo entrambi i legati e li pregano
di non portare la situazione al massimo rischio con il loro dissenso
ostinato; la faccenda era facile sia rimanendo, sia levando le tende,
purché tutti fossero dello stesso avviso e partito; in caso di disaccordo,
invece, non intravedevano alcuna speranza di salvezza. La discussione
prosegue fino a notte fonda. Alla fine Cotta, turbato, si dà per vinto:
prevale il parere di Sabino. La partenza viene annunciata per l'alba. Il
resto della notte la passano a vegliare, ogni soldato valuta che cosa
possa prendere con sé e quali oggetti dell'accampamento invernale debba
abbandonare per forza. Le pensano tutte pur di non garantire, la mattina
dopo, una partenza priva di rischi, e di aumentare il pericolo con la
stanchezza dei soldati, dovuta alla veglia. All'alba lasciano il campo,
non come se fossero stati persuasi dal nemico, ma quasi che avessero
accolto il suggerimento di un amico di provata lealtà, Ambiorige.
L'esercito in marcia formava una schiera interminabile, con numerosissimi
bagagli.
[32
I nemici, quando dall'agitazione notturna e dalla veglia prolungata, si
resero conto che i nostri preparavano la partenza, tesero insidie da due
lati, nella boscaglia, su un terreno favorevole e coperto, a circa due
miglia dal campo, in attesa dell'arrivo dei Romani. Allorché il grosso del
nostro esercito era ormai entrato in un'ampia valle, all'improvviso, dai
fianchi della medesima sbucarono i nemici e iniziarono a premere sulla
retroguardia, a impedire all'avanguardia di salire, costringendo i nostri
a combattere in condizioni assolutamente sfavorevoli.
[33
Solo allora Titurio, che nulla aveva previsto, cominciò ad agitarsi, a
correre qua e là, a disporre le coorti, ma sempre impaurito: sembrava che
tutto gli venisse a mancare, come per lo più accade a chi è costretto a
decidere proprio mentre l'azione è in corso. Cotta, invece, che aveva
pensato all'eventualità di un attacco durante la marcia e che, perciò, non
era stato fautore della partenza, non risparmiò nulla per la salvezza di
tutti e, chiamando e incoraggiando i legionari, durante la battaglia,
svolgeva le funzioni di comandante e di soldato. La lunghezza della
colonna rendeva più difficile provvedere a tutto personalmente e impartire
gli ordini necessari in ogni settore della battaglia, perciò i comandanti
diedero disposizione, passando la voce, di abbandonare i bagagli e di
assumere la formazione a cerchio. La manovra, anche se in circostanze del
genere non è riprovevole, si risolse in un danno: diminuì la fiducia dei
nostri soldati e rese più arditi i nemici, perché sembrava che fosse stata
fatta per estremo timore e scoraggiamento. Inoltre, accadde l'inevitabile:
i soldati, ovunque, si allontanavano dalle insegne, ciascuno correva ai
bagagli per cercare e riprendersi le cose più care, tutto risuonava di
grida e pianti.
[34
I barbari, invece, si dimostrarono avveduti. Infatti, i loro capi
passarono ordine a tutto lo schieramento che nessuno si allontanasse dal
proprio posto: era preda riservata per loro tutto ciò che i Romani
avessero abbandonato, quindi dovevano pensare che tutto dipendeva dalla
vittoria. Il loro coraggio era pari al loro numero. I nostri, benché
abbandonati dal comandandante e dalla Fortuna, tuttavia riponevano ogni
speranza di salvezza nel proprio valore, e ogni volta che una coorte
muoveva all'assalto, in quel settore cadeva un gran numero di nemici.
Appena se ne accorge, Ambiorige passa voce di scagliare dardi da lontano,
senza avvicinarsi, cedendo là dove i Romani avessero sferrato l'attacco:
grazie alle loro armi leggere e all'esercizio quotidiano avrebbero potuto
infliggere ai Romani gravi perdite; quando i nostri si fossero ritirati
verso le insegne, dovevano inseguirli.
[35
L'ordine venne scrupolosamente eseguito dai barbari: quando una coorte
usciva dalla formazione a cerchio e attaccava, i nemici indietreggiavano
in gran fretta. Al tempo stesso era inevitabile che quel punto rimanesse
scoperto e che sul fianco destro piovessero dardi. Poi, quando i nostri
iniziavano il ripiegamento verso il settore di partenza, venivano
circondati sia dai nemici che si erano ritirati, sia dagli altri che erano
rimasti fermi nelle vicinanze. Se, invece, volevano tenere le posizioni,
non avevano modo di esprimere il proprio valore, né di evitare, così
serrati, le frecce scagliate da una tal massa di nemici. Comunque, pur
travagliati da tante difficoltà e nonostante le gravi perdite, resistevano
e, trascorsa già gran parte del giorno - si combatteva dall'alba ed erano
ormai le due di pomeriggio - non si piegavano a nulla che fosse indegno di
loro. A quel punto T. Balvenzio, che l'anno precedente era stato
centurione primipilo, soldato coraggioso e di grande autorità, viene
colpito da una tragula, che gli trapassa tutte e due le cosce; Q. Lucanio,
anch'egli primipilo, mentre combatteva con estremo valore, perde la vita
nel tentativo di recare aiuto al figlio circondato; il legato L. Cotta,
mentre stava incitando tutte le coorti e le centurie, viene colpito da un
proiettile di fionda in pieno volto.
[36
Scosso da tali avvenimenti, Q. Titurio, avendo scorto in lontananza
Ambiorige che spronava i suoi, gli invia il proprio interprete, Cn.
Pompeo, per chiedergli salva la vita per sé e i legionari. Ambiorige alla
richiesta risponde: se Titurio voleva un colloquio, glielo concedeva;
sperava di poter convincere le truppe circa la salvezza dei soldati
romani; Titurio stesso, comunque, non avrebbe corso alcun rischio, se ne
rendeva garante di persona. Titurio si consiglia con Cotta, ferito: gli
propone, se era d'accordo, di allontanarsi dalla battaglia e di recarsi
insieme a parlare con Ambiorige: sperava di riuscire a ottenere salva la
vita per loro e per i soldati. Cotta risponde che non si sarebbe mai
recato da un nemico in armi e non recede dalla sua decisione.
[37
Ai tribuni militari che, al momento, aveva intorno a sé e ai centurioni
più alti in grado, Sabino dà ordine di seguirlo. Essendosi avvicinato ad
Ambiorige, gli viene ingiunto di gettare le armi: esegue l'ordine e
comanda ai suoi di fare altrettanto. E mentre trattavano delle condizioni
di resa e Ambiorige, di proposito, tirava in lungo il suo discorso, a poco
a poco Sabino viene circondato e ucciso. A quel punto, com'è loro costume,
i nemici levano alte grida di vittoria, si lanciano all'assalto,
scompaginano i ranghi dei nostri. L. Cotta cade combattendo sul posto,
come la maggior parte dei nostri. Gli altri si rifugiano nell'accampamento
da cui erano partiti. Tra di essi, L. Petrosidio, aquilifero, attaccato da
molti avversari, gettò l'aquila all'interno del vallo e cadde battendosi
da vero eroe dinanzi all'accampamento. I nostri, a malapena, riescono a
reggere agli attacchi nemici fino al calar delle tenebre; di notte, senza
più speranze di salvezza, si tolgono la vita tutti, sino all'ultimo. I
pochi superstiti raggiungono, per vie malsicure tra le selve, il campo del
legato T. Labieno e lo informano dell'accaduto.
[38
Imbaldanzito dalla vittoria, Ambiorige con la cavalleria si dirige verso
gli Atuatuci, che confinavano col suo regno. Non interrompe la marcia né
di notte, né di giorno e ordina alla fanteria di tenergli dietro.
Illustrato l'accaduto e spinti gli Atuatuci alla ribellione, il giorno
seguente raggiunge i Nervi e li spinge a non perdere l'occasione di
rendersi per sempre liberi e di vendicarsi dei Romani per le offese
ricevute. Racconta che due legati erano stati uccisi e il grosso
dell'esercito eliminato; non era affatto difficile cogliere di sorpresa la
legione che svernava con Cicerone e distruggerla; promette il suo aiuto
nell'impresa. Con tali parole persuade facilmente i Nervi.
[39
Così, inviano subito emissari ai Ceutroni, ai Grudi, ai Levaci, ai
Pleumoxi, ai Geidumni, tutti popoli sottoposti alla loro autorità,
raccolgono quante più truppe possono e piombano all'improvviso sul campo
di Cicerone, che ancora non sapeva della morte di Titurio. Anche Cicerone
si trova di fronte, com'era inevitabile, all'identica situazione: alcuni
legionari, addentratisi nei boschi in cerca di legname per le
fortificazioni, vengono colti alla sprovvista dall'arrivo repentino della
cavalleria nemica. Dopo averli circondati con ingenti forze, gli Eburoni,
i Nervi e gli Atuatuci, con tutti i loro alleati e clienti, stringono
d'assedio la legione. I nostri si precipitano alle armi e salgono sul
vallo. Per quel giorno riescono a resistere, ma a stento, perché i nemici
riponevano ogni speranza nella rapidità dell'attacco ed erano convinti
che, ottenuta quella vittoria, sarebbero sempre usciti vincitori.
[40
Senza indugio Cicerone invia una lettera a Cesare, promettendo grandi
ricompense a chi fosse riuscito a recapitarla. Le vie, però, erano tutte
sorvegliate e i messi vennero intercettati. Di notte, con il legname
procurato per le fortificazioni, i Romani costruiscono, con incredibile
rapidità, almeno centoventi torri e terminano le strutture difensive non
ancora approntate. L'indomani i nemici, raccolte truppe ben più numerose,
riprendono l'assedio e riempiono la fossa. I nostri resistono nello stesso
modo del giorno prima. L'identica situazione si ripete nei giorni
successivi. Di notte i lavori non vengono sospesi, neppure per un istante;
non è concesso riposo né ai malati, né ai feriti. Tutto il necessario per
l'assedio del giorno seguente lo si prepara di notte; sono approntati
molti pali induriti al fuoco e giavellotti pesanti in gran quantità; le
torri vengono munite di tavolati, dotate di merli e parapetti di graticci.
Cicerone stesso, pur essendo di salute molto cagionevole, neanche di notte
si concedeva riposo, tanto che i soldati si accalcarono intorno a lui e lo
costrinsero, a forza di insistere, a prendersi un po' di respiro.
[41
Allora i capi e i principi dei Nervi, che avevano possibilità di contatto
con Cicerone per ragioni di amicizia, gli chiedono un colloquio ed egli lo
concede. Descrivono la situazione negli stessi termini in cui Ambiorige
l'aveva presentata a Titurio: tutta la Gallia era in armi; i Germani
avevano attraversato il Reno; il campo di Cesare e tutti gli altri erano
sotto assedio. Riferiscono anche la morte di Sabino: la presenza di
Ambiorige ne costituiva la prova. Sarebbe stato un errore aspettare
rinforzi da chi disperava della propria situazione; tuttavia, contro
Cicerone e il popolo romano non avevano alcun risentimento, solo non
accettavano più quartieri d'inverno nei loro territori e non intendevano
che tale abitudine si radicasse; concedevano ai Romani la possibilità di
lasciare il campo sani e salvi e di recarsi, senza alcun timore, dovunque
volessero. A tali parole Cicerone risponde semplicemente che non era
consuetudine del popolo romano accettare condizioni da un nemico armato;
se avessero acconsentito a deporre le armi, prometteva il suo appoggio per
l'invio di messi a Cesare: sperava, dato il senso di giustizia del
comandante, che avrebbero viste esaudite le loro richieste.
[42
Svanita tale speranza, i Nervi cingono il campo romano con un vallo alto
dieci piedi e una fossa larga quindici. Negli anni precedenti, per i
frequenti contatti con noi, avevano appreso tale tecnica e adesso erano
istruiti da alcuni prigionieri del nostro esercito; ma, privi degli
attrezzi di ferro adatti, erano costretti a fendere le zolle con le spade
e a trasportare la terra con le mani o i saguli. Ma anche da ciò,
comunque, si poté capire quanto fossero numerosi: in meno di tre ore
ultimarono una linea fortificata per un perimetro di quindici miglia. Nei
giorni successivi, sempre sulla base delle istruzioni dei prigionieri,
cominciarono a preparare e costruire torri alte come il vallo, falci e
testuggini.
[43
Il settimo giorno d'assedio si levò un vento fortissimo: i nemici
iniziarono a scagliare proiettili roventi d'argilla incandescente e frecce
infuocate contro le capanne che, secondo l'uso gallico, avevano il tetto
ricoperto di paglia. I tetti presero subito fuoco e, per la violenza delle
raffiche, le fiamme si diffusero in ogni punto del campo. I nemici, tra
alte grida, come se avessero già la vittoria in pugno, cominciarono a
spingere in avanti le torri e le testuggini, a tentar di salire sul nostro
vallo con scale. I nostri, nonostante il calore sprigionato ovunque dalle
fiamme e il nugolo di dardi che pioveva su di loro e sebbene si rendessero
conto che tutti i bagagli e ogni loro bene era perduto, diedero una tal
prova di valore e presenza di spirito, che nessuno si mosse e abbandonò il
vallo in fuga, anzi, non girarono neanche le teste: tutti si batterono con
estrema tenacia e straordinario coraggio. Per i nostri fu il giorno più
duro in assoluto, ma col risultato che, proprio in esso, i nemici subirono
il maggior numero di perdite, tra morti e feriti, perché si erano
ammassati proprio ai piedi del vallo e gli ultimi impedivano ai primi la
ritirata. Le fiamme erano un po' calate e, in una zona, una torre nemica
era stata spinta contro il vallo; i centurioni della terza coorte
ripiegarono dal settore in cui si trovavano e ordinarono a tutti i loro di
retrocedere, poi con cenni e grida cominciarono a chiamare il nemico,
sfidandolo a entrare: nessuno osò farsi avanti. Allora i nostri, da ogni
parte, scagliarono pietre e i Galli vennero dispersi; la torre fu
incendiata.
[44
In quella legione militavano due centurioni di grande valore, T. Pullone e
L. Voreno, che stavano raggiungendo i gradi più alti. I due erano in
costante antagonismo su chi doveva esser anteposto all'altro e ogni anno
gareggiavano per la promozione, con rivalità accanita. Mentre si
combatteva aspramente nei pressi delle nostre difese, Pullone disse:
"Esiti, Voreno? Che grado ti aspetti a ricompensa del tuo valore? Ecco il
giorno che deciderà le nostre controversie!" Ciò detto, scavalca le difese
e si getta contro lo schieramento nemico dove sembrava più fitto. Neppure
Voreno, allora, resta entro il vallo, ma, temendo il giudizio di tutti,
segue Pullone. A poca distanza dai nemici, questi scaglia il giavellotto
contro di loro e ne colpisce uno, che correva in testa a tutti; i compagni
lo soccorrono, caduto e morente, proteggendolo con gli scudi, mentre tutti
insieme lanciano dardi contro Pullone, impedendogli di avanzare. Anzi, il
suo scudo viene passato da parte a parte e un veruto gli si pianta nel
balteo, spostandogli il fodero della spada: così, mentre cerca di
sguainarla con la destra, perde tempo e, nell'intralcio in cui si trova,
viene circondato. Subito il suo rivale Voreno si precipita e lo soccorre
in quel difficile frangente. Su di lui convergono subito tutti i nemici,
trascurando Pullone: lo credono trafitto dal veruto. Voreno combatte con
la spada, corpo a corpo, uccide un avversario e costringe gli altri a
retrocedere leggermente, ma, trasportato dalla foga, cade a capofitto in
un fosso. Viene circondato a sua volta e trova sostegno in Pullone: tutti
e due, incolumi, si riparano entro le nostre difese, dopo aver ucciso
molti nemici ed essersi procurati grande onore. Così la Fortuna, in questa
loro sfida e contesa, dispose di essi in modo che ognuno recasse
all'antagonista aiuto e salvezza e che non fosse possibile giudicare a
quale dei due, per valore, toccasse il premio per il valore.
[45
Quanto più l'assedio diventava, di giorno in giorno, duro e insostenibile
(soprattutto perché la maggior parte dei soldati era ferita e il numero
dei difensori si era ridotto a ben poca cosa), tanto più di frequente
venivano inviate lettere e messi a Cesare: alcuni di loro, catturati,
vennero uccisi tra i supplizi al cospetto dei nostri soldati.
Nell'accampamento c'era un Nervio, di nome Verticone, persona di nobili
natali: fin dall'inizio dell'assedio era passato dalla parte di Cicerone e
gli aveva giurato fedeltà assoluta. Verticone persuade un suo servo a
portare una lettera a Cesare e gli promette la libertà e grosse
ricompense. Costui porta fuori dal campo la lettera legata al suo
giavellotto: Gallo, tra Galli, si muove senza destare alcun sospetto e
raggiunge Cesare, informandolo dei pericoli che incombono su Cicerone e la
sua legione.
[46
Cesare, ricevuta la lettera verso le cinque di pomeriggio, invia
immediatamente nelle terre dei Bellovaci un messaggero al questore M.
Crasso, il cui campo invernale distava circa venticinque miglia; gli
ordina di mettersi in marcia con la legione a mezzanotte e di raggiungerlo
in fretta. Crasso lascia il campo con l'emissario. Cesare ne invia un
altro al legato C. Fabio e gli comunica di guidare la legione nei
territori degli Atrebati, da dove sapeva di dover transitare. Scrive a
Labieno di venire con la legione nelle terre dei Nervi, se la sua partenza
non era di danno per gli interessi di Roma. Ritiene di non dover aspettare
il resto dell'esercito, stanziato un po' troppo lontano; dai campi
invernali più vicini raccoglie circa quattrocento cavalieri.
[47
Le staffette, verso le nove di mattina, lo informano dell'arrivo di Crasso
ed egli, per quel giorno, avanza di circa venti miglia. Destina Crasso a
Samarobriva e gli attribuisce il comando della legione perché lasciava lì
le salmerie dell'esercito, gli ostaggi delle varie popolazioni, i
documenti ufficiali e tutto il grano trasportato per affrontare l'inverno.
Fabio con la sua legione, secondo gli ordini, senza perdere troppo tempo,
si ricongiunge con lui mentre era in marcia. Quando Labieno era ormai al
corrente della morte di Sabino e della strage delle coorti, i Treveri
giungono con tutto l'esercito: egli ebbe paura, se lasciava il campo con
una partenza simile a una fuga, di non riuscire a tener testa all'assalto
dei nemici, tanto più che li sapeva imbaldanziti per la recente vittoria.
Perciò, scrive a Cesare il pericolo a cui si troverebbe esposta la legione
guidata fuori dall'accampamento, gli illustra le vicende accadute tra gli
Eburoni e lo informa che la fanteria e la cavalleria dei Treveri, al gran
completo, si erano insediate a tre miglia di distanza dal suo campo.
[48
Cesare approvò la decisione di Labieno e, benché, così, caduta la speranza
di contare su tre legioni, dovesse accontentarsi di due, continuava a
pensare che l'unica via di salvezza comune consistesse nella rapidità di
azione. A marce forzate raggiunge la regione dei Nervi. Qui, dai
prigionieri apprende che cosa succede nel campo di Cicerone e come la
situazione sia critica. Allora, offrendogli un forte compenso, persuade
uno dei cavalieri galli a portare a Cicerone una lettera. La scrive in
greco, per evitare che i nemici, in caso di intercettazione, scoprissero i
nostri piani. Dà ordine al Gallo, se non fosse riuscito a penetrare nel
campo romano, di scagliare all'interno delle fortificazioni una tragula,
con la lettera legata alla correggia. Nella missiva scrive che era già in
marcia con le legioni e che presto sarebbe giunto; esorta Cicerone a
mostrarsi all'altezza dell'antico valore. Il Gallo, temendo il pericolo,
scaglia la tragula secondo gli ordini ricevuti. Il caso volle che si
conficcasse in una torre e che per due giorni i nostri non se ne
accorgessero. Il terzo giorno viene notata da un soldato, divelta e
consegnata a Cicerone. Egli legge attentamente la missiva e poi ne
comunica il contenuto pubblicamente, con grande gioia di tutti. Al tempo
stesso si scorgevano, in lontananza, fumi di fuochi: ogni dubbio
sull'arrivo delle legioni venne fugato.
[49
I Galli, informati del fatto dagli esploratori, tolgono l'assedio e con
tutte le truppe, circa sessantamila armati, si dirigono contro Cesare.
Cicerone, grazie all'intervento del solito Verticone - se n'è già parlato
- trova un Gallo che recapiti una lettera a Cesare, visto che era
possibile, e lo avverte di muoversi con cautela e attenzione; nella
missiva spiega a Cesare che il nemico si era allontanato e che, in forze,
stava dirigendosi contro di lui. La lettera, verso mezzanotte, perviene a
Cesare, che informa i suoi e li incoraggia in vista della battaglia.
L'indomani, all'alba, sposta l'accampamento e, percorse circa quattro
miglia, avvista la massa dei nemici tra una valle e un corso d'acqua. Era
molto rischioso combattere su un terreno sfavorevole e avendo truppe così
esigue; allora, sapendo che Cicerone era stato liberato dall'assedio, in
tutta serenità non riteneva necessario stringere i tempi. Si ferma dunque
e fortifica il campo nel posto che offriva più vantaggi; sebbene
l'accampamento fosse già, per sé, di modeste proporzioni (era per appena
settemila uomini e, per di più, privi di bagagli), lo rende ancor più
piccolo stringendo al massimo i passaggi, per indurre il nemico al più
profondo disprezzo. Nel frattempo, mediante esploratori inviati in tutte
le direzioni, esamina quale sia il percorso più agevole per attraversare
la valle.
[50
Quel giorno si verificarono solo scaramucce di cavalleria nei pressi del
corso d'acqua, mentre entrambi gli eserciti tenevano le proprie posizioni:
i Galli in quanto aspettavano l'arrivo di truppe ancor più numerose, non
ancora giunte; Cesare nella speranza di riuscire, simulando timore, ad
attirare sul suo terreno i nemici per combattere al di qua della valle,
dinnanzi al campo, o, in caso contrario, per riuscire, una volta esplorate
le strade, ad attraversare la valle e il corso d'acqua con minore
pericolo. All'alba la cavalleria avversaria si avvicina al campo e attacca
battaglia con i nostri cavalieri. Cesare, di proposito, ordina ai suoi di
ritirarsi e di rientrare all'accampamento. Al tempo stesso, comanda di
rinforzare con un vallo più alto tutti i lati del campo e di ostruire le
porte; dà ordine ai soldati di eseguire le operazioni con estrema
precipitazione e di simulare paura.
[51
I nemici, attirati da tutto ciò, varcano il fiume con le loro truppe e le
schierano in un luogo sfavorevole. Mentre i nostri abbandonano il vallo,
gli avversari si avvicinano ancor più e da tutti i lati scagliano dardi
all'interno delle fortificazioni. Poi, mandano araldi tutt'intorno al
campo e annunziano quanto segue: era consentito a chiunque lo volesse,
Gallo o Romano, di passare dalla loro parte, senza alcun pericolo, entro
le nove di mattina; scaduto il termine, nessuno ne avrebbe più avuto la
facoltà. Disprezzarono i nostri a tal punto, che alcuni dei loro
cominciarono a smantellare il vallo con le mani, altri a riempire i
fossati, perché non ritenevano possibile un'irruzione dalle porte,
ostruite per finta da una sola fila di zolle. Allora Cesare, con una
sortita da tutte le porte, lancia la cavalleria alla carica e mette in
fuga gli avversari, senza che neppure uno riuscisse a combattere e
resistere: ne uccide molti, li costringe tutti a gettare le armi.
[52
Cesare ritenne rischioso spingersi troppo in là, perché si frapponevano
selve e paludi, e si rendeva conto che non c'era modo di infliggere agli
avversari il benché minimo danno. Così, quel giorno stesso, senza nessuna
perdita, raggiunge Cicerone. Qui, con stupore, vede le torri costruite, le
testuggini e le fortificazioni dei nemici; quando la legione viene
schierata, si rende conto che neanche un soldato su dieci è illeso; da
tutti questi elementi giudica con quanto pericolo e con quale valore sia
stata affrontata la situazione: loda pubblicamente per i suoi meriti
Cicerone e i soldati, chiama individualmente i centurioni e i tribuni
militari che - lo sapeva per testimonianza di Cicerone - si erano distinti
per singolare valore. Dai prigionieri apprende altri particolari sulla
fine di Sabino e Cotta. Il giorno seguente riunisce le truppe, descrive
l'accaduto, ma rincuora e rassicura i soldati; spiega che il rovescio,
subito per colpa e imprudenza di un legato, doveva essere sopportato con
animo tanto più sereno, in quanto, per beneficio degli dèi immortali e per
il loro valore, il disastro era stato vendicato; la gioia dei nemici era
stata breve, quindi il loro dolore non doveva durare troppo a lungo.
[53
Nello stesso tempo, i Remi recano a Labieno la notizia della vittoria di
Cesare, con incredibile rapidità. Infatti, sebbene il campo di Cicerone,
dove Cesare era giunto dopo le tre di pomeriggio, distasse circa sessanta
miglia dall'accampamento di Labieno, qui, prima di mezzanotte, si levò
clamore alle porte: erano le grida dei Remi in segno di vittoria e di
congratulazione. Il fatto viene riferito anche ai Treveri; Induziomaro,
che aveva già fissato per l'indomani l'assedio al campo di Labieno, di
notte fugge e riconduce tutte le sue truppe nella regione dei Treveri.
Cesare ordina a Fabio di rientrare con la sua legione all'accampamento
invernale; dal canto suo, fissa tre quartieri d'inverno, separati,
tutt'intorno a Samarobriva e decide, date le numerose sollevazioni
verificatesi in Gallia, di rimanere personalmente con l'esercito per tutto
l'inverno. Infatti, una volta diffusasi la notizia della sconfitta e della
morte di Sabino, quasi tutti i popoli della Gallia si consultavano sulla
guerra, inviavano messi in tutte le direzioni, s'informavano sulle
decisioni degli altri e da dove sarebbe partita l'insurrezione, tenevano
concili notturni in zone deserte. Per tutto l'inverno, non ci fu per
Cesare un momento tranquillo: riceveva di continuo notizie sui progetti e
la ribellione dei Galli. Tra l'altro, L. Roscio, preposto alla tredicesima
legione, lo informò che ingenti truppe galliche delle popolazioni chiamate
aremoriche, si erano radunate con l'intenzione di assediarlo ed erano a
non più di otto miglia dal suo campo, ma, alla notizia della vittoria di
Cesare, si erano allontanate con una rapidità tale, che la loro partenza
era sembrata piuttosto una fuga.
[54
Cesare, allora, convocò i principi di ciascun popolo, e ora col timore
precisando di essere al corrente di quanto accadeva, ora con la
persuasione, indusse la maggior parte delle genti galliche al rispetto
degli impegni assunti. Tuttavia i Senoni, tra i più forti e autorevoli in
Gallia, a seguito di decisione pubblica, tentarono di eliminare Cavarino,
che Cesare aveva designato loro sovrano (e già erano stati re suo fratello
Moritasgo, all'epoca dell'arrivo di Cesare in Gallia, e i suoi avi).
Cavarino ne presagì le intenzioni e fuggì; i suoi avversari gli diedero la
caccia sino al confine e lo bandirono dal trono e dal paese. In seguito,
inviarono a Cesare un'ambasceria per discolparsi: egli comandò che tutti i
senatori si presentassero da lui, ma il suo ordine venne disatteso. A
quegli uomini barbari bastò che ci fossero dei fautori della guerra: in
tutti si verificò un tale mutamento di propositi, che quasi nessun popolo
rimase al di sopra dei nostri sospetti, se si eccettuano gli Edui e i
Remi, che Cesare tenne sempre in particolare onore - i primi per l'antica
e costante lealtà nei confronti del popolo romano, i secondi per i recenti
servizi durante la guerra in Gallia. Ma non so se la cosa sia poi tanto
strana, tenendo soprattutto presente che, tra le molte altre cause, popoli
considerati superiori a tutti, per valore militare, adesso erano
profondamente afflitti per aver perso prestigio al punto da dover
sottostare al dominio di Roma.
[55
I Treveri e Induziomaro, però, per tutto l'inverno non smisero un attimo
di inviare ambascerie oltre il Reno e di sobillare le altre genti, di
promettere denaro e di sostenere che, distrutto ormai il grosso del nostro
esercito, ne restava solo una minima parte. Ma non gli riuscì di
persuadere nessun popolo dei Germani a varcare il Reno; affermavano di
averne fatta già due volte esperienza, con la guerra di Ariovisto e il
passaggio dei Tenteri: non avrebbero tentato ulteriormente la sorte.
Caduta tale speranza, Induziomaro cominciò lo stesso a radunare truppe e a
esercitarle, a fornirsi di cavalli dalle genti vicine e ad attirare a sé,
con grandi remunerazioni, gli esuli e le persone condannate di tutta la
Gallia. In tal modo si era già procurato in Gallia tanta autorità, che da
ogni regione accorrevano ambascerie e gli chiedevano i suoi favori e la
sua amicizia, per l'interesse pubblico e privato.
[56
Induziomaro, quando si rese conto della spontaneità di tali ambascerie e
che, da un lato, i Senoni e i Carnuti erano spinti dalla consapevolezza
della propria colpa, dall'altro i Nervi e gli Atuatuci preparavano guerra
ai Romani, e, inoltre, che non gli sarebbero mancate bande di volontari,
se si fosse mosso dai suoi territori, convoca un'assemblea armata. È il
modo con cui di solito i Galli iniziano una guerra: per una legge comune,
tutti i giovani sono costretti a venirvi in armi; chi giunge ultimo, al
cospetto di tutti viene sottoposto a torture d'ogni sorta e ucciso. In
tale assemblea Induziomaro dichiara Cingetorige, capo della fazione
avversa e suo genero - abbiamo già ricordato che si era messo sotto la
protezione di Cesare e gli era rimasto fedele - nemico pubblico e ne
confisca le sostanze. Dopo tali risoluzioni, nel concilio Induziomaro
annuncia solennemente di aver accolto le sollecitazioni dei Senoni, dei
Carnuti e di molte altre genti della Gallia; intende attraversare i
territori dei Remi e devastarne i campi, ma, prima, vuole porre l'assedio
al campo di Labieno. Impartisce gli ordini da eseguire.
[57
Labieno, al riparo in un accampamento ben munito per conformazione
naturale e numero di soldati, non nutriva timori per sé o per la legione.
Tuttavia, meditava di non lasciarsi sfuggire nessuna occasione per una
bella impresa. Così, non appena informato da Cingetorige e dai suoi
parenti del discorso di Induziomaro al concilio, Labieno invia messi alle
genti limitrofe e fa venire a sé da ogni parte cavalieri: fissa la data in
cui avrebbero dovuto presentarsi. Frattanto, quasi ogni giorno
Induziomaro, con la cavalleria al completo, incrociava nei pressi
dell'accampamento, vuoi per prender visione di com'era disposto il campo,
vuoi per intavolare discorsi o suscitar timori; i suoi cavalieri,
generalmente, scagliavano frecce all'interno del vallo. Labieno teneva i
suoi entro le fortificazioni e cercava, con ogni mezzo, di dar
l'impressione di aver paura.
[58
Mentre Induziomaro, di giorno in giorno, si avvicinava al campo con
maggior sicurezza, Labieno una notte fece entrare i cavalieri richiesti a
tutte le genti limitrofe; grazie alle sentinelle, riuscì a trattenere
tutti i suoi all'interno del campo così bene, che in nessun modo la
notizia poté trapelare o giungere ai Treveri. Nel frattempo Induziomaro,
come ogni giorno, si avvicina all'accampamento e qui trascorre la maggior
parte del giorno: i suoi cavalieri scagliano frecce e provocano i nostri a
battaglia con ingiurie d'ogni sorta. I nostri non rispondono e gli
avversari, quando lo ritengono opportuno, al calar della sera, si
allontanano a piccoli gruppi, disunendosi. All'improvviso Labieno, da due
porte, lancia alla carica tutta la cavalleria: dà ordine e disposizione
che, dopo aver spaventato e messo in fuga i nemici (prevedeva che sarebbe
successo, come in effetti capitò), tutti puntino solo su Induziomaro e non
colpiscano nessun altro prima di averlo visto morto: non voleva che,
mentre si attardavano a inseguire gli altri, il Gallo trovasse una via di
scampo. Promette grandi ricompense a chi l'avesse ucciso; invia le coorti
in appoggio ai cavalieri. La Fortuna asseconda il piano dell'uomo: tutti
si lanciano su Induziomaro, lo catturano proprio sul guado del fiume e lo
uccidono; la sua testa viene portata all'accampamento; i cavalieri, nel
rientrare, inseguono e massacrano quanti più nemici possono. Avute queste
notizie, tutte le truppe degli Eburoni e dei Nervi, che si erano lì
concentrate, si disperdono: dopo questa battaglia Cesare riuscì a tenere
un po' più tranquilla la Gallia. |
LIBER SEXTUS
[1] Multis de causis Caesar maiorem Galliae motum exspectans per Marcum Silanum, Gaium Antistium Reginum, Titum Sextium legatos dilectum habere instituit; simul ab Gnaeo Pompeio proconsule petit, quoniam ipse ad urbem cum imperio rei publicae causa remaneret, quos ex Cisalpina Gallia consulis sacramento rogavisset, ad signa convenire et ad se proficisci iuberet, magni interesse etiam in reliquum tempus ad opinionem Galliae existimans tantas videri Italiae facultates ut, si quid esset in bello detrimenti acceptum, non modo id brevi tempore sarciri, sed etiam maioribus augeri copiis posset. Quod cum Pompeius et rei publicae et amicitiae tribuisset, celeriter confecto per suos dilectu tribus ante exactam hiemem et constitutis et adductis legionibus duplicatoque earum cohortium numero, quas cum Quinto Titurio amiserat, et celeritate et copiis docuit, quid populi Romani disciplina atque opes possent.
[2] Interfecto Indutiomaro, ut docuimus, ad eius propinquos a Treveris imperium defertur. Illi finitimos Germanos sollicitare et pecuniam polliceri non desistunt. Cum ab proximis impetrare non possent, ulteriores temptant. Inventis nonnullis civitatibus iureiurando inter se confirmant obsidibusque de pecunia cavent: Ambiorigem sibi societate et foedere adiungunt. Quibus rebus cognitis Caesar, cum undique bellum parari videret, Nervios, Aduatucos ac Menapios adiunctis Cisrhenanis omnibus Germanis esse in armis, Senones ad imperatum non venire et cum Carnutibus finitimisque civitatibus consilia communicare, a Treveris Germanos crebris legationibus sollicitari, maturius sibi de bello cogitandum putavit.
[3] Itaque nondum hieme confecta proximis quattuor coactis legionibus de improviso in fines Nerviorum contendit et, priusquam illi aut convenire aut profugere possent, magno pecoris atque hominum numero capto atque ea praeda militibus concessa vastatisque agris in deditionem venire atque obsides sibi dare coegit. Eo celeriter confecto negotio rursus in hiberna legiones reduxit. Concilio Galliae primo vere, ut instituerat, indicto, cum reliqui praeter Senones, Carnutes Treverosque venissent, initium belli ac defectionis hoc esse arbitratus, ut omnia postponere videretur, concilium Lutetiam Parisiorum transfert. Confines erant hi Senonibus civitatemque patrum memoria coniunxerant, sed ab hoc consilio afuisse existimabantur. Hac re pro suggestu pronuntiata eodem die cum legionibus in Senones proficiscitur magnisque itineribus eo pervenit.
[4] Cognito eius adventu Acco, qui princeps eius consili fuerat, iubet in oppida multitudinem convenire. Conantibus, priusquam id effici posset, adesse Romanos nuntiatur. Necessario sententia desistunt legatosque deprecandi causa ad Caesarem mittunt: adeunt per Aeduos, quorum antiquitus erat in fide civitas. Libenter Caesar petentibus Aeduis dat veniam excusationemque accipit, quod aestivum tempus instantis belli, non quaestionis esse arbitrabatur. Obsidibus imperatis centum hos Aeduis custodiendos tradit. Eodem Carnutes legatos obsidesque mittunt usi deprecatoribus Renis, quorum erant in clientela: eadem ferunt responsa. Peragit concilium Caesar equitesque imperat civitatibus.
[5] Hac parte Galliae pacata totus et mente et animo in bellum Treverorum et Ambiorigis insistit. Cavarinum cum equitatu Senonum secum proficisci iubet, ne quis aut ex huius iracundia aut ex eo, quod meruerat, odio civitatis motus exsistat. His rebus constitutis, quod pro explorato habebat Ambiorigem proelio non esse concertaturum, reliqua eius consilia animo circumspiciebat. Erant Menapii propinqui Eburonum finibus, perpetuis paludibus silvisque muniti, qui uni ex Gallia de pace ad Caesarem legatos numquam miserant. Cum his esse hospitium Ambiorigi sciebat; item per Treveros venisse Germanis in amicitiam cognoverat. Haec prius illi detrahenda auxilia existimabat quam ipsum bello lacesseret, ne desperata salute aut se in Menapios abderet aut cum Transrhenanis congredi cogeretur. Hoc inito consilio totius exercitus impedimenta ad Labienum in Treveros mittit duasque legiones ad eum proficisci iubet; ipse cum legionibus expeditis quinque in Menapios proficiscitur. Illi nulla coacta manu loci praesidio freti in silvas paludesque confugiunt suaque eodem conferunt.
[6] Caesar partitis copiis cum Gaio Fabio legato et Marco Crasso quaestore celeriterque effectis pontibus adit tripertito, aedificia vicosque incendit, magno pecoris atque hominum numero potitur. Quibus rebus coacti Menapii legatos ad eum pacis petendae causa mittunt. Ille obsidibus acceptis hostium se habiturum numero confirmat, si aut Ambiorigem aut eius legatos finibus suis recepissent. His confirmatis rebus Commium Atrebatem cum equitatu custodis loco in Menapiis relinquit; ipse in Treveros proficiscitur.
[7] Dum haec a Caesare geruntur, Treveri magnis coactis peditatus equitatusque copiis Labienum cum una legione, quae in eorum finibus hiemaverat, adoriri parabant, iamque ab eo non longius bidui via aberant, cum duas venisse legiones missu Caesaris cognoscunt. Positis castris a milibus passuum XV auxilia Germanorum esspectare constituunt. Labienus hostium cognito consilio sperans temeritate eorum fore aliquam dimicandi facultatem praesidio quinque cohortium impedimentis relicto cum viginti quinque cohortibus magnoque equitatu contra hostem proficiscitur et mille passuum intermisso spatio castra communit. Erat inter Labienum atque hostem difficili transitu flumen ripisque praeruptis. Hoc neque ipse transire habebat in animo neque hostes transituros existi mabat. Augebatur auxiliorum cotidie spes. Loquitur in concilio palam, quoniam Germani appropinquare dicantur, sese suas exercitusque fortunas in dubium non devocaturum et postero die prima luce castra moturum. Celeriter haec ad hostes deferuntur, ut ex magno Gallorum equitum numero nonnullos Gallicis rebus favere natura cogebat. Labienus noctu tribunis militum primisque ordinibus convocatis, quid sui sit consili proponit et, quo facilius hostibus timoris det suspicionem, maiore strepitu et tumultu, quam populi Romani fert consuetudo castra moveri iubet. His rebus fugae similem profectionem effecit. Haec quoque per exploratores ante lucem in tanta propinquitate castrorum ad hostes deferuntur.
[8] Vix agmen novissimum extra munitiones processerat, cum Galli cohortati inter se, ne speratam praedam ex manibus dimitterent--longum esse per territis Romanis Germanorum auxilium exspectare, neque suam pati dignitatem ut tantis copiis tam exiguam manum praesertim fugientem atque impeditam adoriri non audeant--flumen transire et iniquo loco committere proelium non dubitant. Quae fore suspicatus Labienus, ut omnes citra flumen eliceret, eadem usus simulatione itineris placide progrediebatur. Tum praemissis paulum impedimentis atque in tumulo quodam collocatis "Habetis," inquit, "milites, quam petistis facultatem: hostem impedito atque iniquo loco tenetis: praestate eandem nobis ducibus virtutem, quam saepe numero imperatori praestitistis, atque illum adesse et haec coram cernere existimate." Simul signa ad hostem converti aciemque dirigi iubet, et paucis turmis praesidio ad impedimenta dimissis reliquos equites ad latera disponit. Celeriter nostri clamore sublato pila in hostes immittunt. Illi, ubi praeter spem quos fugere credebant infestis signis ad se ire viderunt, impetum modo ferre non potuerunt ac primo concursu in fugam coniecti proximas silvas petierunt. Quos Labienus equitatu consectatus, magno numero interfecto, compluribus captis, paucis post diebus civitatem recepit. Nam Germani qui auxilio veniebant percepta Treverorum fuga sese domum receperunt. Cum his propinqui Indutiomari, qui defectionis auctores fuerant, comitati eos ex civitate excesserunt. Cingetorigi, quem ab initio permansisse in officio demonstravimus, principatus atque imperium est traditum.
[9] Caesar, postquam ex Menapiis in Treveros venit, duabus de causis Rhenum transire constituit; quarum una erat, quod auxilia contra se Treveris miserant, altera, ne ad eos Ambiorix receptum haberet. His constitutis rebus paulum supra eum locum quo ante exercitum traduxerat facere pontem instituit. Nota atque instituta ratione magno militum studio paucis diebus opus efficitur. Firmo in Treveris ad pontem praesidio relicto, ne quis ab his subito motus oreretur, reliquas copias equitatumque traducit. Ubii, qui ante obsides dederant atque in deditionem venerant, purgandi sui causa ad eum legatos mittunt, qui doceant neque auxilia ex sua civitate in Treveros missa neque ab se fidem laesam: petunt atque orant ut sibi parcat, ne communi odio Germanorum innocentes pro nocentibus poenas pendant; si amplius obsidum vellet, dare pollicentur. Cognita Caesar causa reperit ab Suebis auxilia missa esse; Ubiorum satisfactionem accipit, aditus viasque in Suebos perquirit.
[10] Interim paucis post diebus fit ab Ubiis certior Suebos omnes in unum locum copias cogere atque eis nationibus quae sub eorum sint imperio denuntiare, ut auxilia peditatus equitatusque mittant. His cognitis rebus rem frumentariam providet, castris idoneum locum deligit; Ubiis imperat ut pecora deducant suaque omnia ex agris in oppida conferant, sperans barbaros atque imperitos homines inopia cibariorum adductos ad iniquam pugnandi condicionem posse deduci; mandat, ut crebros exploratores in Suebos mittant quaeque apud eos gerantur cognoscant. Illi imperata faciunt et paucis diebus intermissis referunt: Suebos omnes, posteaquam certiores nuntii de exercitu Romanorum venerint, cum omnibus suis sociorumque copiis, quas coegissent, penitus ad extremos fines se recepisse: silvam esse ibi infinita magnitudine, quae appellatur Bacenis; hanc longe introrsus pertinere et pro nativo muro obiectam Cheruscos ab Suebis Suebosque ab Cheruscis iniuriis incursionibusque prohibere: ad eius initium silvae Suebos adventum Romanorum exspectare constituisse.
[11] Quoniam ad hunc locum perventum est, non alienum esse videtur de Galliae Germaniaeque moribus et quo differant hae nationes inter sese proponere. In Gallia non solum in omnibus civitatibus atque in omnibus pagis partibusque, sed paene etiam in singulis domibus factiones sunt, earumque factionum principes sunt qui summam auctoritatem eorum iudicio habere existimantur, quorum ad arbitrium iudiciumque summa omnium rerum consiliorumque redeat. Itaque eius rei causa antiquitus institutum videtur, ne quis ex plebe contra potentio rem auxili egeret: suos enim quisque opprimi et circumveniri non patitur, neque, aliter si faciat, ullam inter suos habet auctoritatem. Haec eadem ratio est in summa totius Galliae: namque omnes civitates in partes divisae sunt duas.
[12] Cum Caesar in Galliam venit, alterius factionis principes erant Aedui, alterius Sequani. Hi cum per se minus valerent, quod summa auctoritas antiquitus erat in Aeduis magnaeque eorum erant clientelae, Germanos atque Ariovistum sibi adiunxerant eosque ad se magnis iacturis pollicitationibusque perduxerant. Proeliis vero compluribus factis secundis atque omni nobilitate Aeduorum interfecta tantum potentia antecesserant, ut magnam partem clientium ab Aeduis ad se traducerent obsidesque ab eis principum filios acciperent et publice iurare cogerent nihil se contra Sequanos consili inituros et partem finitimi agri per vim occupatam possiderent Galliaeque totius principatum obtinerent. Qua necessitate adductus Diviciacus auxili petendi causa Romam ad senatum profectus infecta re redierat. Adventu Caesaris facta commutatione rerum, obsidibus Aeduis redditis, veteribus clientelis restitutis, novis per Caesarem comparatis, quod hi, qui se ad eorum amicitiam adgregaverant, meliore condicione atque aequiore imperio se uti videbant, reliquis rebus eorum gratia dignitateque amplificata Sequani principatum dimiserant. In eorum locum Remi successerant: quos quod adaequare apud Caesarem gratia intellegebatur, ei, qui propter veteres inimicitias nullo modo cum Aeduis coniungi poterant, se Remis in clientelam dicabant. Hos illi diligenter tuebantur: ita et novam et repente collectam auctoritatem tene bant. Eo tum statu res erat, ut longe principes haberentur Aedui, secundum locum dignitatis Remi obtinerent.
[13] In omni Gallia eorum hominum, qui aliquo sunt numero atque honore, genera sunt duo. Nam plebes paene servorum habetur loco, quae nihil audet per se, nullo adhibetur consilio. Plerique, cum aut aere alieno aut magnitudine tributorum aut iniuria potentiorum premuntur, sese in servitutem dicant nobilibus: in hos eadem omnia sunt iura, quae dominis in servos. Sed de his duobus generibus alterum est druidum, alterum equitum. Illi rebus divinis intersunt, sacrificia publica ac privata procurant, religiones interpretantur: ad hos magnus adulescentium numerus disciplinae causa concurrit, magnoque hi sunt apud eos honore. Nam fere de omnibus controversiis publicis privatisque constituunt, et, si quod est admissum facinus, si caedes facta, si de hereditate, de finibus controversia est, idem decernunt, praemia poenasque constituunt; si qui aut privatus aut populus eorum decreto non stetit, sacrificiis interdicunt. Haec poena apud eos est gravissima. Quibus ita est interdictum, hi numero impiorum ac sceleratorum habentur, his omnes decedunt, aditum sermonemque defugiunt, ne quid ex contagione incommodi accipiant, neque his petentibus ius redditur neque honos ullus communicatur. His autem omnibus druidibus praeest unus, qui summam inter eos habet auctoritatem. Hoc mortuo aut si qui ex reliquis excellit dignitate succedit, aut, si sunt plures pares, suffragio druidum, nonnumquam etiam armis de principatu contendunt. Hi certo anni tempore in finibus Carnutum, quae regio totius Galliae media habetur, considunt in loco consecrato. Huc omnes undique, qui controversias habent, conveniunt eorumque decretis iudiciisque parent. Disciplina in Britannia reperta atque inde in Galliam translata esse existimatur, et nunc, qui diligentius eam rem cognoscere volunt, plerumque illo discendi causa proficiscuntur.
[14] Druides a bello abesse consuerunt neque tributa una cum reliquis pendunt; militiae vacationem omniumque rerum habent immunitatem. Tantis excitati praemiis et sua sponte multi in disciplinam conveniunt et a parentibus propinquisque mittuntur. Magnum ibi numerum versuum ediscere dicuntur. Itaque annos nonnulli vicenos in disciplina permanent. Neque fas esse existimant ea litteris mandare, cum in reliquis fere rebus, publicis privatisque rationibus Graecis litteris utantur. Id mihi duabus de causis instituisse videntur, quod neque in vulgum disciplinam efferri velint neque eos, qui discunt, litteris confisos minus memoriae studere: quod fere plerisque accidit, ut praesidio litterarum diligentiam in perdiscendo ac memoriam remittant. In primis hoc volunt persuadere, non interire animas, sed ab aliis post mortem transire ad alios, atque hoc maxime ad virtutem excitari putant metu mortis neglecto. Multa praeterea de sideribus atque eorum motu, de mundi ac terrarum magnitudine, de rerum natura, de deorum immortalium vi ac potestate disputant et iuventuti tradunt.
[15] Alterum genus est equitum. Hi, cum est usus atque aliquod bellum incidit (quod fere ante Caesaris adventum quotannis accidere solebat, uti aut ipsi iniurias inferrent aut illatas propulsarent), omnes in bello versantur, atque eorum ut quisque est genere copiisque amplissimus, ita plurimos circum se ambactos clientesque habet. Hanc unam gratiam potentiamque noverunt.
[16] Natio est omnis Gallorum admodum dedita religionibus, atque ob eam causam, qui sunt adfecti gravioribus morbis quique in proeliis periculisque versantur, aut pro victimis homines immolant aut se immolaturos vovent administrisque ad ea sacrificia druidibus utuntur, quod, pro vita hominis nisi hominis vita reddatur, non posse deorum immortalium numen placari arbitrantur, publiceque eiusdem generis habent instituta sacrificia. Alii immani magnitudine simulacra habent, quorum contexta viminibus membra vivis hominibus complent; quibus succensis circumventi flamma exanimantur homines. Supplicia eorum qui in furto aut in latrocinio aut aliqua noxia sint comprehensi gratiora dis immortalibus esse arbitrantur; sed, cum eius generis copia defecit, etiam ad innocentium supplicia descendunt.
[17] Deum maxime Mercurium colunt. Huius sunt plurima simulacra: hunc omnium inventorem artium ferunt, hunc viarum atque itinerum ducem, hunc ad quaestus pecuniae mercaturasque habere vim maximam arbitrantur. Post hunc Apollinem et Martem et Iovem et Minervam. De his eandem fere, quam reliquae gentes, habent opinionem: Apollinem morbos depellere, Minervam operum atque artificiorum initia tradere, Iovem imperium caelestium tenere, Martem bella regere. Huic, cum proelio dimicare constituerunt, ea quae bello ceperint plerumque devovent: cum superaverunt, animalia capta immolant reliquasque res in unum locum conferunt. Multis in civitatibus harum rerum exstructos tumulos locis consecratis conspicari licet; neque saepe accidit, ut neglecta quispiam religione aut capta apud se occultare aut posita tollere auderet, gravissimumque ei rei supplicium cum cruciatu constitutum est.
[18] Galli se omnes ab Dite patre prognatos praedicant idque ab druidibus proditum dicunt. Ob eam causam spatia omnis temporis non numero dierum sed noctium finiunt; dies natales et mensum et annorum initia sic observant ut noctem dies subsequatur. In reliquis vitae institutis hoc fere ab reliquis differunt, quod suos liberos, nisi cum adoleverunt, ut munus militiae sustinere possint, palam ad se adire non patiuntur filiumque puerili aetate in publico in conspectu patris adsistere turpe ducunt.
[19] Viri, quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex suis bonis aestimatione facta cum dotibus communicant. Huius omnis pecuniae coniunctim ratio habetur fructusque servantur: uter eorum vita superarit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit. Viri in uxores, sicuti in liberos, vitae necisque habent potestatem; et cum paterfamiliae illustriore loco natus decessit, eius propinqui conveniunt et, de morte si res in suspicionem venit, de uxoribus in servilem modum quaestionem habent et, si compertum est, igni atque omnibus tormentis excruciatas interficiunt. Funera sunt pro cultu Gallorum magnifica et sumptuosa; omniaque quae vivis cordi fuisse arbitrantur in ignem inferunt, etiam animalia, ac paulo supra hanc memoriam servi et clientes, quos ab eis dilectos esse constabat, iustis funeribus confectis una cremabantur.
[20] Quae civitates commodius suam rem publicam administrare existimantur, habent legibus sanctum, si quis quid de re publica a finitimis rumore aut fama acceperit, uti ad magistratum deferat neve cum quo alio communicet, quod saepe homines temerarios atque imperitos falsis rumoribus terreri et ad facinus impelli et de summis rebus consilium capere cognitum est. Magistratus quae visa sunt occultant quaeque esse ex usu iudicaverunt multitudini produnt. De re publica nisi per concilium loqui non conceditur.
[21] Germani multum ab hac consuetudine differunt. Nam neque druides habent, qui rebus divinis praesint, neque sacrificiis student. Deorum numero eos solos ducunt, quos cernunt et quorum aperte opibus iuvantur, Solem et Vulcanum et Lunam, reliquos ne fama quidem acceperunt. Vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit: ab parvulis labori ac duritiae student. Qui diutissime impuberes permanserunt, maximam inter suos ferunt laudem: hoc ali staturam, ali vires nervosque confirmari putant. Intra annum vero vicesimum feminae notitiam habuisse in turpissimis habent rebus; cuius rei nulla est occultatio, quod et promiscue in fluminibus perluuntur et pellibus aut parvis renonum tegimentis utuntur magna corporis parte nuda.
[22] Agriculturae non student, maiorque pars eorum victus in lacte, caseo, carne consistit. Neque quisquam agri modum certum aut fines habet proprios; sed magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum, qui una coierunt, quantum et quo loco visum est agri attribuunt atque anno post alio transire cogunt. Eius rei multas adferunt causas: ne adsidua consuetudine capti studium belli gerendi agricultura commutent; ne latos fines parare studeant, potentioresque humiliores possessionibus expellant; ne accuratius ad frigora atque aestus vitandos aedificent; ne qua oriatur pecuniae cupiditas, qua ex re factiones dissensionesque nascuntur; ut animi aequitate plebem contineant, cum suas quisque opes cum potentissimis aequari videat.
[23] Civitatibus maxima laus est quam latissime circum se vastatis finibus solitudines habere. Hoc proprium virtutis existimant, expulsos agris finitimos cedere, neque quemquam prope audere consistere; simul hoc se fore tutiores arbitrantur repentinae incursionis timore sublato. Cum bellum civitas aut illa tum defendit aut infert, magistratus, qui ei bello praesint, ut vitae necisque habeant potestatem, deliguntur. In pace nullus est communis magistratus, sed principes regionum atque pagorum inter suos ius dicunt controversiasque minuunt. Latrocinia nullam habent infamiam, quae extra fines cuiusque civitatis fiunt, atque ea iuventutis exercendae ac desidiae minuendae causa fieri praedicant. Atque ubi quis ex principibus in concilio dixit se ducem fore, qui sequi velint, profiteantur, consurgunt ei qui et causam et hominem probant suumque auxilium pollicentur atque ab multitudine collaudantur: qui ex his secuti non sunt, in desertorum ac proditorum numero ducuntur, omniumque his rerum postea fides derogatur. Hospitem violare fas non putant; qui quacumque de causa ad eos venerunt, ab iniuria prohibent, sanctos habent, hisque omnium domus patent victusque communicatur.
[24] Ac fuit antea tempus, cum Germanos Galli virtute superarent, ultro bella inferrent, propter hominum multitudinem agrique inopiam trans Rhenum colonias mitterent. Itaque ea quae fertilissima Germaniae sunt loca circum Hercyniam silvam, quam Eratostheni et quibusdam Graecis fama notam esse video, quam illi Orcyniam appellant, Volcae Tectosages occupaverunt atque ibi consederunt; quae gens ad hoc tempus his sedibus sese continet summamque habet iustitiae et bellicae laudis opinionem. Nunc quod in eadem inopia, egestate, patientia qua Germani permanent, eodem victu et cultu corporis utuntur; Gallis autem provinciarum propinquitas et transmarinarum rerum notitia multa ad copiam atque usus largitur, paulatim adsuefacti superari multisque victi proeliis ne se quidem ipsi cum illis virtute comparant.
[25] Huius Hercyniae silvae, quae supra demonstrata est, latitudo novem dierum iter expedito patet: non enim aliter finiri potest, neque mensuras itinerum noverunt. Oritur ab Helvetiorum et Nemetum et Rauracorum finibus rectaque fluminis Danubi regione pertinet ad fines Dacorum et Anartium; hinc se flectit sinistrorsus diversis ab flumine regionibus multarumque gentium fines propter magnitudinem adtingit; neque quisquam est huius Germaniae, qui se aut adisse ad initium eius silvae dicat, cum dierum iter LX processerit, aut, quo ex loco oriatur, acceperit: multaque in ea genera ferarum nasci constat, quae reliquis in locis visa non sint; ex quibus quae maxime differant ab ceteris et memoriae prodenda videantur haec sunt.
[26] Est bos cervi figura, cuius a media fronte inter aures unum cornu exsistit excelsius magisque directum his, quae nobis nota sunt, cornibus: ab eius summo sicut palmae ramique late divunduntur. Eadem est feminae marisque natura, eadem forma magnitudoque cornuum.
[27] Sunt item, quae appellantur alces. Harum est consimilis capris figura et varietas pellium, sed magnitudine paulo antecedunt mutilaeque sunt cornibus et crura sine nodis articulisque habent neque quietis causa procumbunt neque, si quo adflictae casu conciderunt, erigere sese aut sublevare possunt. His sunt arbores pro cubilibus: ad eas se applicant atque ita paulum modo reclinatae quietem capiunt. Quarum ex vestigiis cum est animadversum a venatoribus, quo se recipere consuerint, omnes eo loco aut ab radicibus subruunt aut accidunt arbores, tantum ut summa species earum stantium relinquatur. Huc cum se consuetudine reclinaverunt, infirmas arbores pondere adfligunt atque una ipsae concidunt.
[28] Tertium est genus eorum, qui uri appellantur. Hi sunt magnitudine paulo infra elephantos, specie et colore et figura tauri. Magna vis eorum est et magna velocitas, neque homini neque ferae quam conspexerunt parcunt. Hos studiose foveis captos interficiunt. Hoc se labore durant adulescentes atque hoc genere venationis exercent, et qui plurimos ex his interfecerunt, relatis in publicum cornibus, quae sint testimonio, magnam ferunt laudem. Sed adsuescere ad homines et mansuefieri ne parvuli quidem excepti possunt. Amplitudo cornuum et figura et species multum a nostrorum boum cornibus differt. Haec studiose conquisita ab labris argento circumcludunt atque in amplissimis epulis pro poculis utuntur.
[29] Caesar, postquam per Ubios exploratores comperit Suebos sese in silvas recepisse, inopiam frumenti veritus, quod, ut supra demonstravimus, minime omnes Germani agriculturae student, constituit non progredi longius; sed, ne omnino metum reditus sui barbaris tolleret atque ut eorum auxilia tardaret, reducto exercitu partem ultimam pontis, quae ripas Ubiorum contingebat, in longitudinem pedum ducentorum rescindit atque in extremo ponte turrim tabulatorum quattuor constituit praesidiumque cohortium duodecim pontis tuendi causa ponit magnisque eum locum munitionibus firmat. Ei loco praesidioque Gaium Volcatium Tullum adulescentem praefecit. Ipse, cum maturescere frumenta inciperent, ad bellum Ambiorigis profectus per Arduennam silvam, quae est totius Galliae maxima atque ab ripis Rheni finibusque Treverorum ad Nervios pertinet milibusque amplius quingentis in longitudinem patet, Lucium Minucium Basilum cum omni equitatu praemittit, si quid celeritate itineris atque opportunitate temporis proficere possit; monet, ut ignes in castris fieri prohibeat, ne qua eius adventus procul significatio fiat: sese confestim subsequi dicit.
[30] Basilus, ut imperatum est, facit. Celeriter contraque omnium opinionem confecto itinere multos in agris inopinantes deprehendit: eorum indicio ad ipsum Ambiorigem contendit, quo in loco cum paucis equitibus esse dicebatur. Multum cum in omnibus rebus tum in re militari potest fortuna. Nam magno accidit casu ut in ipsum incautum etiam atque imparatum incideret, priusque eius adventus ab omnibus videretur, quam fama ac nuntius adferretur: sic magnae fuit fortunae omni militari instrumento, quod circum se habebat, erepto, raedis equisque comprehensis ipsum effugere mortem. Sed hoc quoque factum est, quod aedificio circumdato silva, ut sunt fere domicilia Gallorum, qui vitandi aestus causa plerumque silvarum atque fluminum petunt propinquitates, comites familiaresque eius angusto in loco paulisper equitum nostrorum vim sustinuerunt. His pugnantibus illum in equum quidam ex suis intulit: fugientem silvae texerunt. Sic et ad subeundum periculum et ad vitandum multum fortuna valuit.
[31] Ambiorix copias suas iudicione non conduxerit, quod proelio dimicandum non existimarit, an tempore exclusus et repentino equitum adventu prohibitus, cum reliquum exercitum subsequi crederet, dubium est. Sed certe dimissis per agros nuntiis sibi quemque consulere iussit. Quorum pars in Arduennam silvam, pars in continentes paludes profugit; qui proximi Oceano fuerunt, his insulis sese occultaverunt, quas aestus efficere consuerunt: multi ex suis finibus egressi se suaque omnia alienissimis crediderunt. Catuvolcus, rex dimidiae partis Eburonum, qui una cum Ambiorige consilium inierat, aetate iam confectus, cum laborem aut belli aut fugae ferre non posset, omnibus precibus detestatus Ambiorigem, qui eius consilii auctor fuisset, taxo, cuius magna in Gallia Germaniaque copia est, se exanimavit.
[32] Segni Condrusique, ex gente et numero Germanorum, qui sunt inter Eburones Treverosque, legatos ad Caesarem miserunt oratum, ne se in hostium numero duceret neve omnium Germanorum, qui essent citra Rhenum, unam esse causam iudicaret: nihil se de bello cogitavisse, nulla Ambiorigi auxilia misisse. Caesar explorata re quaestione captivorum, si qui ad eos Eburones ex fuga convenissent, ad se ut reducerentur, imperavit; si ita fecissent, fines eorum se violaturum negavit. Tum copiis in tres partes distributis impedimenta omnium legionum Aduatucam contulit. Id castelli nomen est. Hoc fere est in mediis Eburonum finibus, ubi Titurius atque Aurunculeius hiemandi causa consederant. Hunc cum reliquis rebus locum probabat, tum quod superioris anni munitiones integrae manebant, ut militum laborem sublevaret. Praesidio impedimentis legionem quartamdecimam reliquit, unam ex eis tribus, quas proxime conscriptas ex Italia traduxerat. Ei legioni castrisque Quintum Tullium Ciceronem praeficit ducentosque equites attribuit.
[33] Partito exercitu Titum Labienum cum legionibus tribus ad Oceanum versus in eas partes quae Menapios attingunt proficisci iubet; Gaium Trebonium cum pari legionum numero ad eam regionem quae ad Aduatucos adiacet depopulandam mittit; ipse cum reliquis tribus ad flumen Scaldem, quod influit in Mosam, extremasque Arduennae partis ire constituit, quo cum paucis equitibus profectum Ambiorigem audiebat. Discedens post diem septimum sese reversurum confirmat; quam ad diem ei legioni quae in praesidio relinquebatur deberi frumentum sciebat. Labienum Treboniumque hortatur, si rei publicae commodo facere possint, ad eum diem revertantur, ut rursus communicato consilio exploratisque hostium rationibus aliud initium belli capere possint.
[34] Erat, ut supra demonstravimus, manus certa nulla, non oppidum, non praesidium, quod se armis defenderet, sed in omnes partes dispersa multitudo. Ubi cuique aut valles abdita aut locus silvestris aut palus impedita spem praesidi aut salutis aliquam offerebat, consederat. Haec loca vicinitatibus erant nota, magnamque res diligentiam requirebat non in summa exercitus tuenda (nullum enim poterat universis perterritis ac dispersis periculum accidere), sed in singulis militibus conservandis; quae tamen ex parte res ad salutem exercitus pertinebat. Nam et praedae cupiditas multos longius evocabat, et silvae incertis occultisque itineribus confertos adire prohibebant. Si negotium confici stirpemque hominum sceleratorum interfici vellet, dimittendae plures manus diducendique erant milites; si continere ad signa manipulos vellet, ut instituta ratio et consuetudo exercitus Romani postulabat, locus ipse erat praesidio barbaris, neque ex occulto insidiandi et dispersos circumveniendi singulis deerat audacia. Ut in eiusmodi difficultatibus, quantum diligentia provideri poterat providebatur, ut potius in nocendo aliquid praetermitteretur, etsi omnium animi ad ulciscendum ardebant, quam cum aliquo militum detrimento noceretur. Dimittit ad finitimas civitates nuntios Caesar: omnes ad se vocat spe praedae ad diripiendos Eburones, ut potius in silvis Gallorum vita quam legionarius miles periclitetur, simul ut magna multitudine circumfusa pro tali facinore stirps ac nomen civitatis tollatur. Magnus undique numerus celeriter convenit.
[35] Haec in omnibus Eburonum partibus gerebantur, diesque appetebat septimus, quem ad diem Caesar ad impedimenta legionemque reverti constituerat. Hic quantum in bello fortuna possit et quantos adferat casus cognosci potuit. Dissipatis ac perterritis hostibus, ut demonstravimus, manus erat nulla quae parvam modo causam timoris adferret. Trans Rhenum ad Germanos pervenit fama, diripi Eburones atque ultro omnes ad praedam evocari. Cogunt equitum duo milia Sugambri, qui sunt proximi Rheno, a quibus receptos ex fuga Tencteros atque Usipetes supra docuimus. Transeunt Rhenum navibus ratibusque triginta milibus passuum infra eum locum, ubi pons erat perfectus praesidiumque ab Caesare relictum: primos Eburonum fines adeunt; multos ex fuga dispersos excipiunt, magno pecoris numero, cuius sunt cupidissimi barbari, potiuntur. Invitati praeda longius procedunt. Non hos palus in bello latrociniisque natos, non silvae morantur. Quibus in locis sit Caesar ex captivis quaerunt; profectum longius reperiunt omnemque exercitum discessisse cognoscunt. Atque unus ex captivis "Quid vos," inquit, "hanc miseram ac tenuem sectamini praedam, quibus licet iam esse fortunatissimos? Tribus horis Aduatucam venire potestis: huc omnes suas fortunas exercitus Romanorum contulit: praesidi tantum est, ut ne murus quidem cingi possit, neque quisquam egredi extra munitiones audeat." Oblata spe Germani quam nacti erant praedam in occulto relinquunt; ipsi Aduatucam contendunt usi eodem duce, cuius haec indicio cognoverant.
[36] Cicero, qui omnes superiores dies praeceptis Caesaris cum summa diligentia milites in castris continuisset ac ne calonem quidem quemquam extra munitionem egredi passus esset, septimo die diffidens de numero dierum Caesarem fidem servaturum, quod longius progressum audiebat, neque ulla de reditu eius fama adferebatur, simul eorum permotus vocibus, qui illius patientiam paene obsessionem appellabant, siquidem ex castris egredi non liceret, nullum eiusmodi casum exspectans, quo novem oppositis legionibus maximoque equitatu dispersis ac paene deletis hostibus in milibus passuum tribus offendi posset, quinque cohortes frumentatum in proximas segetes mittit, quas inter et castra unus omnino collis intererat. Complures erant ex legionibus aegri relicti; ex quibus qui hoc spatio dierum convaluerant, circiter CCC, sub vexillo una mittuntur; magna praeterea multitudo calonum, magna vis iumentorum, quae in castris subsederant, facta potestate sequitur.
[37] Hoc ipso tempore et casu Germani equites interveniunt protinusque eodem illo, quo venerant, cursu ab decumana porta in castra irrumpere conantur, nec prius sunt visi obiectis ab ea parte silvis, quam castris appropinquarent, usque eo ut qui sub vallo tenderent mercatores recipiendi sui facultatem non haberent. Inopinantes nostri re nova perturbantur, ac vix primum impetum cohors in statione sustinet. Circumfunduntur ex reliquis hostes partibus, si quem aditum reperire possent. Aegre portas nostri tuentur, reliquos aditus locus ipse per se munitioque defendit. Totis trepidatur castris, atque alius ex alio causam tumultus quaerit; neque quo signa ferantur neque quam in partem quisque conveniat provident. Alius iam castra capta pronuntiat, alius deleto exercitu atque imperatore victores barbaros venisse contendit; plerique novas sibi ex loco religiones fingunt Cottaeque et Tituri calamitatem, qui in eodem occiderint castello, ante oculos ponunt. Tali timore omnibus perterritis confirmatur opinio barbaris, ut ex captivo audierant, nullum esse intus praesidium. Perrumpere nituntur seque ipsi adhortantur, ne tantam fortunam ex manibus dimittant.
[38] Erat aeger cum praesidio relictus Publius Sextius Baculus, qui primum pilum ad Caesarem duxerat, cuius mentionem superioribus proeliis fecimus, ac diem iam quintum cibo caruerat. Hic diffisus suae atque omnium saluti inermis ex tabernaculo prodit: videt imminere hostes atque in summo esse rem discrimine: capit arma a proximis atque in porta consistit. Consequuntur hunc centuriones eius cohortis quae in statione erat: paulisper una proelium sustinent. Relinquit animus Sextium gravibus acceptis vulneribus: aegre per manus tractus servatur. Hoc spatio interposito reliqui sese confirmant tantum, ut in munitionibus consistere audeant speciemque defensorum praebeant.
[39] Interim confecta frumentatione milites nostri clamorem exaudiunt: praecurrunt equites; quanto res sit in periculo cognoscunt. Hic vero nulla munitio est quae perterritos recipiat: modo conscripti atque usus militaris imperiti ad tribunum militum centurionesque ora convertunt; quid ab his praecipiatur exspectant. Nemo est tam fortis quin rei novitate perturbetur. Barbari signa procul conspicati oppugnatione desistunt: redisse primo legiones credunt, quas longius discessisse ex captivis cognoverant; postea despecta paucitate ex omnibus partibus impetum faciunt.
[40] Calones in proximum tumulum procurrunt. Hinc celeriter deiecti se in signa manipulosque coniciunt: eo magis timidos perterrent milites. Alii cuneo facto ut celeriter perrumpant censent, quoniam tam propinqua sint castra, et si pars aliqua circumventa ceciderit, at reliquos servari posse confidunt; alii, ut in iugo consistant atque eundem omnes ferant casum. Hoc veteres non probant milites, quos sub vexillo una profectos docuimus. Itaque inter se cohortati duce Gaio Trebonio, equite Romano, qui eis erat praepositus, per medios hostes perrumpunt incolumesque ad unum omnes in castra perveniunt. Hos subsecuti calones equitesque eodem impetu militum virtute servantur. At ei qui in iugo constiterant, nullo etiam nunc usu rei militaris percepto neque in eo quod probaverant consilio permanere, ut se loco superiore defenderent, neque eam quam prodesse aliis vim celeritatemque viderant imitari potuerunt, sed se in castra recipere conati iniquum in locum demiserunt. Centuriones, quorum nonnulli ex inferioribus ordinibus reliquarum legionum virtutis causa in superiores erant ordines huius legionis traducti, ne ante partam rei militaris laudem amitterent, fortissime pugnantes conciderunt. Militum pars horum virtute summotis hostibus praeter spem incolumis in castra pervenit, pars a barbaris circumventa periit.
[41] Germani desperata expugnatione castrorum, quod nostros iam constitisse in munitionibus videbant, cum ea praeda quam in silvis deposuerant trans Rhenum sese receperunt. Ac tantus fuit etiam post discessum hostium terror ut ea nocte, cum Gaius Volusenus missus cum equitatu ad castra venisset, fidem non faceret adesse cum incolumi Caesarem exercitu. Sic omnino animos timor praeoccupaverat ut paene alienata mente deletis omnibus copiis equitatum se ex fuga recepisse dicerent neque incolumi exercitu Germanos castra oppugnaturos fuisse contenderent. Quem timorem Caesaris adventus sustulit.
[42] Reversus ille eventus belli non ignorans unum, quod cohortes ex statione et praesidio essent emissae, questus ne minimo quidem casu locum relinqui debuisse, multum fortunam in repentino hostium adventu potuisse iudicavit, multo etiam amplius, quod paene ab ipso vallo portisque castrorum barbaros avertisset. Quarum omnium rerum maxime admirandum videbatur, quod Germani, qui eo consilio Rhenum transierant, ut Ambiorigis fines depopularentur, ad castra Romanorum delati optatissimum Ambiorigi beneficium obtulerunt.
[43] Caesar rursus ad vexandos hostes profectus magno coacto numero ex finitimis civitatibus in omnes partes dimittit. Omnes vici atque omnia aedificia quae quisque conspexerat incendebantur; praeda ex omnibus locis agebatur; frumenta non solum tanta multitudine iumentorum atque hominum consumebantur, sed etiam anni tempore atque imbribus procubuerant ut, si qui etiam in praesentia se occultassent, tamen his deducto exercitu rerum omnium inopia pereundum videretur. Ac saepe in eum locum ventum est tanto in omnes partes diviso equitatu, ut modo visum ab se Ambiorigem in fuga circumspicerent captivi nec plane etiam abisse ex conspectu contenderent, ut spe consequendi illata atque infinito labore suscepto, qui se summam ab Caesare gratiam inituros putarent, paene naturam studio vincerent, semperque paulum ad summam felicitatem defuisse videretur, atque ille latebris aut saltibus se eriperet et noctu occultatus alias regiones partesque peteret non maiore equitum praesidio quam quattuor, quibus solis vitam suam committere audebat.
[44] Tali modo vastatis regionibus exercitum Caesar duarum cohortium damno Durocortorum Remorum reducit concilioque in eum locum Galliae indicto de coniuratione Senonum et Carnutum quaestionem habere instituit et de Accone, qui princeps eius consili fuerat, graviore sententia pronuntiata more maiorum supplicium sumpsit. Nonnulli iudicium veriti profugerunt. Quibus cum aqua atque igni interdixisset, duas legiones ad fines Treverorum, duas in Lingonibus, sex reliquas in Senonum finibus Agedinci in hibernis collocavit frumentoque exercitui proviso, ut instituerat, in Italiam ad conventus agendos profectus est. |
LIBRO SESTO
[1
Per molte ragioni Cesare si attendeva una più grave sollevazione della
Gallia, perciò decide di operare un reclutamento mediante i suoi legati M.
Silano, C. Antistio Regino e T. Sestio. Al tempo stesso, al proconsole Cn.
Pompeo, rimasto nelle vicinanze di Roma con un comando militare per il
bene dello stato, chiede di radunare e inviargli i soldati che aveva già
arruolato e fatto giurare nella Gallia cisalpina quand'era console. Al
fine di mantenere il buon concetto che i Galli avevano di noi, riteneva
estremamente importante, anche per il futuro, che vedessero quali erano le
risorse dell'Italia: i Romani, se anche subivano un rovescio in guerra,
erano in grado non solo di rimediare in poco tempo alle perdite, ma
addirittura di aumentare il numero degli effettivi. Pompeo, sia
nell'interesse pubblico, sia per ragioni di amicizia, acconsentì.
Completato con celerità l'arruolamento tramite i legati, prima della fine
dell'inverno vennero formate tre legioni e condotte in Gallia. Cesare
raddoppiò, così, il numero delle coorti rispetto a quelle perse con Q.
Titurio e, grazie alla rapidità e all'entità del reclutamento, dimostrò di
che cosa fossero capaci l'organizzazione e i mezzi di Roma.
[2
Dopo l'uccisione di Induziomaro, come abbiamo descritto, i Treveri
affidano il comando ai suoi parenti, che non desistono dal sobillare i
Germani limitrofi, promettendo denaro. Non avendo ottenuto risultato con i
Germani vicini, tentano con i più lontani. Trovate alcune genti disposte
all'azione, a esse si vincolano con giuramento solenne; quanto al denaro,
garantiscono con ostaggi. Accolgono nella loro lega e patto Ambiorige.
Informato di ciò, Cesare si accorse che, ovunque, erano in corso
preparativi di guerra: i Nervi, gli Atuatuci, i Menapi erano in armi,
uniti a tutti i Germani stanziati al di qua del Reno; i Senoni non
rispondevano alle convocazioni e si accordavano con i Carnuti e i popoli
limitrofi; i Treveri facevano pressione sui Germani con frequenti
ambascerie. Quindi, ritenne di dover pensare alla guerra più presto del
solito.
[3
Perciò, prima ancora della fine dell'inverno, radunò le quattro legioni
più vicine e, inatteso, puntò sui territori dei Nervi: non lasciò ai
nemici il tempo di accorrere o fuggire e, catturati molti capi di bestiame
e uomini, che concesse come preda ai soldati, devastò i campi e costrinse
i Nervi alla resa e alla consegna di ostaggi. Terminate con rapidità le
operazioni, ricondusse le legioni negli accampamenti invernali. Indetto,
secondo il solito, un concilio della Gallia per l'inizio della primavera,
si presentarono tutti, tranne i Senoni, i Carnuti e i Treveri. Cesare lo
considera segno dell'inizio delle ostilità e della ribellione e, per
dimostrare che metteva in secondo piano ogni altro problema, trasferisce
il concilio a Lutezia, città dei Parisi. Costoro confinavano con i Senoni
e a essi si erano uniti all'epoca dei nostri padri, ma non prendevano
parte, si riteneva, al piano di sollevazione. Comunicato dalla tribuna il
cambiamento di sede, il giorno stesso si dirige, con le legioni, verso le
terre dei Senoni, dove giunge a marce forzate.
[4
Saputo del suo arrivo, Accone, responsabile del piano, ordina alla
popolazione di rifugiarsi nelle città. Mentre il tentativo era in corso,
prima che le operazioni fossero ultimate, viene annunziato che i Romani
sono giunti. I Senoni sono costretti a rinunciare ai loro propositi e
inviano un'ambasceria a Cesare per scongiurarne il perdono: inoltrano la
supplica attraverso gli Edui, che da antico tempo li tutelavano. Dal
momento che la richiesta veniva dagli Edui, Cesare concede volentieri il
perdono e accetta le giustificazioni, ritenendo che quell'estate fosse la
stagione di una guerra imminente, e non dei processi. Esige cento ostaggi
e li affida alla custodia degli Edui. Anche i Carnuti gli inviano messi e
ostaggi, avvalendosi dell'intercessione dei Remi, di cui erano clienti:
ottengono la stessa risposta. Cesare chiude il concilio e impone alle
genti galliche di fornirgli cavalieri.
[5
Pacificata questa zona della Gallia, Cesare impegna mente e animo,
totalmente, nella guerra contro i Treveri e Ambiorige. Ordina a Cavarino
di assumere il comando della cavalleria dei Senoni e di seguirlo, per
evitare sedizioni dovute al carattere iracondo del Gallo oppure all'odio
che costui si era meritato da parte della sua gente. Prese tali decisioni,
Cesare, sapendo per certo che Ambiorige non si sarebbe misurato in uno
scontro aperto, cercava di scoprire quali altre soluzioni rimanessero
all'avversario. Con gli Eburoni confinavano i Menapi, protetti da
sterminate paludi e selve, l'unico popolo della Gallia a non aver mai
inviato messi a Cesare per trattare la pace. Cesare conosceva i vincoli di
ospitalità tra Ambiorige e i Menapi ed era pure al corrente che, tramite i
Treveri, il Gallo aveva stretto rapporti d'alleanza con i Germani. Stimava
necessario sottrargli ogni appoggio, piuttosto che provocarlo a battaglia:
non voleva che Ambiorige, sentendosi perduto, fosse costretto a rifugiarsi
nelle terre dei Menapi o a unirsi ai Germani d'oltre Reno. Con questa
intenzione invia a Labieno, nel paese dei Treveri, tutte le salmerie
dell'esercito e dà ordine a due legioni di raggiungerlo. Dal canto suo,
con cinque legioni senza bagagli marcia sui Menapi. Costoro, senza neppure
radunare truppe, confidando nelle sole difese naturali del luogo, si
rifugiano nelle selve e nelle paludi, ammassandovi tutti i loro beni.
[6
Cesare divide le truppe con il legato C. Fabio e il questore M. Crasso,
costruisce con rapidità ponti sulle paludi e avanza su tre fronti:
incendia gli edifici isolati e i villaggi, cattura un gran numero di capi
di bestiame e di uomini. I Menapi, nella morsa della necessità, gli
inviano ambasciatori per chiedere pace. Cesare riceve gli ostaggi e
dichiara che, se avessero accolto nei loro territori Ambiorige o suoi
emissari, li avrebbe considerati nemici. Sistemata la questione, lascia
tra i Menapi, a sorvegliare la regione, l'atrebate Commio con la
cavalleria e punta contro i Treveri.
[7
Mentre Cesare conduceva tali operazioni, i Treveri, raccolte ingenti forze
di fanteria e cavalleria, preparavano l'attacco a Labieno e alla legione
che aveva svernato nei loro territori. Non distavano, ormai, più di due
giorni di cammino da Labieno, quando vengono a sapere dell'arrivo di due
legioni, inviate da Cesare. Pongono il campo a quindici miglia dai nostri
e decidono di aspettare i rinforzi dei Germani. Labieno, conosciute le
intenzioni dei nemici, spera che la loro imprudenza gli offra l'occasione
per uno scontro: lasciate cinque coorti a presidio delle salmerie, con
venticinque coorti e una forte cavalleria si dirige contro il nemico. Alla
distanza di un miglio dai Treveri fortifica il campo. Tra Labieno e il
nemico scorreva un fiume difficile da guadare, che aveva le rive scoscese.
Né lui aveva intenzione di attraversarlo, né pensava che lo avrebbero
fatto i nemici, tra i quali ogni giorno cresceva la speranza dei rinforzi.
Al consiglio di guerra Labieno rende noto apertamente che, essendo i
Germani in arrivo, a quanto si diceva, non intendeva esporre a rischi se
stesso, né l'esercito; perciò, il giorno seguente, all'alba, avrebbe tolto
il campo. Ben presto la notizia viene riportata ai nemici: dei molti
cavalieri galli, alcuni erano spinti - com'è naturale - a favorire la
causa del loro paese. Labieno, convocati di notte i tribuni militari e i
centurioni più alti in grado, espone il suo piano e, per dare con più
facilità al nemico l'impressione di panico tra i nostri, ordina di levare
il campo con uno strepito e tumulto insoliti per l'esercito del popolo
romano. Così, rende la partenza simile a una fuga. Vicini com'erano i due
accampamenti, prima dell'alba i nemici vengono informati anche di ciò dai
loro esploratori.
[8
La retroguardia era appena uscita dalle fortificazioni, che i Galli si
spronano a vicenda a non lasciarsi sfuggire dalle mani la preda sperata:
sarebbe stato troppo lungo, con i Romani atterriti, aspettare i rinforzi
dei Germani; per la loro dignità era inammissibile, numerosi com'erano,
non osare l'attacco a un reparto nemico così esiguo e, oltretutto, in fuga
e carico di bagagli. Così, non esitano a varcare il fiume e a venire a
battaglia in posizione di svantaggio. Labieno, avendo previsto ogni mossa,
allo scopo di attirare tutti i nemici al di qua del fiume continuava nella
sua finzione e proseguiva la marcia, lentamente. Poi, inviate le salmerie
un po' più avanti e avendole disposte su di un rialzo, disse: "Soldati,
avete l'occasione che vi auguravate: tenete in pugno il nemico, in un
luogo malagevole e per loro svantaggioso; date prova, adesso, sotto la
nostra guida, dello stesso valore che più di una volta avete dimostrato al
comandante in capo, fate conto che lui sia qui e che assista allo scontro
di persona". Contemporaneamente ordina di volgere le insegne contro il
nemico e di formare la linea di battaglia, invia pochi squadroni a
presidio delle salmerie e dispone il resto della cavalleria sulle ali. I
nostri rapidamente, tra alte grida, scagliano i giavellotti sui nemici.
Costoro, quando contro ogni aspettativa videro i Romani volgere le insegne
e avanzare, mentre li credevano già in fuga, non riuscirono neanche a
sostenerne l'urto: al primo assalto batterono in ritirata e cercarono
rifugio nelle selve più vicine. Labieno li inseguì con la cavalleria, ne
uccise molti e ne fece prigionieri parecchi: pochi giorni dopo i Treveri
si arresero. Infatti, i Germani, che venivano in loro aiuto, avuta notizia
della fuga dei Treveri, rientrarono in patria. Al loro seguito lasciarono
il paese i parenti di Induziomaro, che avevano istigato alla defezione. A
Cingetorige, rimasto fedele fin dall'inizio, come abbiamo ricordato, fu
conferito il principato e il comando.
[9
Cesare, appena giunto dalle terre dei Menapi nella regione dei Treveri,
decise di varcare il Reno per due motivi: primo, i Germani avevano mandato
aiuti ai Treveri contro di lui; secondo, non voleva che Ambiorige trovasse
rifugio presso di loro. Presa tale decisione, comincia a costruire un
ponte poco più a nord del luogo in cui, in passato, l'esercito aveva
varcato il fiume. Essendo la maniera di fabbricarlo già nota e
sperimentata, l'opera viene realizzata in pochi giorni grazie al grande
impegno dei soldati. A un capo del ponte, nelle terre dei Treveri, per
impedirne un'improvvisa sollevazione, lascia un saldo presidio e guida,
sull'altra riva, il resto delle truppe e la cavalleria. Gli Ubi, che in
precedenza avevano consegnato ostaggi e si erano sottomessi, inviano a
Cesare un'ambasceria per discolparsi: non avevano inviato rinforzi ai
Treveri, né violato i patti. Gli chiedono, lo scongiurano di risparmiarli,
di non accomunarli ai Germani nel suo odio, perché non volevano,
innocenti, pagare per chi innocente non era; se chiedeva altri ostaggi,
erano pronti a consegnarli. Cesare, fatta luce sull'accaduto, scopre che i
rinforzi erano stati inviati dagli Svevi. Accetta le spiegazioni degli
Ubi, si informa in modo dettagliato sulle vie d'accesso alle terre degli
Svevi.
[10
Intanto, pochi giorni dopo, gli Ubi lo avvertono che gli Svevi stavano
concentrando tutte le truppe in un solo luogo e che imponevano ai popoli
sottomessi l'invio di rinforzi di fanteria e cavalleria. Saputo ciò,
Cesare provvede alle scorte di grano, sceglie un luogo adatto
all'accampamento e ordina agli Ubi di portar via i capi di bestiame e di
ammassare ogni bene dalle campagne nelle città. Sperava che i nemici,
barbari e inesperti com'erano, si lasciassero indurre ad accettare lo
scontro anche in posizione di svantaggio, costretti a ciò dalla mancanza
di viveri. Incarica gli Ubi di inviare molti esploratori nelle zone degli
Svevi per spiarne le mosse. Gli Ubi eseguono gli ordini e, pochi giorni
dopo, riferiscono: tutti gli Svevi, avute notizie più sicure sull'esercito
dei Romani, si erano ritirati lontano, nei loro territori più remoti, con
tutte le truppe e i contingenti alleati da essi raccolti; lì si trovava
una foresta sterminata, di nome Bacenis, che si estendeva profonda verso
l'interno e formava una sorta di barriera naturale tra i Cherusci e gli
Svevi, impedendo agli uni e agli altri violenze e incursioni: sul limitare
della foresta gli Svevi avevano deciso di attendere l'arrivo dei Romani.
[11
Giunti a questo punto, non ci sembra fuori luogo esporre i costumi della
Gallia e della Germania e le differenze tra le due nazioni. In Gallia non
solo tutti i popoli, le tribù e i gruppi, ma addirittura quasi tutte le
famiglie sono divise in fazioni. A capo di esse sta chi, secondo
l'opinione dei Galli, è considerato più autorevole, ed egli è arbitro e
giudice in tutti gli affari e le deliberazioni. A quanto pare,
l'istituzione risaliva a tempi antichi, al fine di garantire alla gente
del popolo sostegno contro i più potenti. Infatti, il capo di ogni fazione
non permette che la sua gente subisca violenze o raggiri; in caso
contrario, tra i suoi perde ogni autorità. Lo stesso sistema regola ogni
aspetto della vita in Gallia, tant'è vero che tutti i popoli sono divisi
in due fazioni.
[12
Al momento dell'arrivo di Cesare in Gallia, una fazione faceva capo agli
Edui, l'altra ai Sequani. Quest'ultimi, di per sé meno influenti - fin dai
tempi antichi la massima autorità era nelle mani degli Edui, che avevano
molti clienti - si erano uniti ai Germani e ad Ariovisto, attirandoli con
grandi elargizioni e promesse. Riportati diversi successi in battaglia ed
eliminati tutti i nobili edui, i Sequani avevano superato in potenza gli
Edui stessi, al punto da sottrarre loro la maggior parte dei popoli
soggetti, da costringerli a dare in ostaggio i figli dei capi e a giurare
pubblicamente di non intraprendere nulla contro di loro; inoltre, si erano
impadroniti, con le armi, di una parte del territorio eduo contiguo al
loro e avevano ottenuto la supremazia su tutta la Gallia. Diviziaco,
spinto dalla necessità, si era recato a Roma, dal senato, per chiedere
aiuto, ma era ritornato con un nulla di fatto. L'arrivo di Cesare aveva
prodotto un vero e proprio capovolgimento: gli Edui si erano visti rendere
gli ostaggi, avevano recuperato i vecchi clienti, ne avevano acquisito di
nuovi, grazie a Cesare, perché i popoli che si ponevano sotto la loro
tutela si accorgevano di ricevere un trattamento migliore e di sottostare
a un dominio più equo. Quanto al resto, il prestigio e la dignità degli
Edui erano cresciuti, i Sequani avevano perso l'egemonia. Al loro posto
erano subentrati i Remi. Il favore di Cesare per gli Edui e i Remi era
identico, lo si capiva, perciò i popoli che, per antiche inimicizie, non
potevano assolutamente legarsi ai primi, si facevano clienti dei secondi,
che li proteggevano con ogni cura, mantenendo, in tal modo, un prestigio
nuovo e assunto di colpo. Quindi, al momento, la situazione era la
seguente: gli Edui erano considerati i primi in assoluto, i Remi
occupavano, in dignità, il secondo posto.
[13
In tutta la Gallia ci sono due classi di persone tenute in un certo conto
e riguardo. La gente del popolo, infatti, è considerata quasi alla stregua
dei servi, non prende iniziative e non viene ammessa alle assemblee. I
più, oberati dai debiti, dai tributi gravosi o dai soprusi dei potenti, si
mettono al servizio dei nobili, che su di essi godono degli stessi diritti
che hanno i padroni sugli schiavi. Delle due classi, dunque, la prima
comprende i druidi, l'altra i cavalieri. I druidi si occupano delle
cerimonie religiose, provvedono ai sacrifici pubblici e privati, regolano
le pratiche del culto. Moltissimi giovani accorrono a istruirsi dai
druidi, che tra i Galli godono di grande onore. Infatti, risolvono quasi
tutte le controversie pubbliche e private e, se è stato commesso un reato,
se c'è stato un omicidio, oppure se sorgono problemi d'eredità o di
confine, sono sempre loro a giudicare, fissando risarcimenti e pene. Se
qualcuno - si tratti di un privato cittadino o di un popolo - non si
attiene alle loro decisioni, gli interdicono i sacrifici. È la pena più
grave tra i Galli. Chi ne è stato colpito, viene considerato un empio, un
criminale: tutti si scostano alla sua vista, lo evitano e non gli
rivolgono la parola, per non contrarre qualche sciagura dal suo contatto;
non è ammesso a chiedere giustizia, né può essere partecipe di qualche
carica. Tutti i druidi hanno un unico capo, che gode della massima
autorità. Alla sua morte, ne prende il posto chi preceda gli altri druidi
in prestigio, oppure, se sono in parecchi ad avere uguali meriti, la
scelta è lasciata ai voti dei druidi, ma talvolta si contendono la carica
addirittura con le armi. In un determinato periodo dell'anno si radunano
in un luogo consacrato, nella regione dei Carnuti, ritenuta al centro di
tutta la Gallia. Chi ha delle controversie, da ogni regione qui si reca e
si attiene alla decisione e al verdetto dei druidi. Si crede che la loro
dottrina sia nata in Britannia e che, da lì, sia passata in Gallia: ancor
oggi, chi intende approfondirla, in genere si reca sull'isola per
istruirsi.
[14
I druidi, di solito, non prendono parte alle guerre e non pagano tributi
come gli altri, sono esentati dal servizio militare e dispensati da ogni
altro onere. Con la prospettiva di così grandi privilegi, molti giovani si
accostano spontaneamente a questa dottrina, molti altri vengono inviati
dai loro genitori e parenti ad apprenderla. Presso i druidi, a quanto si
dice, imparano a memoria un gran numero di versi. E alcuni proseguono gli
studi per oltre vent'anni. Non ritengono lecito affidare i loro
insegnamenti alla scrittura, mentre per quasi tutto il resto, per gli
affari pubblici e privati, usano l'alfabeto greco. A mio parere, hanno
stabilito così per due motivi: non vogliono che la loro dottrina venga
divulgata tra il popolo, e neppure che i discepoli, fidando nella
scrittura, esercitino la memoria con più scarso impegno, come accade quasi
a tutti, che, valendosi dello scritto, si applicano meno nello studio e
trascurano la memoria. Il loro principale insegnamento riguarda
l'immortalità dell'anima, che dopo la morte - sostengono - passa da un
corpo ad un altro. Lo ritengono un grandissimo incentivo al coraggio,
poiché viene eliminata la paura di morire. Inoltre, sulle stelle e il loro
moto, sulla dimensione del cielo e della terra, sulla natura, sulla
potenza e la potestà degli dèi immortali discutono molto e tramandano
questo patrimonio ai giovani.
[15
L'altra è la classe dei cavalieri. Quando ce n'è bisogno scoppia qualche
guerra (prima dell'arrivo di Cesare quasi ogni anno se ne verificavano,
sia che fossero i Galli ad attaccare, sia che dovessero difendersi), i
cavalieri partecipano al completo alle operazioni militari. Quanto più uno
è influente per nascita e mezzi, tanto più si circonda di ambacti e di
clienti: è l'unica forma di prestigio e di potere che conoscano.
[16
Il popolo dei Galli, nel suo complesso, è oltremodo religioso. Per tale
motivo, chi è afflitto da malattie di una certa gravità e chi rischia la
vita in battaglia o è esposto ai pericoli, immola o fa voto di immolare
vittime umane e si vale dei druidi come ministri dei sacrifici. Ritengono,
infatti, che gli dèi immortali non possano venir placati, se non si offre
la vita di un uomo in cambio della vita di un altro uomo. Celebrano anche
istituzionalmente sacrifici di tal genere. Alcuni popoli hanno figure
umane di enormi dimensioni, di vimini intrecciati, che vengono riempite di
uomini ancor vivi: si appicca il fuoco e le persone prigioniere lì dentro,
avvolte dalle fiamme, muoiono. Credono che agli dèi immortali sia più
gradito, tra tutti, il supplizio di chi è stato sorpreso a commettere
furti, ladrocini o altri delitti, ma quando mancano vittime di questo
tipo, si risolvono anche a suppliziare chi è innocente.
[17
Il dio più venerato è Mercurio: ne hanno moltissimi simulacri. Lo
ritengono inventore di tutte le arti, guida delle vie e dei viaggi,
credono che, più di ogni altro, abbia il potere di favorire i guadagni e i
commerci. Dopo di lui adorano Apollo, Marte, Giove e Minerva. Su tutti
questi dèi la pensano, all'incirca, come le altre genti: Apollo guarisce
le malattie, Minerva insegna i principi dei lavori manuali, Giove è il re
degli dèi, Marte governa le guerre. A quest'ultimo, in genere, quando
decidono di combattere, offrono in voto il bottino di guerra: in caso di
vittoria, immolano gli animali catturati e ammassano il resto in un unico
luogo. Nei territori di molti popoli è possibile vedere, in zone
consacrate, tumuli costruiti con tali spoglie. E ben di rado accade che
uno, sfidando il voto religioso, osi nascondere a casa sua il bottino o
sottrarre qualcosa dai tumuli: per una colpa del genere è prevista una
morte terribile tra le torture.
[18
I Galli affermano di discendere tutti dal padre Dite e dicono che siano i
druidi a tramandarlo. Per tale motivo calcolano il tempo non sulla base
dei giorni, ma delle notti. E anche i compleanni e i primi giorni del mese
e dell'anno li osservano a partire dalla notte fino al giorno successivo.
Per quanto riguarda gli altri usi quotidiani differiscono dai rimanenti
popoli quasi solo per il seguente aspetto: non permettono che i figli li
avvicinino davanti a tutti, se non quando, cresciuti, sono ormai in grado
di prestare servizio militare, e considerano una vergogna che un figlio,
in giovane età, si presenti davanti al padre in pubblico.
[19
Gli uomini, fatta la stima della dote portata dalle mogli, mettono in
comune, dal loro patrimonio, l'equivalente dei beni ricevuti. Si fa un
computo unico della somma e se ne conservano gli interessi: chi dei due
sopravvive all'altro, entra in possesso dei beni di entrambi con i frutti
degli anni precedenti. Gli uomini hanno diritto di vita e di morte sulle
mogli come sui figli. Quando muore un capofamiglia di un certo riguardo, i
parenti si riuniscono e, se nasce qualche sospetto sulla sua morte,
interrogano le mogli come si fa con i servi: se risultano colpevoli, le
uccidono dopo averle torturate col fuoco e supplizi d'ogni sorta. I
funerali sono, in rapporto alla civiltà dei Galli, magnifici e sontuosi;
depongono sulla pira ogni cosa cara in vita al defunto, anche gli animali.
E fino a poco tempo fa, insieme al morto, venivano cremati, con le dovute
esequie, i servi e i clienti che si sapevano da lui prediletti.
[20
Presso i popoli che, secondo l'opinione comune, sono meglio organizzati,
la legge prescrive che se uno sente, dalle genti limitrofe, voci o notizie
riguardanti lo stato, deve informare il magistrato senza farne cenno ad
altri, perché spesso, si sa, gli uomini avventati e inesperti si lasciano
atterrire dalle false notizie, sono spinti a commettere delitti e prendono
decisioni sui problemi più importanti. I magistrati tengono segreto ciò
che sembra loro opportuno e divulgano le altre notizie considerate utili.
Non è permesso trattare questioni di stato se non nelle assemblee.
[21
I Germani hanno consuetudini molto diverse. Infatti, non hanno druidi che
presiedano alle cerimonie religiose, né si occupano di sacrifici.
Considerano dèi solo quelli che vedono e dal cui aiuto traggono giovamento
palese: il Sole, Vulcano, la Luna. Degli altri dèi non hanno neanche
sentito parlare. Passano tutta la vita tra cacce e addestramento alla
guerra: fin dall'infanzia si abituano alla fatica e alla vita dura. Quanto
più a lungo un giovane rimane casto, tanto più riceve le lodi della sua
gente: ritengono che ciò aumenti la statura, accresca la robustezza fisica
e il vigore. E stimano tra le cose più vergognose aver rapporti intimi con
una donna prima dei vent'anni; ma il sesso non viene nascosto, in quanto
maschi e femmine si lavano insieme nei fiumi, indossano pelli o giubbotti
di pelliccia che lasciano scoperta gran parte del corpo.
[22
Non praticano l'agricoltura, il loro vitto consiste, per la maggior parte,
di latte, formaggio e carne. Nessuno ha in proprio un terreno fisso o un
possesso personale. Anzi, alle genti e ai nuclei familiari in cui i
parenti convivono, i magistrati e i capi attribuiscono, di anno in anno,
la quantità di terra e la zona ritenute giuste, ma l'anno successivo li
costringono a spostarsi altrove. Forniscono, in merito, molteplici
spiegazioni. Non vogliono che la gente, vinta da una costante abitudine,
sostituisca la guerra con l'agricoltura, che desideri procurarsi
appezzamenti più estesi e che i più potenti scaccino dai loro campi i meno
forti. Non vogliono che vengano costruite case confortevoli per difendersi
dal freddo e dal caldo, che nasca la brama di denaro, fonte di fazioni e
dissensi, cercano di tenere a bada il popolo con la serenità d'animo,
quando ciascuno si renda conto di possedere quanto i più potenti.
[23
Il vanto maggiore per le loro genti è, devastate le zone di confine, di
avere intorno a sé dei deserti, nel raggio più ampio. Ritengono segno
distintivo del valore se i vicini, scacciati dai loro territori, si
ritirano e nessuno osa stabilirsi nei pressi. Al contempo, si sentono più
al sicuro, eliminato il timore di un'incursione improvvisa. Quando un
popolo entra in guerra, per difendersi o attaccare, vengono scelti dei
magistrati per guidarli, ed essi hanno potere di vita e di morte. In tempo
di pace non ci sono magistrati comuni, ma i capi delle varie regioni e
tribù, al loro interno, amministrano la giustizia e appianano le
controversie. Il ladrocinio non comporta disonore, se commesso fuori dei
territori di ciascun popolo, anzi, lo consigliano per esercitare i giovani
e diminuire l'inerzia. E quando, durante l'assemblea, uno dei capi si
dichiara pronto a guidare una spedizione e chiede ai volontari di farsi
avanti, chi è favorevole all'impresa e all'uomo si alza e promette il
proprio sostegno, tra le lodi generali; chi, invece, non si unisce alla
spedizione, viene considerato nel novero dei disertori e dei traditori, e
in futuro gli viene negata fiducia in ogni campo. Considerano sacrilegio
recare offesa a un ospite: chiunque, per qualsiasi motivo, giunga da loro,
viene protetto da ogni torto e considerato sacro, gli sono aperte le porte
di tutte le case e con lui viene diviso il cibo.
[24
Ci fu, in passato, un tempo in cui i Galli erano più forti dei Germani, li
attaccavano e, avendo una popolazione numerosa e pochi campi, inviavano
colonie oltre il Reno. Perciò, le zone della Germania più fertili attorno
alla selva Ercinia - nota, a quanto vedo, a Eratostene e ad altri Greci,
che però la chiamano Orcinia - le occuparono i Volci Tectosagi,
insediandosi lì. Essi abitano ancor oggi la regione e godono di
straordinaria fama quanto a giustizia e valor militare. Ma mentre i
Germani mantengono sempre le stesse condizioni di povertà, stenti e
sopportazione, senza aver in nulla mutato il nutrimento e il tenore di
vita, i Galli, invece, dalla vicinanza con le nostre province e dal
commercio marittimo hanno tratto molte ricchezze e vantaggi. Così, si sono
gradualmente abituati alla sconfitta e, vinti in molte battaglie, non
osano più neppure paragonarsi ai Germani per valore.
[25
La selva Ercinia, sopra menzionata, si estende per una larghezza
equivalente a nove giorni di marcia per chi viaggi libero da impedimenti:
non è possibile, infatti, determinare in altro modo le sue dimensioni,
perché i Germani non conoscono le misure itinerarie. Ha inizio nei
territori degli Elvezi, dei Nemeti e dei Rauraci e, in parallelo con il
corso del Danubio, raggiunge il paese dei Daci e degli Anarti; da qui,
piega a sinistra, in regioni lontane dal fiume e, nella sua vastità, tocca
le terre di molti popoli. Non c'è nessuno, in questa zona della Germania,
che possa affermare di aver raggiunto l'inizio della selva, benché si sia
spinto in avanti per sessanta giorni di cammino, o che abbia sentito dire
dove ha principio. Vi nascono, a quanto consta, molte specie di animali
mai visti altrove: di essi descriveremo i più strani e singolari e più
degni, a nostro parere, di menzione.
[26
C'è un bue, dalla forma di cervo, che in mezzo alla fronte, tra le
orecchie, ha un corno unico, più alto e più dritto di quelli a noi noti:
sulla sommità, il corno si divide in ampie diramazioni. Uguale è l'aspetto
della femmina e del maschio, con corna di identica forma e grandezza.
[27
Ci sono, altresì, le cosiddette alci. Per forma e varietà delle pelli
assomigliano alle capre, ma sono un po' più grosse, hanno le corna senza
punta e le zampe senza giunture, per cui né si sdraiano per riposarsi, né,
se per qualche motivo cadono a terra, sono in grado di rialzarsi o
risollevarsi. Come giacigli usano gli alberi: vi si appoggiano e così,
leggermente reclinate, si addormentano. Quando i cacciatori, dalle orme,
scoprono il rifugio delle alci, scalzano o tagliano alla base tutti gli
alberi del luogo, stando attenti che rimanga nell'insieme l'aspetto di
alberi ritti. Quando le alci, come al solito, vi si appoggiano, con il
loro peso provocano il crollo degli alberi, già malfermi, e cadono
anch'esse per terra.
[28
La terza è la specie dei cosiddetti uri. Sono leggermente più piccoli
degli elefanti, assomigliano ai tori per aspetto, colore e forma. Sono
molto forti, estremamente veloci, non risparmiano né uomini, né animali
che abbiano scorto. I Germani si danno molto da fare per catturarli per
mezzo di fosse, e poi li uccidono: i giovani si temprano e si esercitano
in queste fatiche e genere di cacce. Chi ha ucciso diversi uri, ne espone
le corna pubblicamente, a testimonianza della sua impresa, ricevendo
grandi elogi. Non si riesce ad abituare gli uri alla presenza degli
uomini, né ad addomesticarli, neppure se catturati da piccoli. Le corna,
per ampiezza, forma e aspetto, sono molto diverse da quelle dei nostri
buoi. Sono un pezzo molto ricercato, le guarniscono d'argento negli orli e
le usano come coppe nei banchetti più sontuosi.
[29
Cesare, quando dagli esploratori degli Ubi apprende che gli Svevi si erano
rifugiati nelle selve, decide di non avanzare ulteriormente, temendo che
gli venisse a mancare il grano, visto che tutti i Germani, come abbiamo
ricordato prima, non praticano affatto l'agricoltura. Ma per tener desto
nei barbari il timore di un suo possibile ritorno e per rallentare la
marcia dei loro rinforzi, ritira l'esercito e, per duecento piedi di
lunghezza, distrugge la testa del ponte sulla sponda degli Ubi.
All'estremità del ponte, costruisce una torre di quattro piani, lasciando
a difesa del medesimo una guarnigione di dodici coorti e munendo il luogo
con salde fortificazioni. Assegna il comando della zona e della
guarnigione al giovane C. Volcacio Tullo. Cesare, invece, non appena il
grano cominciava a maturare, partì per muovere guerra ad Ambiorige,
attraverso la selva delle Ardenne, la più estesa di tutta la Gallia: dalle
rive del Reno e dalle terre dei Treveri giunge fino alla regione dei
Nervi, per oltre cinquecento miglia di lunghezza. Manda in avanscoperta L.
Minucio Basilo alla testa di tutta la cavalleria, perché traesse vantaggio
dalla rapidità della marcia e dalle occasioni favorevoli. Lo ammonisce a
vietare i fuochi nell'accampamento, perché da lontano non si scorgessero
indizi del suo arrivo, e gli garantisce che si sarebbe spinto subito
dietro di lui.
[30
Basilo si attiene agli ordini. Coperta la distanza rapidamente e mentre
nessuno se lo aspettava, coglie di sorpresa molti nemici ancora nei campi.
Grazie alle loro indicazioni, punta su Ambiorige stesso, dirigendosi nel
luogo in cui si trovava - così dicevano - con pochi cavalieri. La Fortuna
ha un gran peso in tutto, specie nelle operazioni militari. Infatti, se
per un caso davvero propizio Basilo poté piombare su Ambiorige stesso
cogliendolo alla sprovvista e impreparato (videro di persona l'arrivo del
Romano prima che ne giungesse voce o notizia), d'altro canto fu una vera
combinazione se il Gallo riuscì a sottrarsi alla morte, pur perdendo tutto
il suo equipaggiamento militare, i carri e i cavalli. Ed ecco come andò:
la sua casa era circondata da un bosco, come spesso le abitazioni dei
Galli, che, per evitare il caldo, in genere cercano luoghi vicini a fiumi
o selve. Così, i suoi compagni e servi, in una stretta zona d'accesso,
ressero per un po' al nostro assalto. Mentre essi combattevano, uno dei
suoi lo fece salire a cavallo: le selve ne protessero la fuga. Così, la
Fortuna ebbe un ruolo determinante prima nel metterlo in pericolo, poi nel
salvarlo.
[31
Non è chiaro se Ambiorige non avesse raccolto le sue truppe di proposito,
non ritenendo opportuno uno scontro aperto, oppure se gli fosse mancato il
tempo e glielo avesse impedito l'arrivo improvviso della cavalleria, che
credeva seguita dal resto dell'esercito. L'unica cosa certa è che inviò
messi nelle campagne con l'ordine di pensare ciascuno per sé. Alcuni dei
suoi si rifugiarono nella selva delle Ardenne, altri nelle paludi
interminabili. Chi viveva nei pressi dell'Oceano riparò nelle isole che le
maree sono solite formare. Molti, poi, abbandonati i propri territori,
affidarono se stessi, con ogni avere, a genti del tutto estranee.
Catuvolco, re di una metà degli Eburoni, che aveva assunto l'iniziativa
insieme ad Ambiorige, era ormai sfinito dagli anni e non poteva reggere le
fatiche di una guerra o di una fuga. Perciò, dopo aver maledetto con ogni
sorta d'imprecazioni Ambiorige, l'ideatore del piano, si tolse la vita con
il tasso, una pianta molto diffusa in Gallia e in Germania.
[32
I Segni e i Condrusi, popoli di stirpe germanica e tali ritenuti, che
abitano tra gli Eburoni e i Treveri, mandarono a Cesare un'ambasceria per
pregarlo di non considerarli nemici e di non credere che tutti i Germani
stanziati al di qua del Reno avessero fatto causa comune: essi non avevano
pensato alla guerra, né inviato ad Ambiorige rinforzi. Cesare, accertato
come stavano le cose interrogando i prigionieri, comandò ai Segni e ai
Condrusi di ricondurgli eventuali fuggiaschi degli Eburoni giunti nelle
loro terre; se avessero eseguito l'ordine, non avrebbe violato i loro
territori. Quindi, divise in tre corpi le sue truppe e ammassò le salmerie
di tutte le legioni ad Atuatuca. È il nome di una fortezza che si trova
circa al centro dei territori degli Eburoni, dove Titurio e Aurunculeio
avevano posto i quartieri d'inverno. Tra gli altri motivi, Cesare
approvava la scelta del luogo soprattutto perché erano ancora intatte le
fortificazioni dell'anno precedente, così avrebbe risparmiato fatica ai
soldati. A presidio delle salmerie lasciò la quattordicesima legione, una
delle tre che, arruolate di recente, aveva condotto dall'Italia. Affidò il
comando della legione e del campo a Q. Tullio Cicerone, assegnandogli
duecento cavalieri.
[33
Suddiviso l'esercito, ordina a T. Labieno di partire con tre legioni verso
l'Oceano, puntando sulle terre al confine con i Menapi. Alla testa di
altrettante legioni invia C. Trebonio a devastare i territori contigui
agli Atuatuci. E lui stesso decide di muoversi, con le tre restanti
legioni, in direzione della Schelda, un fiume che si getta nella Mosa, e
verso le parti più lontane delle Ardenne, dove, stando alle voci, era
riparato Ambiorige con pochi cavalieri. Al momento della partenza,
assicura che sarebbe rientrato di lì a sette giorni, data stabilita per
distribuire il grano alla legione di presidio in Atuatuca. Invita Labieno
e Trebonio, se ciò non nuoceva agli interessi di stato, a rientrare lo
stesso giorno: tenuto ancora consiglio e analizzate le intenzioni del
nemico, avrebbero potuto riprendere, su nuove basi, le ostilità.
[34
I nemici, come abbiamo detto in precedenza, non avevano un esercito
regolare, una fortezza, un presidio che si difendesse con le armi: erano
una massa di uomini sparsi ovunque. Ciascuno si era appostato dove una
valle nascosta, una zona boscosa, una palude impraticabile offriva una
qualche speranza di difesa o di salvezza. Erano luoghi ben noti agli
abitanti della zona, e la situazione richiedeva la massima prudenza, non
tanto per proteggere il grosso dell'esercito (nessun pericolo, infatti,
poteva nascere, per le nostre truppe riunite, da nemici atterriti e
sparpagliati), quanto per tutelare i singoli legionari, cosa che comunque,
in parte, riguardava la sicurezza di tutto l'esercito. Infatti, l'avidità
di bottino spingeva molti ad allontanarsi troppo, e le selve, dai sentieri
malsicuri e poco visibili, impedivano ai nostri la marcia in gruppo. Se si
voleva portare a termine l'operazione e annientare quella stirpe di
canaglie, era necessario distaccare diversi gruppi in varie direzioni e
dividere i soldati; se, invece, si sceglieva di tenere i manipoli sotto le
insegne, come richiesto dalla regola e dall'uso dell'esercito romano, la
zona stessa avrebbe protetto i barbari, ai quali non mancava l'audacia,
per quanto isolati, di tendere imboscate e di circondare i nostri che si
fossero disuniti. Così, di fronte a tali difficoltà, si provvide con tutta
l'attenzione possibile: si rinunciò perfino a qualche occasione di nuocere
al nemico, sebbene tutti bruciassero dal desiderio di vendetta, piuttosto
che farlo a prezzo di nostre perdite. Cesare invia messi ai popoli
confinanti, li fa venire presso di sé e li spinge, con la speranza di
bottino, a saccheggiare le terre degli Eburoni: voleva che fossero i
Galli, non i legionari, a rischiare la vita nelle selve e che, al tempo
stesso, in seguito all'affluire di una simile massa, venissero annientati,
come prezzo per la loro colpa, gli Eburoni, nome e stirpe. Da ogni regione
accorre ben presto una gran folla.
[35
Ecco cosa succedeva in ogni parte del territorio degli Eburoni, e intanto
si avvicinava il settimo giorno, fissato da Cesare per il suo ritorno alle
salmerie e alla legione di presidio. In questa circostanza si poté
constatare il peso della Fortuna in guerra e quali inattesi eventi essa
produca. I nemici erano dispersi e atterriti, lo abbiamo visto; non vi
erano truppe in grado di dare il benché minimo motivo di preoccupazione.
Ai Germani, al di là del Reno, giunge voce che le terre degli Eburoni
venivano saccheggiate e che, anzi, tutti erano chiamati a far bottino. I
Sigambri, popolo vicino al Reno, che avevano accolto - lo abbiamo riferito
in precedenza - i Tenteri e gli Usipeti in fuga, radunano duemila
cavalieri. Passano il Reno su imbarcazioni e zattere, trenta miglia più a
sud del punto in cui era stato costruito il ponte e dove Cesare aveva
lasciato il presidio. Varcano la frontiera degli Eburoni, raccolgono molti
sbandati, si impossessano di una gran quantità di capi di bestiame, preda
ambitissima dai barbari. Attratti dal bottino, avanzano. Né la palude, né
le selve frenano questi uomini nati tra guerre e saccheggi. Ai prigionieri
chiedono dove sia Cesare; scoprono, così, che si è molto allontanato e che
tutto l'esercito è partito. Allora uno dei prigionieri "Ma perché - dice -
vi accanite dietro a questa preda misera e meschina, quando potreste
essere già ricchissimi? Atuatuca è raggiungibile in tre ore di marcia: lì
l'esercito romano ha ammassato tutti i propri averi. I difensori non
bastano neppure a coprire il muro di cinta e nessuno osa uscire dalle
fortificazioni". Di fronte a una tale occasione, i Germani nascondono la
preda già conquistata e puntano su Atuatuca, sotto la guida dell'uomo che
li aveva informati.
[36
Cicerone, in tutti i giorni precedenti, secondo le disposizioni di Cesare,
aveva trattenuto con molto scrupolo i soldati nell'accampamento, senza
permettere che neppure un calone uscisse dalle fortificazioni. Ma il
settimo giorno, non avendo fiducia che Cesare sarebbe stato puntuale come
aveva promesso (giungevano, infatti, voci che si era spinto ancor più
lontano e non si avevano notizie sul suo ritorno) e turbato, al tempo
stesso, dalle critiche di chi definiva la sua pazienza una sorta di
assedio, in quanto a nessuno era concesso di uscire dal campo, stima che,
nel raggio di tre miglia, i suoi non avrebbero corso alcun pericolo: il
nemico, già sbandato e pressoché distrutto, aveva di fronte nove legioni e
una fortissima cavalleria. Così, invia cinque coorti a far provvista di
grano nei campi più vicini, che un unico colle separava dall'accampamento.
Con Cicerone erano rimasti, dalle varie legioni, parecchi malati; i
soldati guariti in quell'arco di tempo, circa trecento, formano un
distaccamento e vengono mandati con gli altri. E, poi, ottenuto il
permesso, li seguono anche molti caloni con un gran numero di bestie da
soma, che erano rimaste al campo.
[37
Proprio in questo momento e frangente sopraggiungono i cavalieri germani,
che, proseguendo senza rallentare l'andatura, tentano un'irruzione dalla
porta decumana. Essendo coperti, su quel lato, dalle selve, vengono scorti
solo quando erano ormai nei pressi del campo, al punto che i mercanti,
attendati ai piedi del vallo, non hanno neppure modo di rifugiarsi
all'interno. I nostri, colti alla sprovvista, rimangono scossi dall'evento
inatteso, e la coorte di guardia riesce a respingere a malapena il primo
assalto. I Germani si spargono tutt'intorno, nella speranza di trovare un
adito. I nostri difendono a stento le porte, per il resto l'accesso era
impedito solo dalla posizione naturale e dalle fortificazioni. In tutto il
campo regna la confusione, ci si domanda l'un l'altro la causa del
tumulto: non si pensa a disporre le insegne, né a indicare dove ciascuno
debba radunarsi. Chi sostiene che il campo è già caduto, chi afferma che i
barbari sono giunti vittoriosi, dopo aver annientato il nostro esercito e
ucciso il comandante. La maggior parte si inventa nuove superstizioni
sulla base del luogo, rievocando il massacro di Cotta e Titurio, avvenuto
proprio lì. Poiché tutti erano terrorizzati da tali paure, i barbari si
rafforzano nell'idea che, come aveva detto il prigioniero, all'interno non
c'era alcuna guarnigione. Cercano di sfondare e si spronano a vicenda a
non lasciarsi sfuggire dalle mani un'occasione così splendida.
[38
Al campo, con la legione di presidio, era rimasto, malato, P. Sestio
Baculo, che sotto Cesare aveva rivestito la carica di centurione primipilo
e di cui abbiamo parlato nelle battaglie precedenti: già da cinque giorni
non toccava cibo. Disperando della salvezza sua e di tutti, esce disarmato
dalla tenda. Vede che i nemici incombevano e che il momento era molto
critico: si fa consegnare le armi dai soldati più vicini e si piazza sulla
porta. A lui si uniscono i centurioni della coorte di guardia; per un po'
reggono agli assalti, insieme. Poi Sestio, gravemente ferito, sviene: lo
traggono in salvo a stento, passandolo di braccia in braccia. Ma nel
frattempo gli altri si rinfrancano, tanto che osano attestarsi sui
baluardi e danno l'impressione di una vera guarnigione.
[39
In quel mentre, i nostri, terminata la raccolta di grano, odono i clamori:
i cavalieri accorrono, si rendono conto della gravità della situazione. Ma
qui non c'era nessun riparo che potesse accogliere gente in preda al
panico: soldati appena arruolati e privi di esperienza militare, rivolgono
gli occhi al tribuno e ai centurioni, aspettano i loro ordini. Ma anche i
migliori erano sconvolti dagli eventi inattesi. I barbari, scorgendo in
lontananza le insegne, cessano l'assedio: dapprima pensano al rientro
delle legioni che, su informazione dei prigionieri, sapevano lontane; poi,
disprezzando lo scarso numero dei nostri, li attaccano da ogni lato.
[40
I caloni corrono sul rialzo più vicino. Ben presto scacciati, si
precipitano tra le insegne e i manipoli, seminando ancor più scompiglio
tra i legionari impauriti. Dei nostri c'era chi consigliava di formare un
cuneo per aprirsi rapidamente un varco, data la vicinanza del campo: anche
se qualcuno, accerchiato, soccombeva, certo gli altri sarebbero riusciti a
mettersi in salvo. E chi, invece, era dell'avviso di attestarsi sul colle
e di affrontare tutti lo stesso destino. I veterani - abbiamo detto che si
erano aggregati come distaccamento - non approvano quest'ultima soluzione.
Così, si incoraggiano a vicenda e, sotto la guida di C. Trebonio,
cavaliere romano, loro comandante, forzano al centro la linea nemica e,
sani e salvi dal primo all'ultimo, raggiungono tutti l'accampamento. Alle
loro spalle si lanciano nello stesso attacco i caloni e i cavalieri e
vengono salvati dal valore dei veterani. Gli altri, invece, rimasti in
cima al colle, soldati ancora privi di qualsiasi esperienza militare, non
seppero attenersi alla decisione da loro stessi approvata, cioè di
difendersi dall'alto del colle, né imitare la forza e la rapidità che
avevano visto procurare ai loro compagni la salvezza, ma, nel tentativo di
ripiegare verso il campo, scesero su un terreno sfavorevole. I centurioni,
alcuni dei quali, per il loro valore, erano stati promossi dagli ordini
inferiori delle altre legioni agli ordini superiori di questa, caddero sul
campo, combattendo con straordinario coraggio, per non perdere l'onore
delle armi che si erano prima conquistati. Parte dei soldati, mentre i
nemici venivano respinti dal valore dei centurioni, contro ogni speranza
raggiunse salva l'accampamento, parte fu circondata dai barbari e uccisa.
[41
I Germani, persa la speranza di espugnare il campo, poiché vedevano i
nostri ormai ben saldi sui baluardi, si ritirarono oltre il Reno con il
bottino che avevano nascosto nelle selve. E anche dopo la partenza dei
nemici, i nostri rimasero così atterriti, che C. Voluseno, quando giunse,
quella notte stessa, al campo con la cavalleria, non riuscì a far credere
che Cesare stesse arrivando con l'esercito indenne. Il panico si era
impadronito degli animi di tutti al punto che erano quasi usciti di senno:
dicevano che l'esercito era stato annientato e che la cavalleria era
riuscita a salvarsi fuggendo, sostenevano che, se l'esercito non fosse
stato distrutto, i Germani non avrebbero attaccato il nostro campo.
L'arrivo di Cesare dissolse ogni paura.
[42
Appena rientrato, Cesare, ben sapendo come vanno le cose in guerra, si
lamentò solo di un fatto, che le coorti fossero state spedite fuori dalla
guarnigione e dal presidio: non bisognava lasciare al caso il benché
minimo spazio. Giudicò determinante il ruolo della Fortuna nel repentino
attacco nemico, ma ancor più nel respingere i barbari quasi dal vallo e
dalle porte dell'accampamento. Tra tutte le circostanze, però, la più
singolare gli parve che i Germani, varcato il Reno con l'intenzione di
saccheggiare i territori di Ambiorige, si fossero, poi, volti contro
l'accampamento dei Romani, rendendo ad Ambiorige stesso il beneficio più
desiderato.
[43
Cesare ripartì con lo scopo di devastare i territori nemici e, radunati
forti contingenti di cavalleria dai popoli limitrofi, li invia in ogni
direzione. Tutti i villaggi, tutti gli edifici isolati, appena scorti,
erano dati alle fiamme, gli animali venivano sgozzati, si faceva razzia
ovunque, il grano non lo consumavano solo i moltissimi giumenti e soldati,
ma cadeva anche nei campi per la stagione avanzata e le piogge. Così, se
anche qualcuno, al momento, era riuscito a nascondersi, sembrava tuttavia
destinato, dopo la partenza dell'esercito romano, a morte sicura, per
totale mancanza di sostentamento. E, suddivisa e inviata la cavalleria in
tutte le direzioni, più d'una volta si giunse al punto che i prigionieri
cercassero con gli occhi Ambiorige, che avevano appena scorto in fuga, e
sostenessero che non poteva essere già fuori di vista. I cavalieri
speravano di catturarlo e si impegnavano senza respiro, ritenendo di poter
entrare nelle grazie di Cesare, e con il loro zelo piegavano, per così
dire, la natura, ma, a quanto pareva, si trovavano sempre a un passo dal
successo. Ambiorige si sottraeva alla caccia rifugiandosi in anfratti o
boscaglie, con il favore delle tenebre si spostava in altre regioni e
zone, senz'altra scorta che quattro cavalieri, i soli a cui osasse
affidare la propria vita.
[44
Devastate in tal modo le regioni, Cesare conduce l'esercito, che aveva
subito la perdita di due coorti, a Durocortoro, città dei Remi. Qui
convoca l'assemblea della Gallia e decide di aprire un'inchiesta sulla
cospirazione dei Senoni e dei Carnuti. Accone, responsabile del piano di
sollevazione, fu condannato alla pena capitale e giustiziato secondo
l'antico costume dei nostri padri. Alcuni, temendo il processo, fuggirono.
Cesare li condannò all'esilio. Sistemò nei quartieri invernali due legioni
presso i Treveri, due nelle terre dei Lingoni, le altre sei nella regione
dei Senoni, ad Agedinco. Dopo aver provveduto alle scorte di grano per
l'esercito, partì alla volta dell'Italia, come suo solito, per tenervi le
sessioni giudiziarie. |
LIBER SEPTIMUS
[1] Quieta Gallia Caesar, ut constituerat, in Italiam ad conventus agendos proficiscitur. Ibi cognoscit de Clodii caede
[de] senatusque consulto certior factus, ut omnes iuniores Italiae coniurarent, delectum tota provincia habere instituit. Eae res in Galliam Transalpinam celeriter perferuntur. Addunt ipsi et ad fingunt rumoribus Galli, quod res poscere videbatur, retineri urbano motu Caesarem neque in tantis dissensionibus ad exercitum venire posse. Hac impulsi occasione, qui iam ante se populi Romani imperio subiectos dolerent liberius atque audacius de bello consilia inire incipiunt. Indictis inter se principes Galliae conciliis silvestribus ac remotis locis queruntur de Acconis morte; posse hunc casum ad ipsos recidere demonstrant: miserantur communem Galliae fortunam: omnibus pollicitationibus ac praemius deposcunt qui belli initium faciant et sui capitis periculo Galliam in libertatem vindicent. In primis rationem esse habendam dicunt, priusquam eorum clandestina consilia efferantur, ut Caesar ab exercitu intercludatur. Id esse facile, quod neque legiones audeant absente imperatore ex hibernis egredi, neque imperator sine praesidio ad legiones pervenire possit. Postremo in acie praestare interfici quam non veterem belli gloriam libertatemque quam a maioribus acce perint recuperare.
[2] His rebus agitatis profitentur Carnutes se nullum periculum communis salutis causa recusare principesque ex omnibus bellum facturos pollicentur et, quoniam in praesentia obsidibus cavere inter se non possint ne res efferatur, ut iureiurando ac fide sanciatur, petunt, collatis militaribus signis, quo more eorum gravissima caerimonia continetur, ne facto initio belli ab reliquis deserantur. Tum collaudatis Carnutibus, dato iureiurando ab omnibus qui aderant, tempore eius rei constituto ab concilio disceditur.
[3] Ubi ea dies venit, Carnutes Cotuato et Conconnetodumno ducibus, desperatis hominibus, Cenabum signo dato concurrunt civesque Romanos, qui negotiandi causa ibi constiterant, in his Gaium Fufium Citam, honestum equitem Romanum, qui rei frumentariae iussu Caesaris praeerat, interficiunt bonaque eorum diripiunt. Celeriter ad omnes Galliae civitates fama perfertur. Nam ubicumque maior atque illustrior incidit res, clamore per agros regionesque significant; hunc alii deinceps excipiunt et proximis tradunt, ut tum accidit. Nam quae Cenabi oriente sole gesta essent, ante primam confectam vigiliam in finibus Arvernorum audita sunt, quod spatium est milium passuum circiter centum LX.
[4] Simili ratione ibi Vercingetorix, Celtilli filius, Arvernus, summae potentiae adulescens, cuius pater principatum Galliae totius obtinuerat et ob eam causam, quod regnum appetebat, ab civitate erat interfectus, convocatis suis clientibus facile incendit. Cognito eius consilio ad arma concurritur. Prohibetur ab Gobannitione, patruo suo, reliquisque principibus, qui hanc temptandam fortunam non existimabant; expellitur ex oppido Gergovia; non destitit tamen atque in agris habet dilectum egentium ac perditorum. Hac coacta manu, quoscumque adit ex civitate ad suam sententiam perducit; hortatur ut communis libertatis causa arma capiant, magnisque coactis copiis adversarios suos a quibus paulo ante erat eiectus expellit ex civitate. Rex ab suis appellatur. Dimittit quoque versus legationes; obtestatur ut in fide maneant. Celeriter sibi Senones, Parisios, Pictones, Cadurcos, Turonos, Aulercos, Lemovices, Andos reliquosque omnes qui Oceanum attingunt adiungit: omnium consensu ad eum defertur imperium. Qua oblata potestate omnibus his civitatibus obsides imperat, certum numerum militum ad se celeriter adduci iubet, armorum quantum quaeque civitas domi quodque ante tempus efficiat constituit; in primis equitatui studet. Summae diligentiae summam imperi severitatem addit; magnitudine supplici dubitantes cogit. Nam maiore commisso delicto igni atque omnibus tormentis necat, leviore de causa auribus desectis aut singulis effossis oculis domum remittit, ut sint reliquis documento et magnitudine poenae perterreant alios.
[5] His suppliciis celeriter coacto exercitu Lucterium Cadurcum, summae hominem audaciae, cum parte copiarum in Rutenos mittit; ipse in Bituriges proficiscitur. Eius adventu Bituriges ad Aeduos, quorum erant in fide, legatos mittunt subsidium rogatum, quo facilius hostium copias sustinere possint. Aedui de consilio legatorum, quos Caesar ad exercitum reliquerat, copias equitatus peditatusque subsidio Biturigibus mittunt. Qui cum ad flumen Ligerim venissent, quod Bituriges ab Aeduis dividit, paucos dies ibi morati neque flumen transire ausi domum revertuntur legatisque nostris renuntiant se Biturigum perfidiam veritos revertisse, quibus id consili fuisse cognoverint, ut, si flumen transissent, una ex parte ipsi, altera Arverni se circumsisterent. Id eane de causa, quam legatis pronuntiarunt, an perfidia adducti fecerint, quod nihil nobis constat, non videtur pro certo esse proponendum. Bituriges eorum discessu statim cum Arvernis iunguntur.
[6] His rebus in Italiam Caesari nuntiatis, cum iam ille urbanas res virtute Cn. Pompei commodiorem in statum pervenisse intellegeret, in Transalpinam Galliam profectus est. Eo cum venisset, magna difficultate adficiebatur, qua ratione ad exercitum pervenire posset. Nam si legiones in provinciam arcesseret, se absente in itinere proelio dimicaturas intellegebat; si ipse ad exercitum contenderet, ne eis quidem eo tempore qui quieti viderentur suam salutem recte committi videbat.
[7] Interim Lucterius Cadurcus in Rutenos missus eam civitatem Arvernis conciliat. Progressus in Nitiobriges et Gabalos ab utrisque obsides accipit et magna coacta manu in provinciam Narbonem versus eruptionem facere contendit. Qua re nuntiata Caesar omnibus consiliis antevertendum existimavit, ut Narbonem proficisceretur. Eo cum venisset, timentes confirmat, praesidia in Rutenis provincialibus, Volcis Arecomicis, Tolosatibus circumque Narbonem, quae loca hostibus erant finitima, constituit; partem copiarum ex provincia supplementumque, quod ex Italia adduxerat, in Helvios, qui fines Arvernorum contingunt, convenire iubet.
[8] His rebus comparatis, represso iam Lucterio et remoto, quod intrare intra praesidia periculosum putabat, in Helvios proficiscitur. Etsi mons Cevenna, qui Arvernos ab Helviis discludit, durissimo tempore anni altissima nive iter impediebat, tamen discussa nive sex in altitudinem pedum atque ita viis patefactis summo militum sudore ad fines Arvernorum pervenit. Quibus oppressis inopinantibus, quod se Cevenna ut muro munitos existimabant, ac ne singulari quidem umquam homini eo tempore anni semitae patuerant, equitibus imperat, ut quam latissime possint vagentur et quam maximum hostibus terrorem inferant. Celeriter haec fama ac nuntiis ad Vercingetorigem perferuntur; quem perterriti omnes Arverni circumsistunt atque obsecrant, ut suis fortunis consulat, neve ab hostibus diripiautur, praesertim cum videat omne ad se bellum translatum. Quorum ille precibus per motus castra ex Biturigibus movet in Arveruos versus.
[9] At Caesar biduum in his locis moratus, quod haec de Vercingetorige usu ventura opinione praeceperat, per causam supplementi equitatusque cogendi ab exercitu discedit; Brutum adulescentem his copiis praeficit; hunc monet, ut in omnes partes equites quam latissime pervagentur: daturum se operam, ne longius triduo ab castris absit. His constitutis rebus suis inopinantibus quam maximis potest itineribus Viennam pervenit. Ibi nactus recentem equitatum, quem multis ante diebus eo praemiserat, neque diurno neque nocturno itinere intermisso per fines Aeduorum in Lingones contendit, ubi duae legiones hiemabant, ut, si quid etiam de sua salute ab Aeduis iniretur consili, celeritate praecurreret. Eo cum pervenisset, ad reliquas legiones mittit priusque omnes in unum locum cogit quam de eius adventu Arvernis nuntiari posset. Hac re cognita Vercingetorix rursus in Bituriges exercitum reducit atque inde profectus Gorgobinam, Boiorum oppidum, quos ibi Helvetico proelio victos Caesar collocaverat Aeduisque attribuerat, oppugnare instituit.
[10] Magnam haec res Caesari difficultatem ad consilium capiendum adferebat, si reliquam partem hiemis uno loco legiones contineret, ne stipendiariis Aeduorum expugnatis cuncta Gallia deficeret, quod nullum amicis in eo praesidium videretur positum esse; si maturius ex hibernis educeret, ne ab re frumentaria duris subvectionibus laboraret. Praestare visum est tamen omnis difficultates perpeti, quam tanta contumelia accepta omnium suorum voluntates alienare. Itaque cohortatus Aeduos de supportando commeatu praemittit ad Boios qui de suo adventu doceant hortenturque ut in fide maneant atque hostium impetum magno animo sustineant. Duabus Agedinci legionibus atque impedimentis totius exer citus relictis ad Boios proficiscitur.
[11] Altero die cum ad oppidum Senonum Vellaunodunum venisset, ne quem post se hostem relinqueret, quo expeditiore re frumentaria uteretur, oppugnare instituit idque biduo circumvallavit; tertio die missis ex oppido legatis de deditione arma conferri, iumenta produci, sescentos obsides dari iubet. Ea qui conficeret, a. Trebonium legatum relinquit. Ipse, ut quam primum iter faceret, Cenabum Carnutum proficiscitur; qui tum primum allato nuntio de oppugnatione Vellaunoduni, cum longius eam rem ductum iri existimarent, praesidium Cenabi tuendi causa, quod eo mitterent, comparabant. Huc biduo pervenit. Castris ante oppidum positis diei tempore exclusus in posterum oppugnationem differt quaeque ad eam rem usui sint militibus imperat et, quod oppidum Cenabum pons fluminis Ligeris contingebat, veritus ne noctu ex oppido profugerent, duas legiones in armis excubare iubet. Cenabenses paulo ante mediam noctem silentio ex oppido egressi flumen transire coeperunt. Qua re per exploratores nuntiata Caesar legiones quas expeditas esse iusserat portis incensis intromittit atque oppido potitur, perpaucis ex hostium numero desideratis quin cuncti caperentur, quod pontis atque itinerum angustiae multitudinis fugam intercluserant. Oppidum diripit atque incendit, praedam militibus donat, exercitum Ligerem traducit atque in Biturigum fines pervenit.
[12] Vercingetorix, ubi de Caesaris adventu cognovit, oppuguatione destitit atque obviam Caesari proficiscitur. Ille oppidum Biturigum positum in via Noviodunum oppugnare instituerat. Quo ex oppido cum legati ad eum venissent oratum ut sibi ignosceret suaeque vitae consuleret, ut celeritate reliquas res conficeret, qua pleraque erat consecutus, arma conferri, equos produci, obsides dari iubet. Parte iam obsidum tradita, cum reliqua administrarentur, centurionibus et paucis militibus intromissis, qui arma iumentaque conquirerent, equitatus hostium procul visus est, qui agmen Vercingetorigis antecesserat. Quem simul atque oppidani conspexerunt atque in spem auxili venerunt, clamore sublato arma capere, portas claudere, murum complere coeperunt. Centuriones in oppido, cum ex significatione Gallorum novi aliquid ab eis iniri consili intellexissent, gladiis destrictis portas occupaverunt suosque omnes incolumes receperunt.
[13] Caesar ex castris equitatum educi iubet, proelium equestre committit: laborantibus iam suis Germanos equites circiter CCCC summittit, quos ab initio habere secum instituerat. Eorum impetum Galli sustinere non potuerunt atque in fugam coniecti multis amissis se ad agmen receperunt. Quibus profligatis rursus oppidani perterriti comprehensos eos, quorum opera plebem concitatam existimabant, ad Caesarem perduxerunt seseque ei dediderunt. Quibus rebus confectis, Caesar ad oppidum Avaricum, quod erat maximum munitissimumque in finibus Biturigum atque agri fertilissima regione, profectus est, quod eo oppido recepto civitatem Biturigum se in potestatem redacturum confidebat.
[14] Vercingetorix tot continuis incommodis Vellaunoduni, Cenabi, Novioduni acceptis suos ad concilium convocat. Docet longe alia ratione esse bellum gerendum atque antea gestum sit. Omnibus modis huic rei studendum, ut pabulatione et commeatu Romani prohibeantur. Id esse facile, quod equitatu ipsi abundent et quod anni tempore subleventur. Pabulum secari non posse; necessario dispersos hostes ex aedificiis petere: hos omnes cotidie ab equitibus deligi posse. Praeterea salutis causa rei familiaris commoda neglegenda: vicos atque aedificia incendi oportere hoc spatio ab via quoque versus, quo pabulandi causa adire posse videantur. Harum ipsis rerum copiam suppetere, quod, quorum in finibus bellum geratur, eorum opibus subleventur: Romanos aut inopiam non laturos aut magno periculo longius ab castris processuros; neque interesse, ipsosne interficiant, impedimentisne exuant, quibus amissis bellum geri non possit. Praeterea oppida incendi oportere, quae non munitione et loci natura ab omni sint periculo tuta, neu suis sint ad detractandam militiam receptacula neu Romanis proposita ad copiam commeatus praedamque tollendam. Haec si gravia aut acerba videautur, multo illa gravius aestimare, liberos, coniuges in servitutem abstrahi, ipsos interfici; quae sit necesse accidere victis.
[15] Omnium consensu hac sententia probata uno die amplius XX urbes Biturigum iucenduntur. Hoc idem fit in reliquis civitatibus: in omnibus partibus incendia conspiciuntur; quae etsi magno cum dolore omnes ferebant, tamen hoc sibi solati proponebant, quod se prope explorata victoria celeriter amissa reciperaturos confidebant. Deliberatur de Avarico in communi concilio, incendi placeret an defendi. Procumbunt omnibus Gallis ad pedes Bituriges, ne pulcherrimam prope totius Galliae urbem, quae praesidio et ornamento sit civitati, suis manibus succendere cogerentur: facile se loci natura defensuros dicunt, quod prope ex omnibus partibus flumine et palude circumdata unum habeat et perangustum aditum. Datur petentibus venia dissuadente primo Vercingetorige, post concedente et precibus ipsorum et misericordia vulgi. Defensores oppido idonei deliguntur.
[16] Vercingetorix minoribus Caesarem itineribus subsequitur et locum castris deligit paludibus silvisque munitum ab Avarico longe milia passuum XVI. Ibi per certos exploratores in singula diei tempora quae ad Avaricum agerentur cognoscebat et quid fieri vellet imperabat. Omnes nostras pabulationes frumentationesque observabat dispersosque, cum longius necessario procederent, adoriebatur magnoque incommodo adficiebat, etsi, quantum ratione provideri poterat, ab nostris occurrebatur, ut incertis temporibus diversisque itineribus iretur.
[17] Castris ad eam partem oppidi positis Caesar, quae intermissa
[a] flumine et a paludibus aditum, ut supra diximus, angustum habebat, aggerem apparare, vineas agere, turres duas constituere coepit: nam circumvallare loci natura prohibebat. De re frumentaria Boios atque Aeduos adhortari non destitit; quorum alteri, quod nullo studio agebant, non multum adiuvabant, alteri non magnis facultatibus, quod civitas erat exigua et infirma, celeriter quod habuerunt consumpserunt. Summa difficultate rei frumentariae adfecto exercitu tenuitate Boiorum, indiligentia Aeduorum, incendiis aedificiorum, usque eo ut complures dies frumento milites caruerint et pecore ex longinquioribus vicis adacto extremam famem sustentarent, nulla tamen vox est ab eis audita populi Romani maiestate et superioribus victoriis indigna. Quin etiam Caesar cum in opere singulas legiones appellaret et, si acerbius inopiam ferrent, se dimissurum oppugnationem diceret, universi ab eo, ne id faceret, petebant: sic se complures anuos illo imperante meruisse, ut nullam ignominiam acciperent, nusquam infecta re discederent: hoc se ignominiae laturos loco, si inceptam oppugnationem reliquissent: praestare omnes perferre acerbitates, quam non civibus Romanis, qui Cenabi perfidia Gallorum interissent, parentarent. Haec eadem centurionibus tribunisque militum mandabant, ut per eos ad Caesarem deferrentur.
[18] Cum iam muro turres appropinquassent, ex captivis Caesar cognovit Vercingetorigem consumpto pabulo castra movisse propius Avaricum atque ipsum cum equitatu expeditisque, qui inter equites proeliari consuessent, insidiarum causa eo profectum, quo nostros postero die pabulatum venturos arbitraretur. Quibus rebus cognitis media nocte silentio profectus ad hostium castra mane pervenit. Illi celeriter per exploratores adventu Caesaris cognito carros impedimentaque sua in artiores silvas abdiderunt, copias omnes in loco edito atque aperto instruxerunt. Qua re nuntiata Caesar celeriter sarcinas conferri, arma expediri iussit.
[19] Collis erat leniter ab infimo acclivis. Hunc ex omnibus fere partibus palus difficilis atque impedita cingebat non latior pedibus quinquaginta. Hoc se colle interruptis pontibus Galli fiducia loci continebant generatimque distributi in civitates omnia vada ac saltus eius paludis obtinebant sic animo parati, ut, si eam paludem Romani perrumpere conarentur, haesitantes premerent ex loco superiore; ut qui propinquitatem loci videret paratos prope aequo Marte ad dimicandum existimaret, qui iniqui tatem condicionis perspiceret inani simulatione sese ostentare cognosceret. Indignantes milites Gaesar, quod conspectum suum hostes perferre possent tantulo spatio interiecto, et signum proeli ecentes edocet, quanto detrimento et quot virorum tortium morte necesse sit constare victoriam; quos cum sic animo paratos videat, ut nullum pro sua laude periculum recusent, summae se iniquitatis condemnari debere, nisi eorum vitam sua salute habeat cariorem. Sic milites consolatus eodem die reducit in castra reliquaque quae ad oppugnationem pertinebant oppidi administrare instituit.
[20] Vercingetorix, cum ad suos redisset, proditionis insimulatus, quod castra propius Romanos movisset, quod cum omni equitatu discessisset, quod sine imperio tantas copias reliquisset, quod eius discessu Romani tanta opportunitate et celeritate venissent: non haec omnia fortuito aut sine consilio accidere potuisse; regnum illum Galliae malle Caesaris concessu quam ipsorum habere beneficio--tali modo accusatus ad haec respondit: Quod castra movisset, factum inopia pabuli etiam ipsis hortantibus; quod propius Romanos accessisset, persuasum loci opportunitate, qui se ipsum munitione defenderet: equitum vero operam neque in loco palustri desiderari debuisse et illic fuisse utilem, quo sint profecti. Summam imperi se consulto nulli discedentem tradidisse, ne is multitudinis studio ad dimicandum impelleretur; cui rei propter animi mollitiem studere omnes videret, quod diutius laborem ferre non possent. Romani si casu intervenerint, fortunae, si alicuius indicio vocati, huic habendam gratiam, quod et paucitatem eorum ex loco superiore cognoscere et virtutem despicere potuerint, qui dimicare non ausi turpiter se in castra receperint. Imperium se ab Caesare per proditionem nullum desiderare, quod habere victoria posset, quae iam esset sibi atque omnibus Gallis explorata: quin etiam ipsis remittere, si sibi magis honorem tribuere, quam ab se salutem accipere videantur. "Haec ut intellegatis," inquit, "a me sincere pronuntiari, audite Romanos milites." Producit servos, quos in pabulatione paucis ante diebus exceperat et fame vinculisque excruciaverat. Hi iam ante edocti quae interrogati pronuntiarent, milites se esse legionarios dicunt; fame et inopia adductos clam ex castris exisse, si quid frumenti aut pecoris in agris reperire possent: simili omnem exercitum inopia premi, nec iam vires sufficere cuiusquam nec ferre operis laborem posse: itaque statuisse imperatorem, si nihil in oppugnatione oppidi profecissent, triduo exercitum deducere. "Haec," inquit, "a me," Vercingetorix, "beneficia habetis, quem proditionis insimulatis; cuius opera sine vestro sanguine tantum exercitum victorem fame consumptum videtis; quem turpiter se ex fuga recipientem ne qua civitas suis finibus recipiat a me provisum est."
[21] Conclamat omnis multitudo et suo more armis concrepat, quod facere in eo consuerunt cuius orationem approbant: summum esse Vercingetorigem ducem, nec de eius fide dubitandum, nec maiore ratione bellum administrari posse. Statuunt, ut X milia hominum delecta ex omnibus copiis in oppidum mittantur, nec solis Biturigibus communem salutem committendam censent, quod paene in eo, si id oppidum retinuissent, summam victoriae constare intellegebant.
[22] Singulari militum nostrorum virtuti consilia cuius que modi Gallorum occurrebant, ut est summae genus sollertiae atque ad omnia imitanda et efficienda, quae ab quoque traduntur, aptissimum. Nam et laqueis falces avertebant, quas, cum destinaverant, tormentis introrsus reducebant, et aggerem cuniculis subtrahebant, eo scientius quod apud eos magnae sunt ferrariae atque omne genus cuniculorum notum atque usitatum est. Totum autem murum ex omni parte turribus contabulaverant atque has coriis intexerant. Tum crebris diurnis nocturnisque eruptionibus aut aggeri ignem inferebant aut milites occupatos in opere adoriebantur, et nostrarum turrium altitudinem, quantum has cotidianus agger expresserat, commissis suarum turrium malis adaequabant, et apertos cuniculos praeusta et praeacuta materia et pice fervefacta et maximi ponderis saxis morabantur moenibusque appropinquare prohibebant.
[23] Muri autem omnes Gallici hac fere forma sunt. Trabes derectae perpetuae in longitudinem paribus intervallis, distantes inter se binos pedes, in solo collocantur. Hae revinciuntur introrsus et multo aggere vestiuntur: ea autem, quae diximus, inter valla grandibus in fronte saxis effarciuntur. His collocatis et coagmentatis alius insuper ordo additur, ut idem illud intervallum servetur neque inter se contingant trabes, sed paribus intermissae spatiis singulae singulis saxis interiectis arte contineantur. Sic deinceps omne opus contexitur, dum iusta muri altitudo expleatur. Hoc cum in speciem varietatemque opus deforme non est alternis trabibus ac saxis, quae rectis lineis suos ordines servant, tum ad utilitatem et defensionem urbium summam habet opportunitatem, quod et ab incendio lapis et ab ariete materia defendit, quae perpetuis trabibus pedes quadragenos plerumque introrsus revincta neque perrumpi neque distrahi potest.
[24] His tot rebus impedita oppugnatione milites, cum toto tempore frigore et assiduis imbribus tardarentur, tamen continenti labore omnia haec superaverunt et diebus XXV aggerem latum pedes CCCXXX, altum pedes LXXX exstruxerunt. Cum is murum hostium paene contingeret, et Caesar ad opus consuetudine excubaret milites que hortaretur, ne quod omnino tempus ab opere intermitteretur, paulo ante tertiam vigiliam est animadversum fumare aggerem, quem cuniculo hostes succenderant, eodemque tempore toto muro clamore sublato duabus portis ab utroque latere turrium eruptio fiebat, alii faces atque aridam materiem de muro in aggerem eminus iaciebant, picem reliquasque res, quibus ignis excitari potest, fundebant, ut quo primum curreretur aut cui rei ferretur auxilium vix ratio iniri posset. Tamen, quod instituto Caesaris semper duae legiones pro castris excubabant pluresque partitis temporibus erant in opere, celeriter factum est, ut alii eruptionibus resisterent, alii turres reducerent aggeremque inter scinderent, omnis vero ex castris multitudo ad restinguendum concurreret.
[25] Cum in omnibus locis consumpta iam reliqua parte noctis pugnaretur, semperque hostibus spes victoriae redintegraretur, eo magis, quod deustos pluteos turrium videbant nec facile adire apertos ad auxiliandum animadvertebant, semperque ipsi recentes defessis succederent omnemque Galliae salutem in illo vestigio temporis positam arbitrarentur, accidit inspectantibus nobis quod dignum memoria visum praetereundum non existimavimus. Quidam ante portam oppidi Gallus per manus sebi ac picis traditas glebas in ignem e regione turris proiciebat: scorpione ab latere dextro traiectus exanimatusque concidit. Hunc ex proximis unus iacentem transgressus eodem illo munere fungebatur; eadem ratione ictu scorpionis exanimato alteri successit tertius et tertio quartus, nec prius ille est a propugnatoribus vacuus relictus locus quam restincto aggere atque omni ex parte summotis hostibus finis est pugnandi factus.
[26] Omnia experti Galli, quod res nulla successerat, postero die consilium ceperunt ex oppido profugere hortante et iubente Vercingetorige. Id silentio noctis conati non magna iactura suorum sese effecturos sperabant, propterea quod neque longe ab oppido castra Vercingetorigis aberant, et palus, quae perpetua intercedebat, Romanos ad insequendum tardabat. Iamque hoc facere noctu apparabant, cum matres familiae repente in publicum procurrerunt flentesque proiectae ad pedes suorum omnibus precibus petierunt, ne se et communes liberos hostibus ad supplicium dederent, quos ad capiendam fugam naturae et virium infirmitas impediret. Ubi eos in sententia perstare viderunt, quod plerumque in summo periculo timor misericordiam non recipit, conclamare et significare de fuga Romanis coeperunt. Quo timore perterriti Galli, ne ab equitatu Romanorum viae praeoccuparentur, consilio destiterunt.
[27] Postero die Caesar promota turri perfectisque operibus quae facere instituerat, magno coorto imbre non inutilem hanc ad capiendum consilium tempestatem arbitratus est, quod paulo incautius custodias in muro dispositas videbat, suosque languidius in opere versari iussit et quid fieri vellet ostendit. Legionibusque intra vineas in occulto expeditis, cohortatus ut aliquando pro tantis laboribus fructum victoriae perciperent, eis qui primi murum ascendissent praemia proposuit militibusque signum dedit. Illi subito ex omnibus partibus evolaverunt murumque celeriter compleverunt.
[28] Hostes re nova perterriti muro turribusque deiecti in foro ac locis patentioribus cuneatim constiterunt, hoc animo ut si qua ex parte obviam contra veniretur acie instructa depugnarent. Ubi neminem in aequum locum sese demittere, sed toto undique muro circumfundi viderunt, veriti ne omnino spes fugae tolleretur, abiectis armis ultimas oppidi partes continenti impetu petiverunt, parsque ibi, cum angusto exitu portarum se ipsi premerent, a militibus, pars iam egressa portis ab equitibus est interfecta; nec fuit quisquam, qui praedae studeret. Sic et Cenabi caede et labore operis incitati non aetate confectis, non mulieribus, non infantibus pepercerunt. Denique ex omni numero, qui fuit circiter milium XL, vix DCCC, qui primo clamore audito se ex oppido eiecerunt, incolumes ad Vercingetorigem pervenerunt. Quos ille multa iam nocte silentio ex fuga excepit, veritus ne qua in castris ex eorum concursu et misericordia vulgi seditio oreretur, ut procul in via dispositis familiaribus suis principibusque civitatum disparandos deducendosque ad suos curaret, quae cuique civitati pars castrorum ab initio obvenerat.
[29] Postero die concilio convocato consolatus cohortatusque est ne se admodum animo demitterent, ne perturbarentur incommodo. Non virtute neque in acie vicisse Romanos, sed artificio quodam et scientia oppugnationis, cuius rei fuerint ipsi imperiti. Errare, si qui in bello omnes secundos rerum proventus exspectent. Sibi numquam placuisse Avaricum defendi, cuius rei testes ipsos haberet; sed factum imprudentia Biturigum et nimia obsequentia reliquorum uti hoc incommodum acciperetur. Id tamen se celeriter maioribus commodis sanaturum. Nam quae ab reliquis Gallis civitates dissentirent, has sua diligentia adiuncturum atque unum consilium totius Galliae effecturum, cuius consensui ne orbis quidem terrarum possit obsistere; idque se prope iam effectum habere. Interea aequum esse ab eis communis salutis causa impetrari ut castra munire instituerent, quo facilius repentinos hostium impetus sustinerent.
[30] Fuit haec oratio non ingrata Gallis, et maxime, quod ipse animo non defecerat tanto accepto incommodo neque se in occultum abdiderat et conspectum multitudinis fugerat; plusque animo providere et praesentire existimabatur, quod re integra primo incendendum Avaricum, post deserendum censuerat. Itaque ut reliquorum imperatorum res adversae auctoritatem minuunt, sic huius ex contrario dignitas incommodo accepto in dies augebatur. Simul in spem veniebant eius adfirmatione de reliquis adiungendis civitatibus; primumque eo tempore Galli castra munire instituerunt et sic sunt animo confirmati, homines insueti laboris, ut omnia quae imperarentur sibi patienda existimarent.
[31] Nec minus quam est pollicitus Vercingetorix animo laborabat ut reliquas civitates adiungeret, atque eas donis pollicitationibusque alliciebat. Huic rei idoneos homines deligebat, quorum quisque aut oratione subdola aut amicitia facillime capere posset. Qui Avarico expugnato refugerant, armandos vestiendosque curat; simul, ut deminutae copiae redintegrarentur, imperat certum numerum militum civitatibus, quem et quam ante diem in castra adduci velit, sagittariosque omnes, quorum erat permagnus numerus in Gallia, conquiri et ad se mitti iubet. His rebus celeriter id quod Avarici deperierat expletur. Interim Teutomatus, Olloviconis filius, rex Nitiobrigum, cuius pater ab senatu nostro amicus erat appellatus, cum magno equitum suorum numero et quos ex Aquitania conduxerat ad eum pervenit.
[32] Caesar Avarici complures dies commoratus summamque ibi copiam frumenti et reliqui commeatus nactus exercitum ex labore atque inopia refecit. Iam prope hieme confecta cum ipso anni tempore ad gerendum bellum vocaretur et ad hostem proficisci constituisset, sive eum ex paludibus silvisque elicere sive obsidione premere posset, legati ad eum principes Aeduorum veniunt oratum ut maxime necessario tempore civitati subveniat: summo esse in periculo rem, quod, cum singuli magistratus antiquitus creari atque regiam potestatem annum obtinere consuessent, duo magistratum gerant et se uterque eorum legibus creatum esse dicat. Horum esse alterum Convictolitavem, florentem et illustrem adulescentem, alterum Cotum, antiquissima familia natum atque ipsum hominem summae potentiae et magnae cognationis, cuius frater Valetiacus proximo anno eundem magistratum gesserit. Civitatem esse omnem in armis; divisum senatum, divisum populum, suas cuiusque eorum clientelas. Quod si diutius alatur controversia, fore uti pars cum parte civitatis confligat. Id ne accidat, positum in eius diligentia atque auctoritate.
[33] Caesar, etsi a bello atque hoste discedere detrimentosum esse existimabat, tamen non ignorans quanta ex dissensionibus incommoda oriri consuessent, ne tanta et tam coniuncta populo Romano civitas, quam ipse semper aluisset omnibusque rebus ornasset, ad vim atque arma descenderet, atque ea pars quae minus sibi confideret auxilia a Vercingetorige arcesseret, huic rei praevertendum existimavit et, quod legibus Aeduorum eis, qui summum magistra tum obtinerent, excedere ex finibus non liceret, ne quid de iure aut de legibus eorum deminuisse videretur, ipse in Aeduos proficisci statuit senatumque omnem et quos inter controversia esset ad se Decetiam evocavit. Cum prope omnis civitas eo convenisset, docereturque paucis clam convocatis alio loco, alio tempore atque oportuerit fratrem a fratre renuntiatum, cum leges duo ex una familia vivo utroque non solum magistratus creari vetarent, sed etiam in senatu esse prohiberent, Cotum imperium deponere coegit, Convictolitavem, qui per sacerdotes more civitatis intermissis magistratibus esset creatus, potestatem obtinere iussit.
[34] Hoc decreto interposito cohortatus Aeduos, ut controversiarum ac dissensionis obliviscerentur atque omnibus omissis his rebus huic bello servirent eaque quae meruissent praemia ab se devicta Gallia exspectarent equitatumque omnem et peditum milia decem sibi celeriter mitterent, quae in praesidiis rei frumentariae causa disponeret, exercitum in duas partes divisit: quattuor legiones in Senones Parisiosque Labieno ducendas dedit, sex ipse in Arvernos ad oppidum Gergoviam secundum flumen Elaver duxit; equitatus partem illi attribuit, partem sibi reliquit. Qua re cognita Vercingetorix omnibus interruptis eius fluminis pontibus ab altera fluminis parte iter facere coepit.
[35] Cum uterque utrimque exisset exercitus, in conspectu fereque e regione castris castra ponebant dispositis exploratoribus, necubi effecto ponte Romani copias traducerent. Erat in magnis Caesaris difficultatibus res, ne maiorem aestatis partem flumine impediretur, quod non fere ante autumnum Elaver vado transiri solet. Itaque, ne id accideret, silvestri loco castris positis e regione unius eorum pontium, quos Vercingetorix rescindendos curaverat, postero die cum duabus legionibus in occulto restitit; reliquas copias cum omnibus impedimentis, ut consueverat, misit, apertis quibusdam cohortibus, uti numerus legionum constare videretur. His quam longissime possent egredi iussis, cum iam ex diei tempore coniecturam ceperat in castra perventum, isdem sublicis, quarum pars inferior integra remanebat, pontem reficere coepit. Celeriter effecto opere legionibusque traductis et loco castris idoneo delecto reliquas copias revocavit. Vercingetorix re cognita, ne contra suam voluntatem dimicare cogeretur, magnis itineribus antecessit.
[36] Caesar ex eo loco quintis castris Gergoviam pervenit equestrique eo die proelio levi facto perspecto urbis situ, quae posita in altissimo monte omnes aditus difficiles habebat, de expugnatione desperavit, de obsessione non prius agendum constituit, quam rem frumentariam expedisset. At Vercingetorix castris, prope oppidum positis, mediocribus circum se intervallis separatim singularum civitatium copias collocaverat atque omnibus eius iugi collibus occupatis, qua despici poterat, horribilem speciem praebebat; principesque earum civitatium, quos sibi ad consilium capiendum delegerat, prima luce cotidie ad se convenire iubebat, seu quid communicandum, seu quid administrandum videretur; neque ullum fere diem intermittebat quin equestri proelio interiectis sagittariis, quid in quoque esset animi ac virtutis suorum perspiceret. Erat e regione oppidi collis sub ipsis radicibus montis, egregie munitus atque ex omni parte circumcisus; quem si tenerent nostri, et aquae magna parte et pabulatione libera prohibituri hostes videbantur. Sed is locus praesidio ab his non nimis firmo tenebatur. Tamen silentio noctis Caesar ex castris egressus, priusquam subsidio ex oppido veniri posset, deiecto praesidio potitus loco duas ibi legiones collocavit fossamque duplicem duodenum pedum a maioribus castris ad minora perduxit, ut tuto ab repentino hostium incursu etiam singuli commeare possent.
[37] Dum haec ad Gergoviam geruntur, Convictolitavis Aeduus, cui magistratum adiudicatum a Caesare demonstravimus, sollicitatus ab Arvernis pecunia cum quibusdam adulescentibus colloquitur; quorum erat princeps Litaviccus atque eius fratres, amplissima familia nati adulescentes. Cum his praemium communicat hortaturque, ut se liberos et imperio natos meminerint. Unam esse Aeduorum civitatem, quae certissimam Galliae victoriam detineat; eius auctoritate reliquas contineri; qua traducta locum consistendi Romanis in Gallia non fore. Esse nonnullo se Caesaris beneficio adfectum, sic tamen, ut iustissimam apud eum causam obtinuerit; sed plus communi libertati tribuere. Cur enim potius Aedui de suo iure et de legibus ad Caesarem disceptatorem, quam Romani ad Aeduos veniant? Celeriter adulescentibus et oratione magistratus et praemio deductis, cum se vel principes eius consili fore profiterentur, ratio perficiendi quaerebatur, quod civitatem temere ad suscipiendum bellum adduci posse non confidebant. Placuit ut Litaviccus decem illis milibus, quae Caesari ad bellum mitterentur, praeficeretur atque ea ducenda curaret, fratresque eius ad Caesarem praecurrerent. Reliqua qua ratione agi placeat constituunt.
[38] Litaviccus accepto exercitu, cum milia passuum circiter XXX ab Gergovia abesset, convocatis subito militibus lacrimans, "Quo proficiscimur," inquit, "milites? Omnis noster equitatus, omnis nobilitas interiit; principes civitatis, Eporedorix et Viridomarus, insimulati proditionis ab Romanis indicta causa interfecti sunt. Haec ab ipsis cognoscite, qui ex ipsa caede fugerunt: nam ego fratribus atque omnibus meis propinquis interfectis dolore prohibeor, quae gesta sunt, pronuntiare." Producuntur hi quos ille edocuerat quae dici vellet, atque eadem, quae Litaviccus pronuntiaverat, multitudini exponunt: multos equites Aeduorum interfectos, quod collocuti cum Arvernis dicerentur; ipsos se inter multitudinem militum occultasse atque ex media caede fugisse. Conclamant Aedui et Litaviccum obsecrant ut sibi consulat. "Quasi vero," inquit ille, "consili sit res, ac non necesse sit nobis Gergoviam contendere et cum Arvernis nosmet coniungere. An dubitamus quin nefario facinore admisso Romani iam ad nos interficiendos concurrant? Proinde, si quid in nobis animi est, persequamur eorum mortem qui indignissime interierunt, atque hos latrones interficiamus." Ostendit cives Romanos, qui eius praesidi fiducia una erant: magnum numerum frumenti commeatusque diripit, ipsos crudeliter excruciatos interficit. Nuntios tota civitate Aeduorum dimittit, eodem mendacio de caede equitum et principum permovet; hortatur ut simili ratione atque ipse fecerit suas iniurias persequantur.
[39] Eporedorix Aeduus, summo loco natus adulescens et summae domi potentiae, et una Viridomarus, pari aetate et gratia, sed genere dispari, quem Caesar ab Diviciaeo sibi traditum ex humili loco ad summam dignitatem perduxerat, in equitum numero convenerant nominatim ab eo evocati. His erat inter se de principatu contentio, et in illa magistratuum controversia alter pro Convictolitavi, alter pro Coto summis opibus pugnaverant. Ex eis Eporedorix cognito Litavicci consilio media fere nocte rem ad Caesarem defert; orat ne patiatur civitatem pravis adulescentium consiliis ab amicitia populi Romani deficere; quod futurum provideat, si se tot hominum milia cum hostibus coniunxerint, quorum salutem neque propinqui neglegere, neque civitas levi momento aestimare posset.
[40] Magna adfectus sollicitudine hoc nuntio Caesar, quod semper Aeduorum civitati praecipue indulserat, nulla interposita dubitatione legiones expeditas quattuor equitatumque omnem ex castris educit; nec fuit spatium tali tempore ad contrahenda castra, quod res posita in celeritate videbatur; Gaium Fabium legatum eum legionibus duabus castris praesidio relinquit. Fratres Litavicci eum comprehendi iussisset, paulo ante reperit ad hostes fugisse. Adhortatus milites, ne necessario tempore itineris labore permoveantur, cupidissimis omnibus progressus milia passuum XXV agmen Aeduorum conspicatus immisso equitatu iter eorum moratur atque impedit interdicitque omnibus ne quemquam interficiant. Eporedorigem et Viridomarum, quos illi interfectos existimabant, inter equites versari suosque appellare iubet. His cognitis et Litavicci fraude perspecta Aedui manus tendere, deditionem significare et proiectis armis mortem deprecari incipiunt. Litaviccus cum suis clientibus, quibus more Gallorum nefas est etiam in extrema fortuna deserere patronos, Gergoviam profugit.
[41] Caesar nuntiis ad civitatem Aeduorum missis, qui suo beneficio conservatos docerent quos iure belli interficere potuisset, tribusque horis noctis exercitui ad quietem datis castra ad Gergoviam movit. Medio fere itinere equites a Fabio missi, quanto res in periculo fuerit, exponunt. Summis copiis castra oppugnata demonstrant, cum crebro integri defessis succederent nostrosque assiduo labore defatigarent, quibus propter magnitudinem castrorum perpetuo esset isdem in vallo permanendum. Multitudine sagittarum atque omnis generis telorum multos vulneratos; ad haec sustinenda magno usui fuisse tormenta. Fabium discessu eorum duabus relictis portis obstruere ceteras pluteosque vallo addere et se in posterum diem similemque casum apparare. His rebus cognitis Caesar summo studio militum ante ortum solis in castra pervenit.
[42] Dum haec ad Gergoviam geruntur, Aedui primis nuntiis ab Litavicco acceptis nullum sibi ad cognoscendum spatium relinquunt. Impellit alios avaritia, alios iracundia et temeritas, quae maxime illi hominum generi est innata, ut levem auditionem habeant pro re comperta. Bona civium Romanorum diripiunt, caedes faciunt, in servitutem abstrahunt. Adiuvat rem proclinatam Convictolitavis plebemque ad furorem impellit, ut facinore admisso ad sanitatem reverti pudeat. Marcum Aristium, tribunum militum, iter ad legionem facientem fide data ex oppido Cabillono educunt: idem facere cogunt eos, qui negotiandi causa ibi constiterant. Hos continuo (in) itinere adorti omnibus impedimentis exuunt; repugnantes diem noctemque obsident; multis utrimque interfectis maiorem multitudinem armatorum concitant.
[43] Interim nuntio allato omnes eorum milites in potestate Caesaris teneri, concurrunt ad Aristium, nihil publico factum consilio demonstrant; quaestionem de bonis direptis decernunt, Litavicci fatrumque bona publicant, legatos ad Caesarem sui purgandi gratia mittunt. Haec faciunt reciperandorum suorum causa; sed contaminati facinore et capti compendio ex direptis bonis, quod ea res ad multos pertinebat, timore poenae exterriti consilia clam de bello inire incipiunt civitatesque reliquas legationibus sollicitant. Quae tametsi Caesar intellegebat, tamen quam mitissime potest legatos appellat: nihil se propter inscientiam levitatemque vulgi gravius de civitate iudicare neque de sua in Aeduos benevolentia deminuere. Ipse maiorem Galliae motum exspectans, ne ab omnibus civitatibus circumsisteretur, consilia inibat quemadmodum ab Gergovia discederet ac rursus omnem exercitum contraheret, ne profectio nata ab timore defectionis similis fugae videretur.
[44] Haec cogitanti accidere visa est facultas bene rei gerendae. Nam cum in minora castra operis perspiciendi causa venisset, animadvertit collem, qui ab hostibus tenebatur, nudatum hominibus, qui superioribus diebus vix prae multitudine cerni poterat. Admiratus quaerit ex perfugis causam, quorum magnus ad eum cotidie numerus confluebat. Constabat inter omnes, quod iam ipse Caesar per exploratores cognoverat, dorsum esse eius iugi prope aequum, sed hunc silvestrem et angustum, qua esset aditus ad alteram partem oppidi; huic loco vehementer illos timere nec iam aliter sentire, uno colle ab Romanis occupato, si alterum amisissent, quin paene circumvallati atque omni exitu et pabulatione interclusi viderentur: ad hunc muniendum omnes a Vercingetorige evocatos.
[45] Hac re cognita Caesar mittit complures equitum turmas; eis de media nocte imperat, ut paulo tumultuosius omnibus locis vagarentur. Prima luce magnum numerum impedimentorum ex castris mulorumque produci deque his stramenta detrahi mulionesque cum cassidibus equitum specie ac simulatione collibus circumvehi iubet. His paucos addit equites qui latius ostentationis causa vagarentur. Longo circuitu easdem omnes iubet petere regiones. Haec procul ex oppido videbantur, ut erat a Gergovia despectus in castra, neque tanto spatio certi quid esset explorari poterat. Legionem unam eodem iugo mittit et paulum progressam inferiore constituit loco silvisque occultat. Augetur Gallis suspicio, atque omnes illo ad munitionem copiae traducuntur. Vacua castra hostium Caesar conspicatus tectis insignibus suorum occultatisque signis militaribus raros milites, ne ex oppido animadverterentur, ex maioribus castris in minora traducit legatisque, quos singulis legionibus praefecerat, quid fieri velit ostendit: in primis monet ut contineant milites, ne studio pugnandi aut spe praedae longius progrediantur; quid iniquitas loci habeat incommodi proponit: hoc una celeritate posse mutari; occasionis esse rem, non proeli. His rebus eitis signum dat et ab dextra parte alio ascensu eodem tempore Aeduos mittit.
[46] Oppidi murus ab planitie atque initio ascensus recta regione, si nullus anfractus intercederet, MCC passus aberat: quidquid huc circuitus ad molliendum clivum accesserat, id spatium itineris augebat. A medio fere colle in longitudinem, ut natura montis ferebat, ex grandibus saxis sex pedum murum qui nostrorum impetum tardaret praeduxerant Galli, atque inferiore omni spatio vacuo relicto superiorem partem collis usque ad murum oppidi densissimis castris compleverant. Milites dato signo celeriter ad munitionem perveniunt eamque transgressi trinis castris potiuntur; ac tanta fuit in castris capiendis celeritas, ut Teutomatus, rex Nitiobrigum, subito in tabernaculo oppressus, ut meridie conquieverat, superiore corporis parte nudata vulnerato equo vix se ex manibus praedantium militum eriperet.
[47] Consecutus id quod animo proposuerat, Caesar receptui cani iussit legionique decimae, quacum erat, continuo signa constituit. Ac reliquarum legionum milites non exaudito sono tubae, quod satis magna valles intercedebat, tamen ab tribunis militum legatisque, ut erat a Caesare praeceptum, retinebantur. Sed elati spe celeris victoriae et hostium fuga et superiorum temporum secundis proeliis nihil adeo arduum sibi esse existimaverunt quod non virtute consequi possent, neque finem prius sequendi fecerunt quam muro oppidi portisque appropinquarunt. Tum vero ex omnibus urbis partibus orto clamore, qui longius aberant repentino tumultu perterriti, cum hostem intra portas esse existimarent, sese ex oppido eiecerunt. Matres familiae de muro vestem argentumque iactabant et pectore nudo prominentes passis manibus obtestabantur Romanos, ut sibi parcerent neu, sicut Avarici fecissent, ne a mulieribus quidem atque infantibus abstinerent: nonnullae de muris per manus demissae sese militibus tradebant. Lucius Fabius, centurio legionis VIII, quem inter suos eo die dixisse constabat excitari se Avaricensibus praemiis neque commissurum, ut prius quisquam murum ascenderet, tres suos nactus manipulares atque ab eis sublevatus murum ascendit: hos ipse rursus singulos exceptans in murum extulit.
[48] Interim ei qui ad alteram partem oppidi, ut supra demonstravimus, munitionis causa convenerant, primo exaudito clamore, inde etiam crebris nuntiis incitati, oppidum a Romanis teneri, praemissis equitibus magno concursu eo contenderunt. Eorum ut quisque primus venerat, sub muro consistebat suorumque pugnantium numerum augebat. Quorum cum magna multitudo convenisset, matres familiae, quae paulo ante Romanis de muro manus tendebant, suos obtestari et more Gallico passum capillum ostentare liberosque in conspectum proferre coeperunt. Erat Romanis nec loco nec numero aequa contentio; simul et cursu et spatio pugnae defatigati non facile recentes atque integros sustinebant.
[49] Caesar, cum iniquo loco pugnari hostiumque augeri copias videret, praemetuens suis ad Titum Sextium legatum, quem minoribus castris praesidio reliquerat, misit, ut cohortes ex castris celeriter educeret et sub infimo colle ab dextro latere hostium constitueret, ut, si nostros loco depulsos vidisset, quo minus libere hostes insequerentur terreret. Ipse paulum ex eo loco cum legione progressus, ubi constiterat, eventum pugnae exspectabat.
[50] Cum acerrime comminus pugnaretur, hostes loco et numero, nostri virtute confiderent, subito sunt Aedui visi ab latere nostris aperto, quos Caesar ab dextra parte alio ascensu manus distinendae causa miserat. Hi similitudine armorum vehementer nostros perterruerunt, ac tametsi dextris humeris exsertis animadvertebantur, quod insigne +pacatum+ esse consuerat, tamen id ipsum sui fallendi causa milites ab hostibus factum existimabant. Eodem tempore Lucius Fabius centurio quique una murum ascenderant circumventi atque interfecti muro praecipitabantur. Marcus Petronius, eiusdem legionis centurio, cum portam excidere conatus esset, a multitudine oppressus ac sibi desperans multis iam vulneribus acceptis manipularibus suis, qui illum secuti erant, "Quoniam," inquit, "me una vobiscum servare non possum, vestrae quidem certe vitae prospiciam, quos cupiditate gloriae adductus in periculum deduxi. Vos data facultate vobis consulite." Simul in medios hostes irrupit duobusque interfectis reliquos a porta paulum summovit. Conantibus auxiliari suis "Frustra," inquit, "meae vitae subvenire conamini, quem iam sanguis viresque deficiunt. Proinde abite, dum est facultas, vosque ad legionem recipite." Ita puguans post paulum concidit ac suis saluti fuit.
[51] Nostri, cum undique premerentur, XLVI centurionibus amissis deiecti sunt loco. Sed intolerantius Gallos insequentes legio decima tardavit, quae pro subsidio paulo aequiore loco constiterat. Hanc rursus XIII legionis cohortes exceperunt, quae ex castris minoribus eductae cum Tito Sextio legato ceperant locum superiorem. Legiones, ubi primum planitiem attigerunt, infestis contra hostes signis constiterunt. Vercingetorix ab radicibus collis suos intra munitiones reduxit. Eo die milites sunt paulo minus septingenti desiderati.
[52] Postero die Caesar contione advocata temeritatem cupiditatemque militum reprehendit, quod sibi ipsi iudicavissent quo procedendum aut quid agendum videretur, neque signo recipiendi dato constitissent neque ab tribunis militum legatisque retineri potuissent. Euit quid iniquitas loci posset, quid ipse ad Avaricum sensisset, cum sine duce et sine equitatu deprehensis hostibus exploratam victoriam dimisisset, ne parvum modo detrimentum in contentione propter iniquitatem loci accideret. Quanto opere eorum animi magnitudinem admiraretur, quos non castrorum munitiones, non altitudo montis, non murus oppidi tardare potuisset, tanto opere licentiam arrogantiamque reprehendere, quod plus se quam imperatorem de victoria atque exitu rerum sentire existimarent; nec minus se ab milite modestiam et continentiam quam virtutem atque animi magnitudinem desiderare.
[53] Hac habita contione et ad extremam orationem confirmatis militibus, ne ob hanc causam animo permoverentur neu quod iniquitas loci attulisset id virtuti hostium tribuerent, eadem de profectione cogitans quae ante senserat legiones ex castris eduxit aciemque idoneo loco constituit. Cum Vercingetorix nihil magis in aequum locum descenderet, levi facto equestri proelio atque secundo in castra exercitum reduxit. Cum hoc idem postero die fecisset, satis ad Gallicam ostentationem minuendam militumque animos confirmandos factum existimans in Aeduos movit castra. Ne tum quidem insecutis hostibus tertio die ad flumen Elaver venit; pontem refecit exercitumque traduxit.
[54] Ibi a Viridomaro atque Eporedorige Aeduis appellatus discit cum omni equitatu Litaviccum ad sollicitandos Aeduos profectum: opus esse ipsos antecedere ad confirmandam civitatem. Etsi multis iam rebus perfidiam Aeduorum perspectam habebat atque horum discessu admaturari defectionem civitatis existimabat, tamen eos retinendos non constituit, ne aut inferre iniuriam videretur aut dare timoris aliquam suspicionem. Discedentibus his breviter sua in Aeduos merita euit, quos et quam humiles accepisset, compulsos in oppida, multatos agris omnibus ereptis copiis, imposito stipendio, obsidibus summa cum contumelia extortis, et quam in fortunam quamque in amplitudinem deduxisset, ut non solum in pristinum statum redissent, sed omnium temporum dignitatem et gratiam antecessisse viderentur. His datis mandatis eos ab se dimisit.
[55] Noviodunum erat oppidum Aeduorum ad ripas Ligeris opportuno loco positum. Huc Caesar omnes obsides Galliae, frumentum, pecuniam publicam, suorum atque exercitus impedimentorum magnam partem contulerat; huc magnum numerum equorum huius belli causa in Italia atque Hispania coemptum miserat. Eo cum Eporedorix Viridomarusque venissent et de statu civitatis cognovissent, Litaviccum Bibracti ab Aeduis receptum, quod est oppidum apud eos maximae auctoritatis, Convictolitavim magistratum magnamque partem senatus ad eum convenisse, legatos ad Vercingetorigem de pace et amicitia concilianda publice missos, non praetermittendum tantum commodum existimaverunt. Itaque interfectis Novioduni custodibus quique eo negotiandi causa convenerant pecuniam atque equos inter se partiti sunt; obsides civitatum Bibracte ad magistratum deducendos curaverunt; oppidum, quod a se teneri non posse iudicabant, ne cui esset usui Romanis, incenderunt; frumenti quod subito potuerunt navibus avexerunt, reliquum flumine atque incendio corruperunt. Ipsi ex finitimis regionibus copias cogere, praesidia custodiasque ad ripas Ligeris disponere equitatumque omnibus locis iniciendi timoris causa ostentare coeperunt, si ab re frumentaria Romanos excludere aut adductos inopia in provinciam expellere possent. Quam ad spem multum eos adiuvabat, quod Liger ex nivibus creverat, ut omnino vado non posse transiri videretur.
[56] Quibus rebus cognitis Caesar maturandum sibi censuit, si esset in perficiendis pontibus periclitandum, ut prius quam essent maiores eo coactae copiae dimicaret. Nam ut commutato consilio iter in provinciam converteret, id ne metu quidem necessario faciendum existimabat; cum infamia atque indignitas rei et oppositus mons Cevenna viarumque difficultas impediebat, tum maxime quod abiuncto Labieno atque eis legionibus quas una miserat vehementer timebat. Itaque admodum magnis diurnis nocturnisque itineribus confectis contra omnium opinionem ad Ligerem venit vadoque per equites invento pro rei necessitate opportuno, ut brachia modo atque humeri ad sustinenda arma liberi ab aqua esse possent, disposito equitatu qui vim fluminis refringeret, atque hostibus primo aspectu perturbatis, incolumem exercitum traduxit frumentumque in agris et pecoris copiam nactus repleto his rebus exercitu iter in Senones facere instituit.
[57] Dum haec apud Caesarem geruntur, Labienus eo supplemento, quod nuper ex Italia venerat, relicto Agedinci, ut esset impedimentis praesidio, cum quattuor legionibus Lutetiam proficiscitur. Id est oppidum Parisiorum, quod positum est in insula fluminis Sequanae. Cuius adventu ab hostibus cognito magnae ex finitimis civitatibus copiae convenerunt. Summa imperi traditur Camulogeno Aulerco, qui prope confectus aetate tamen propter singularem scientiam rei militaris ad eum est honorem evocatus. Is cum animadvertisset perpetuam esse paludem, quae influeret in Sequanam atque illum omnem locum magnopere impediret, hic consedit nostrosque transitu prohibere instituit.
[58] Labienus primo vineas agere, cratibus atque aggere paludem explere atque iter munire conabatur. Postquam id difficilius confieri animadvertit, silentio e castris tertia vigilia egressus eodem quo venerat itinere Metiosedum pervenit. Id est oppidum Senonum in insula Sequanae positum, ut paulo ante de Lutetia diximus. Deprensis navibus circiter quinquaginta celeriterque coniunctis atque eo militibus iniectis et rei novitate perterritis oppidanis, quorum magna pars erat ad bellum evocata, sine contentione oppido potitur. Refecto ponte, quem superioribus diebus hostes resciderant, exercitum traducit et secundo flumine ad Lutetiam iter facere coepit. Hostes re cognita ab eis, qui Metiosedo fugerant, Lutetiam incendi pontesque eius oppidi rescindi iubent; ipsi profecti a palude ad ripas Sequanae e regione Lutetiae contra Labieni castra considunt.
[59] Iam Caesar a Gergovia discessisse audiebatur, iam de Aeduorum defectione et secundo Galliae motu rumores adferebantur, Gallique in colloquiis interclusum itinere et Ligeri Caesarem inopia frumenti coactum in provinciam contendisse confirmabant. Bellovaci autem defectione Aeduorum cognita, qui ante erant per se infideles, manus cogere atque aperte bellum parare coeperunt. Tum Labienus tanta rerum commutatione longe aliud sibi capiendum consilium atque antea senserat intellegebat, neque iam, ut aliquid adquireret proelioque hostes lacesseret, sed ut incolumem exercitum Agedincum reduceret, cogitabat. Namque altera ex parte Bellovaci, quae civitas in Gallia maximam habet opinionem virtutis, instabant, alteram Camulogenus parato atque instructo exercitu tenebat; tum legiones a praesidio atque impedimentis interclusas maximum flumen distinebat. Tantis subito difficultatibus obiectis ab animi virtute auxilium petendum videbat.
[60] Sub vesperum consilio convocato cohortatus ut ea quae imperasset diligenter industrieque administrarent, naves, quas Metiosedo deduxerat, singulas equitibus Romanis attribuit, et prima confecta vigilia quattuor milia passuum secundo flumine silentio progredi ibique se exspectari iubet. Quinque cohortes, quas minime firmas ad dimicandum esse existimabat, castris praesidio relinquit; quinque eiusdem legionis reliquas de media nocte cum omnibus impedimentis adverso flumine magno tumultu proficisci imperat. Conquirit etiam lintres: has magno sonitu remorum incitatus in eandem partem mittit. Ipse post paulo silentio egressus cum tribus legionibus eum locum petit quo naves appelli iusserat.
[61] Eo cum esset ventum, exploratores hostium, ut omni fluminis parte erant dispositi, inopinantes, quod magna subito erat coorta tempestas, ab nostris opprimumtur; exercitus equitatusque equitibus Romanis administrantibus, quos ei negotio praefecerat, celeriter transmittitur. Uno fere tempore sub lucem hostibus nuntiatur in castris Romanorum praeter consuetudinem tumultuari et magnum ire agmen adverso flumine sonitumque remorum in eadem parte exaudiri et paulo infra milites navibus transportari. Quibus rebus auditis, quod existimabant tribus locis transire legiones atque omnes perturbatos defectione Aeduorum fugam parare, suas quoque copias in tres partes distribuerunt. Nam praesidio e regione castrorum relicto et parva manu Metiosedum versus missa, quae tantum progrediatur, quantum naves processissent, reliquas copias contra Labienum duxerunt.
[62] Prima luce et nostri omnes erant transportati, et hostium acies cernebatur. Labienus milites cohortatus ut suae pristinae virtutis et secundissimorum proeliorum retinerent memoriam atque ipsum Caesarem, cuius ductu saepe numero hostes superassent, praesentem adesse existimarent, dat signum proeli. Primo concursu ab dextro cornu, ubi septima legio constiterat, hostes pelluntur atque in fugam coniciuntur; ab sinistro, quem locum duodecima legio tenebat, cum primi ordines hostium transfixi telis concidissent, tamen acerrime reliqui resistebant, nec dabat suspicionem fugae quisquam. Ipse dux hostium Camulogenus suis aderat atque eos cohortabatur. Incerto nunc etiam exitu victoriae, cum septimae legionis tribunis esset nuntiatum quae in sinistro cornu gererentur, post tergum hostium legionem ostenderunt signaque intulerunt. Ne eo quidem tempore quisquam loco cessit, sed circumventi omnes interfectique sunt. Eandem fortunam tulit Camulogenus. At ei qui praesidio contra castra Labieni erant relicti, cum proelium commissum audissent, subsidio suis ierunt collemque ceperunt, neque nostrorum militum victorum impetum sustinere potuerunt. Sic cum suis fugientibus permixti, quos non silvae montesque texerunt, ab equitatu sunt interfecti. Hoc negotio confecto Labienus revertitur Agedincum, ubi impedimenta totius exercitus relicta erant: inde cum omnibus copiis ad Caesarem pervenit.
[63] Defectione Aeduorum cognita bellum augetur. Legationes in omnes partes circummittuntur: quantum gratia, auctoritate, pecunia valent, ad sollicitandas civitates nituntur; nacti obsides, quos Caesar apud eos deposuerat, horum supplicio dubitantes territant. Petunt a Vercingetorige Aedui ut ad se veniat rationesque belli gerendi communicet. Re impetrata contendunt ut ipsis summa imperi tradatur, et re in controversiam deducta totius Galliae concilium Bibracte indicitur. Eodem conveniunt undique frequentes. Multitudinis suffragiis res permittitur: ad unum omnes Vercingetorigem probant imperatorem. Ab hoc concilio Remi, Lingones, Treveri afuerunt: illi, quod amicitiam Romanorum sequebantur; Treveri, quod aberant longius et ab Germanis premebantur, quae fuit causa quare toto abessent bello et neutris auxilia mitterent. Magno dolore Aedui ferunt se deiectos principatu, queruntur fortunae commutationem et Caesaris indulgentiam in se requirunt, neque tamen suscepto bello suum consilium ab reliquis separare audent. Inviti summae spei adulescentes Eporedorix et Viridomarus Vercingetorigi parent.
[64] Ipse imperat reliquis civitatibus obsides diemque ei rei constituit. Omnes equites, quindecim milia numero, celeriter convenire iubet; peditatu quem antea habuerit se fore contentum dicit, neque fortunam temptaturum aut in acie dimicaturum, sed, quoniam abundet equitatu, perfacile esse factu frumentationibus pabulationibusque Romanos prohibere, aequo modo animo sua ipsi frumenta corrumpant aedificiaque incendant, qua rei familiaris iactura perpetuum imperium libertatemque se consequi videant. His constitutis rebus Aeduis Segusiavisque, qui sunt finitimi provinciae, decem milia peditum imperat; huc addit equites octingentos. His praeficit fratrem Eporedorigis bellumque inferri Allobrogibus iubet. Altera ex parte Gabalos proximosque pagos Arvernorum in Helvios, item Rutenos Cadurcosque ad fines Volcarum Arecomicorum depopulandos mittit. Nihilo minus clandestinis nuntiis legationibusque Allobrogas sollicitat, quorum mentes nondum ab superiore bello resedisse sperabat. Horum principibus pecunias, civitati autem imperium totius provinciae pollicetur.
[65] Ad hos omnes casus provisa erant praesidia cohortium duarum et viginti, quae ex ipsa provincia ab Lucio Caesare legato ad omnes partes opponebantur. Helvii sua sponte cum finitimis proelio congressi pelluntur et Gaio Valerio Donnotauro, Caburi filio, principe civitatis, compluribusque aliis interfectis intra oppida ac muros compelluntur. Allobroges crebris ad Rhodanum dispositis praesidiis magna cum cura et diligentia suos fines tuentur. Caesar, quod hostes equitatu superiores esse intellegebat et interclusis omnibus itineribus nulla re ex provincia atque Italia sublevari poterat, trans Rhenum in Germaniam mittit ad eas civitates quas superioribus annis pacaverat, equitesque ab his arcessit et levis armaturae pedites, qui inter eos proeliari consuerant. Eorum adventu, quod minus idoneis equis utebantur, a tribunis militum reliquisque equitibus Romanis atque evocatis equos sumit Germanisque distribuit.
[66] Interea, dum haec geruntur, hostium copiae ex Arvernis equitesque qui toti Galliae erant imperati conveniunt. Magno horum coacto numero, cum Caesar in Sequanos per extremos Lingonum fines iter faceret, quo facilius subsidium provinciae ferri posset, circiter milia passuum decem ab Romanis trinis castris Vercingetorix consedit convocatisque ad concilium praefectis equitum venisse tempus victoriae demonstrat. Fugere in provinciam Romanos Galliaque excedere. Id sibi ad praesentem obtinendam libertatem satis esse; ad reliqui temporis pacem atque otium parum profici: maioribus enim coactis copiis reversuros neque finem bellandi facturos. Proinde agmine impeditos adorirantur. Si pedites suis auxilium ferant atque in eo morentur, iter facere non posse; si, id quod magis futurum confidat, relictis impedimentis suae saluti consulant, et usu rerum necessariarum et dignitate spoliatum iri. Nam de equitibus hostium, quin nemo eorum progredi modo extra agmen audeat, et ipsos quidem non debere dubitare, et quo maiore faciant animo, copias se omnes pro castris habiturum et terrori hostibus futurum. Conclamant equites sanctissimo iureiurando confirmari oportere, ne tecto recipiatur, ne ad liberos, ne ad parentes, ad uxorem aditum habeat, qui non bis per agmen hostium perequitasset.
[67] Probata re atque omnibus iureiurando adactis postero die in tres partes distributo equitatu duae se acies ab duobus lateribus ostendunt, una primo agmine iter impedire coepit. Qua re nuntiata Caesar suum quoque equitatum tripertito divisum contra hostem ire iubet. Pugnatur una omnibus in partibus. Consistit agmen; impedimenta intra legiones recipiuntur. Si qua in parte nostri laborare aut gravius premi videbantur, eo signa inferri Caesar aciemque constitui iubebat; quae res et hostes ad insequendum tardabat et nostros spe auxili confirmabat. Tandem Germani ab dextro latere summum iugum nacti hostes loco depellunt; fugientes usque ad flumen, ubi Vercingetorix cum pedestribus copiis consederat, persequuntur compluresque interficiunt. Qua re animadversa reliqui ne circumirentur veriti se fugae mandant. Omnibus locis fit caedes. Tres nobilissimi Aedui capti ad Caesarem perducuntur: Cotus, praefectus equitum, qui controversiam cum Convictolitavi proximis comitiis habuerat, et Cavarillus, qui post defectionem Litavicci pedestribus copiis praefuerat, et Eporedorix, quo duce ante adventum Caesaris Aedui cum Sequanis bello contenderant.
[68] Fugato omni equitatu Vercingetorix copias, ut pro castris collocaverat, reduxit protinusque Alesiam, quod est oppidum Mandubiorum, iter facere coepit celeriterque impedimenta ex castris educi et se subsequi iussit. Caesar impedimentis in proximum collem deductis, duabus legionibus praesidio relictis, secutus quantum diei tempus est passum, circiter tribus milibus hostium ex novissimo agmine interfectis altero die ad Alesiam castra fecit. Perspecto urbis situ perterritisque hostibus, quod equitatu, qua maxime parte exercitus confidebant, erant pulsi, adhortatus ad laborem milites circumvallare instituit.
[69] Ipsum erat oppidum Alesia in colle summo admodum edito loco, ut nisi obsidione expugnari non posse videretur; cuius collis radices duo duabus ex partibus flumina subluebant. Ante id oppidum planities circiter milia passuum tria in longitudinem patebat: reliquis ex omnibus partibus colles mediocri interiecto spatio pari altitudinis fastigio oppidum cingebant. Sub muro, quae pars collis ad orientem solem spectabat, hunc omnem locum copiae Gallorum compleverant fossamque et maceriam sex in altitudinem pedum praeduxerant. Eius munitionis quae ab Romanis instituebatur circuitus XI milia passuum tenebat. Castra opportunis locis erant posita ibique castella viginti tria facta, quibus in castellis interdiu stationes ponebantur, ne qua subito eruptio fieret: haec eadem noctu excubitoribus ac firmis praesidiis tenebantur.
[70] Opere instituto fit equestre proelium in ea planitie, quam intermissam collibus tria milia passuum in longitudinem patere supra demonstravimus. Summa vi ab utrisque contenditur. Laborantibus nostris Caesar Germanos summittit legionesque pro castris constituit, ne qua subito irruptio ab hostium peditatu fiat. Praesidio legionum addito nostris animus augetur: hostes in fugam coniecti se ipsi multitudine impediunt atque angustioribus portis relictis coacervantur. Germani acrius usque ad munitiones sequuntur. Fit magna caedes: nonnulli relictis equis fossam transire et maceriam transcendere conantur. Paulum legiones Caesar quas pro vallo constituerat promoveri iubet. Non minus qui intra munitiones erant perturbantur Galli: veniri ad se confestim existimantes ad arma conclamant; nonnulli perterriti in oppidum irrumpunt. Vercingetorix iubet portas claudi, ne castra nudentur. Multis interfectis, compluribus equis captis Germani sese recipiunt.
[71] Vercingetorix, priusquam munitiones ab Romanis perficiantur, consilium capit omnem ab se equitatum noctu dimittere. Discedentibus mandat ut suam quisque eorum civitatem adeat omnesque qui per aetatem arma ferre possint ad bellum cogant. Sua in illos merita proponit obtestaturque ut suae salutis rationem habeant neu se optime de communi libertate meritum in cruciatum hostibus dedant. Quod si indiligentiores fuerint, milia hominum delecta octoginta una secum interitura demonstrat. Ratione inita se exigue dierum triginta habere frumentum, sed paulo etiam longius tolerari posse parcendo. His datis mandatis, qua opus erat intermissum, secunda vigilia silentio equitatum mittit. Frumentum omne ad se referri iubet; capitis poenam eis qui non paruerint constituit: pecus, cuius magna erat copia ab Mandubiis compulsa, viritim distribuit; frumentum parce et paulatim metiri instituit; copias omnes quas pro oppido collocaverat in oppidum recepit. His rationibus auxilia Galliae exspectare et bellum parat administrare.
[72] Quibus rebus cognitis ex perfugis et captivis, Caesar haec genera munitionis instituit. Fossam pedum viginti directis lateribus duxit, ut eius fossae solum tantundem pateret quantum summae fossae labra distarent. Reliquas omnes munitiones ab ea fossa pedes quadringentos reduxit,
[id] hoc consilio, quoniam tantum esset necessario spatium complexus, nec facile totum corpus corona militum cingeretur, ne de improviso aut noctu ad munitiones hostium multitudo advolaret aut interdiu tela in nostros operi destinatos conicere possent. Hoc intermisso spatio duas fossas quindecim pedes latas, eadem altitudine perduxit, quarum interiorem campestribus ac demissis locis aqua ex flumine derivata complevit. Post eas aggerem ac vallum duodecim pedum exstruxit. Huic loricam pinnasque adiecit grandibus cervis eminentibus ad commissuras pluteorum atque aggeris, qui ascensum hostium tardarent, et turres toto opere circumdedit, quae pedes LXXX inter se distarent.
[73] Erat eodem tempore et materiari et frumentari et tantas munitiones fieri necesse deminutis nostris copiis quae longius ab castris progrediebantur: ac non numquam opera nostra Galli temptare atque eruptionem ex oppido pluribus portis summa vi facere conabantur. Quare ad haec rursus opera addendum Caesar putavit, quo minore numero militum munitiones defendi possent. Itaque truncis arborum aut admodum firmis ramis abscisis atque horum delibratis ac praeacutis cacuminibus perpetuae fossae quinos pedes altae ducebantur. Huc illi stipites demissi et ab infimo revincti, ne revelli possent, ab ramis eminebant. Quini erant ordines coniuncti inter se atque implicati; quo qui intraverant, se ipsi acutissimis vallis induebant. Hos cippos appellabant. Ante quos obliquis ordinibus in quincuncem dispositis scrobes tres in altitudinem pedes fodiebantur paulatim angustiore ad infimum fastigio. Huc teretes stipites feminis crassitudine ab summo praeacuti et praeusti demittebantur, ita ut non amplius digitis quattuor ex terra eminerent; simul confirmandi et stabiliendi causa singuli ab infimo solo pedes terra exculcabantur, reliqua pars scrobis ad occultandas insidias viminibus ac virgultis integebatur. Huius generis octoni ordines ducti ternos inter se pedes distabant. Id ex similitudine floris lilium appellabant. Ante haec taleae pedem longae ferreis hamis infixis totae in terram infodiebantur mediocribusque intermissis spatiis omnibus locis disserebantur; quos stimulos nominabant.
[74] His rebus perfectis regiones secutus quam potuit aequissimas pro loci natura quattuordecim milia passuum complexus pares eiusdem generis munitiones, diversas ab his, contra exteriorem hostem perfecit, ut ne magna quidem multitudine, si ita accidat, munitionum praesidia circumfundi possent; ac ne cum periculo ex castris egredi cogatur, dierum triginta pabulum frumentumque habere omnes convectum iubet.
[75] Dum haec apud Alesiam geruntur, Galli concilio principum indicto non omnes eos qui arma ferre possent, ut censuit Vercingetorix, convocandos statuunt, sed certum numerum cuique ex civitate imperandum, ne tanta multitudine confusa nec moderari nec discernere suos nec frumentandi rationem habere possent. Imperant Aeduis atque eorum clientibus, Segusiavis, Ambivaretis, Aulercis Brannovicibus, Blannoviis, milia XXXV; parem numerum Arvernis adiunctis Eleutetis, Cadurcis, Gabalis, Vellaviis, qui sub imperio Arvernorum esse consuerunt; Sequanis, Senonibus, Biturigibus, Santonis, Rutenis, Carnutibus duodena milia; Bellovacis X; totidem Lemovicibus; octona Pictonibus et Turonis et Parisiis et Helvetiis;
[Suessionibus,] Ambianis, Mediomatricis, Petrocoriis, Nerviis, Morinis, Nitiobrigibus quina milia; Aulercis Cenomanis totidem; Atrebatibus
[IIII milibus]; Veliocassis, Lexoviis et Aulercis Eburovicibus terna; Rauracis et Boiis bina;
[XXX milia] universis civitatibus, quae Oceanum attingunt quaeque eorum consuetudine Armoricae appellantur, quo sunt in numero Curiosolites, Redones, Ambibarii, Caletes, Osismi, Veneti, Lemovices, Venelli. Ex his Bellovaci suum numerum non compleverunt, quod se suo nomine atque arbitrio cum Romanis bellum gesturos dicebant neque cuiusquam imperio obtemperaturos; rogati tamen ab Commio pro eius hospitio duo milia una miserunt.
[76] Huius opera Commi, ut antea demonstravimus, fideli atque utili superioribus annis erat usus in Britannia Caesar; quibus ille pro meritis civitatem eius immunem esse iusserat, iura legesque reddiderat atque ipsi Morinos attribuerat. Tamen tanta universae Galliae consensio fuit libertatis vindicandae et pristinae belli laudis recuperandae, ut neque beneficiis neque amicitiae memoria moverentur, omnesque et animo et opibus in id bellum incumberent. Coactis equitum VIII milibus et peditum circiter CCL haec in Aeduorum finibus recensebantur, numerusque inibatur, praefecti constituebantur. Commio Atrebati, Viridomaro et Eporedorigi Aeduis, Vercassivellauno Arverno, consobrino Vercingetorigis, summa imperi traditur. His delecti ex civitatibus attribuuntur, quorum consilio bellum administraretur. Omnes alacres et fiduciae pleni ad Alesiam proficiscuntur, neque erat omnium quisquam qui aspectum modo tantae multitudinis sustineri posse arbitraretur, praesertim ancipiti proelio, cum ex oppido eruptione pugnaretur, foris tantae copiae equitatus peditatusque cernerentur.
[77] At ei, qui Alesiae obsidebantur praeterita die, qua auxilia suorum exspectaverant, consumpto omni frumento, inscii quid in Aeduis gereretur, concilio coacto de exitu suarum fortunarum consultabant. Ac variis dictis sententiis, quarum pars deditionem, pars, dum vires suppeterent, eruptionem censebat, non praetereunda oratio Critognati videtur propter eius singularem et nefariam crudelitatem. Hic summo in Arvernis ortus loco et magnae habitus auctoritatis, "Nihil," inquit, "de eorum sententia dicturus sum, qui turpissimam servitutem deditionis nomine appellant, neque hos habendos civium loco neque ad concilium adhibendos censeo. Cum his mihi res sit, qui eruptionem probant; quorum in consilio omnium vestrum consensu pristinae residere virtutis memoria videtur. Animi est ista mollitia, non virtus, paulisper inopiam ferre non posse. Qui se ultro morti offerant facilius reperiuntur quam qui dolorem patienter ferant. Atque ego hanc sententiam probarem (tantum apud me dignitas potest), si nullam praeterquam vitae nostrae iacturam fieri viderem: sed in consilio capiendo omnem Galliam respiciamus, quam ad nostrum auxilium concitavimus. Quid hominum milibus LXXX uno loco interfectis propinquis consanguineisque nostris animi fore existimatis, si paene in ipsis cadaveribus proelio decertare cogentur? Nolite hos vestro auxilio exspoliare, qui vestrae salutis causa suum periculum neglexerunt, nec stultitia ac temeritate vestra aut animi imbecillitate omnem Galliam prosternere et perpetuae servituti subicere. An, quod ad diem non venerunt, de eorum fide constantiaque dubitatis? Quid ergo? Romanos in illis ulterioribus munitionibus animine causa cotidie exerceri putatis? Si illorum nuntiis confirmari non potestis omni aditu praesaepto, his utimini testibus appropinquare eorum adventum; cuius rei timore exterriti diem noctemque in opere versantur. Quid ergo mei consili est? Facere, quod nostri maiores nequaquam pari bello Cimbrorum Teutonumque fecerunt; qui in oppida compulsi ac simili inopia subacti eorum corporibus qui aetate ad bellum inutiles videbantur vitam toleraverunt neque se hostibus tradiderunt. Cuius rei si exemplum non haberemus, tamen libertatis causa institui et posteris prodi pulcherrimum iudicarem. Nam quid illi simile bello fuit? Depopulata Gallia Cimbri magnaque illata calamitate finibus quidem nostris aliquando excesserunt atque alias terras petierunt; iura, leges, agros, libertatem nobis reliquerunt. Romani vero quid petunt aliud aut quid volunt, nisi invidia adducti, quos fama nobiles potentesque bello cognoverunt, horum in agris civitatibusque considere atque his aeternam iniungere servitutem? Neque enim ulla alia condicione bella gesserunt. Quod si ea quae in longinquis nationibus geruntur ignoratis, respicite finitimam Galliam, quae in provinciam redacta iure et legibus commutatis securibus subiecta perpetua premitur servitute."
[78] Sententiis dictis constituunt ut ei qui valetudine aut aetate inutiles sunt bello oppido excedant, atque omnia prius experiantur, quam ad Critognati sententiam descendant: illo tamen potius utendum consilio, si res cogat atque auxilia morentur, quam aut deditionis aut pacis subeundam condicionem. Mandubii, qui eos oppido receperant, cum liberis atque uxoribus exire coguntur. Hi, cum ad munitiones Romanorum accessissent, flentes omnibus precibus orabant, ut se in servitutem receptos cibo iuvarent. At Caesar dispositis in vallo custodibus recipi prohibebat.
[79] Interea Commius reliquique duces quibus summa imperi permissa erat cum omnibus copiis ad Alesiam perveniunt et colle exteriore occupato non longius mille passibus ab nostris munitionibus considunt. Postero die equitatu ex castris educto omnem eam planitiem, quam in longitudinem tria milia passuum patere demonstravimus, complent pedestresque copias paulum ab eo loco abditas in locis superioribus constituunt. Erat ex oppido Alesia despectus in campum. Concurrunt his auxiliis visis; fit gratulatio inter eos, atque omnium animi ad laetitiam excitantur. Itaque productis copiis ante oppidum considunt et proximam fossam cratibus integunt atque aggere explent seque ad eruptionem atque omnes casus comparant.
[80] Caesar omni exercitu ad utramque partem munitionum disposito, ut, si usus veniat, suum quisque locum teneat et noverit, equitatum ex castris educi et proelium committi iubet. Erat ex omnibus castris, quae summum undique iugum tenebant, despectus, atque omnes milites intenti pugnae proventum exspectabant. Galli inter equites raros sagittarios expeditosque levis armaturae interiecerant, qui suis cedentibus auxilio succurrerent et nostrorum equitum impetus sustinerent. Ab his complures de improviso vulnerati proelio excedebant. Cum suos pugna superiores esse Galli confiderent et nostros multitudine premi viderent, ex omnibus partibus et ei qui munitionibus continebantur et hi qui ad auxilium convenerant clamore et ululatu suorum animos confirmabant. Quod in conspectu omnium res gerebatur neque recte ac turpiter factum celari poterat, utrosque et laudis cupiditas et timor ignominiae ad virtutem excitabant. Cum a meridie prope ad solis occasum dubia victoria pugnaretur, Germani una in parte confertis turmis in hostes impetum fecerunt eosque propulerunt; quibus in fugam coniectis sagittarii circumventi interfectique sunt. Item ex reliquis partibus nostri cedentes usque ad castra insecuti sui colligendi facultatem non dederunt. At ei qui ab Alesia processerant maesti prope victoria desperata se in oppidum receperunt.
[81] Uno die intermisso Galli atque hoc spatio magno cratium, scalarum, harpagonum numero effecto media nocte silentio ex castris egressi ad campestres munitiones accedunt. Subito clamore sublato, qua significatione qui in oppido obsidebantur de suo adventu cognoscere possent, crates proicere, fundis, sagittis, lapidibus nostros de vallo proturbare reliquaque quae ad oppugnationem pertinent parant administrare. Eodem tempore clamore exaudito dat tuba signum suis Vercingetorix atque ex oppido educit. Nostri, ut superioribus diebus, ut cuique erat locus attributus, ad munitiones accedunt; fundis librilibus sudibusque quas in opere disposuerant ac glandibus Gallos proterrent. Prospectu tenebris adempto multa utrimque vulnera accipiuntur. Complura tormentis tela coniciuntur. At Marcus Antonius et Gaius Trebonius legati, quibus hae partes ad defendendum obvenerant, qua ex parte nostros premi intellexerant, his auxilio ex ulterioribus castellis deductos summittebant.
[82] Dum longius ab munitione aberant Galli, plus multitudine telorum proficiebant; posteaquam propius successerunt, aut se stimulis inopinantes induebant aut in scrobes delati transfodiebantur aut ex vallo ac turribus traiecti pilis muralibus interibant. Multis undique vulneribus acceptis nulla munitione perrupta, cum lux appeteret, veriti ne ab latere aperto ex superioribus castris eruptione circumvenirentur, se ad suos receperunt. At interiores, dum ea quae a Vercingetorige ad eruptionem praeparata erant proferunt, priores fossas explent, diutius in his rebus administrandis morati prius suos discessisse cognoverunt, quam munitionibus appropinquarent. Ita re infecta in oppidum reverterunt.
[83] Bis magno cum detrimento repulsi Galli quid agant consulunt; locorum peritos adhibent: ex his superiorum castrorum situs munitionesque cognoscunt. Erat a septentrionibus collis, quem propter magnitudinem circuitus opere circumplecti non potuerant nostri: necessario paene iniquo loco et leniter declivi castra fecerunt. Haec Gaius Antistius Reginus et Gaius Caninius Rebilus legati cum duabus legionibus obtinebant. Cognitis per exploratores regionibus duces hostium LX milia ex omni numero deligunt earum civitatum quae maximam virtutis opinionem habebant; quid quoque pacto agi placeat occulte inter se constituunt; adeundi tempus definiunt, cum meridies esse videatur. His copiis Vercassivellaunum Arvernum, unum ex quattuor ducibus, propinquum Vercingetorigis, praeficiunt. Ille ex castris prima vigilia egressus prope confecto sub lucem itinere post montem se occultavit militesque ex nocturno labore sese reficere iussit. Cum iam meridies appropinquare videretur, ad ea castra quae supra demonstravimus contendit; eodemque tempore equitatus ad campestres munitiones accedere et reliquae copiae pro castris sese ostendere coeperunt.
[84] Vercingetorix ex arce Alesiae suos conspicatus ex oppido egreditur; crates, longurios, musculos, falces reliquaque quae eruptionis causa paraverat profert. Pugnatur uno tempore omnibus locis, atque omnia temptantur: quae minime visa pars firma est, huc concurritur. Romanorum manus tantis munitionibus distinetur nec facile pluribus locis occurrit. Multum ad terrendos nostros valet clamor, qui post tergum pugnantibus exstitit, quod suum periculum in aliena vident salute constare: omnia enim plerumque quae absunt vehementius hominum mentes perturbant.
[85] Caesar idoneum locum nactus quid quaque ex parte geratur cognoscit; laborantibus summittit. Utrisque ad animum occurrit unum esse illud tempus, quo maxime contendi conveniat: Galli, nisi perfregerint munitiones, de omni salute desperant; Romani, si rem obtinuerint, finem laborum omnium exspectant. Maxime ad superiores munitiones laboratur, quo Vercassivellaunum missum demonstravimus. Iniquum loci ad declivitatem fastigium magnum habet momentum. Alii tela coniciunt, alii testudine facta subeunt; defatigatis in vicem integri succedunt. Agger ab universis in munitionem coniectus et ascensum dat Gallis et ea quae in terra occultaverant Romani contegit; nec iam arma nostris nec vires suppetunt.
[86] His rebus cognitis Caesar Labienum cum cohortibus sex subsidio laborantibus mittit: imperat, si sustinere non posset, deductis cohortibus eruptione pugnaret; id nisi necessario ne faciat. Ipse adit reliquos, cohortatur ne labori succumbant; omnium superiorum dimicationum fructum in eo die atque hora docet consistere. Interiores desperatis campestribus locis propter magnitudinem munitionum loca praerupta ex ascensu temptant: huc ea quae paraverant conferunt. Multitudine telorum ex turribus propugnantes deturbant, aggere et cratibus fossas explent, falcibus vallum ac loricam rescindunt.
[87] Mittit primo Brutum adulescentem cum cohortibus Caesar, post cum aliis Gaium Fabium legatum; postremo ipse, cum vehementius pugnaretur, integros subsidio adducit. Restituto proelio ac repulsis hostibus eo quo Labienum miserat contendit; cohortes quattuor ex proximo castello deducit, equitum partem sequi, partem circumire exteriores munitiones et ab tergo hostes adoriri iubet. Labienus, postquam neque aggeres neque fossae vim hostium sustinere poterant, coactis una XL cohortibus, quas ex proximis praesidus deductas fors obtulit, Caesarem per nuntios facit certiorem quid faciendum existimet. Accelerat Caesar, ut proelio intersit.
[88] Eius adventu ex colore vestitus cognito, quo insigni in proeliis uti consuerat, turmisque equitum et cohortibus visis quas se sequi iusserat, ut de locis superioribus haec declivia et devexa cernebantur, hostes proelium committunt. Utrimque clamore sublato excipit rursus ex vallo atque omnibus munitionibus clamor. Nostri omissis pilis gladiis rem gerunt. Repente post tergum equitatus cernitur; cohortes aliae appropinquant. Hostes terga vertunt; fugientibus equites occurrunt. Fit magna caedes. Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur; Vercassivellaunus Arvernus vivus in fuga comprehenditur; signa militaria septuaginta quattuor ad Caesarem referuntur: pauci ex tanto numero se incolumes in castra recipiunt. Conspicati ex oppido caedem et fugam suorum desperata salute copias a munitionibus reducunt. Fit protinus hac re audita ex castris Gallorum fuga. Quod nisi crebris subsidiis ac totius diei labore milites essent defessi, omnes hostium copiae deleri potuissent. De media nocte missus equitatus novissimum agmen consequitur: magnus numerus capitur atque interficitur; reliqui ex fuga in civitates discedunt.
[89] Postero die Vercingetorix concilio convocato id bellum se suscepisse non suarum necessitatium, sed communis libertatis causa demonstrat, et quoniam sit fortunae cedendum, ad utramque rem se illis offerre, seu morte sua Romanis satisfacere seu vivum tradere velint. Mittuntur de his rebus ad Caesarem legati. Iubet arma tradi, principes produci. Ipse in munitione pro castris consedit: eo duces producuntur; Vercingetorix deditur, arma proiciuntur. Reservatis Aeduis atque Arvernis, si per eos civitates reciperare posset, ex reliquis captivis toto exercitui capita singula praedae nomine distribuit.
[90] His rebus confectis in Aeduos proficiscitur; civitatem recipit. Eo legati ab Arvernis missi quae imperaret se facturos pollicentur. Imperat magnum numerum obsidum. Legiones in hiberna mittit. Captivorum circiter viginti milia Aeduis Arvernisque reddit. Titum Labienum duabus cum legionibus et equitatu in Sequanos proficisci iubet: huic Marcum Sempronium Rutilum attribuit. Gaium Fabium legatum et Lucium Minucium Basilum cum legionibus duabus in Remis collocat, ne quam ab finitimis Bellovacis calamitatem accipiant. Gaium Antistium Reginum in Ambivaretos, Titum Sextium in Bituriges, Gaium Caninium Rebilum in Rutenos cum singulis legionibus mittit. Quintum Tullium Ciceronem et Publium Sulpicium Cabilloni et Matiscone in Aeduis ad Ararim rei frumentariae causa collocat. Ipse Bibracte hiemare constituit. His litteris cognitis Romae dierum viginti supplicatio redditur. |
LIBRO SETTIMO
[1
Quando la Gallia era tranquilla, Cesare, come aveva stabilito, si reca in
Italia per tenervi le sessioni giudiziarie. Qui viene a sapere
dell'assassinio di P. Clodio. Poi, messo al corrente della delibera del
senato che chiamava al giuramento in massa i giovani dell'Italia, inizia
il reclutamento in tutta la provincia. Le notizie vengono ben presto
riferite in Gallia transalpina. I Galli stessi aggiungono e inventano
altri particolari, che sembravano adatti alla circostanza: Cesare era
trattenuto dai disordini della capitale e non poteva certo raggiungere
l'esercito mentre erano in corso contrasti così aspri. I Galli, già prima,
afflitti di sottostare al dominio del popolo romano, cominciano a prendere
decisioni per la guerra con maggior libertà e audacia, spronati
dall'occasione favorevole. I capi della Gallia si riuniscono in zone
boscose e appartate, si lamentano della morte di Accone, spiegano che la
stessa sorte poteva toccare anche a loro. Deplorano la situazione comune a
tutto il paese: promettendo premi d'ogni sorta, chiedono con insistenza
qualcuno che apra le ostilità e renda libera la Gallia a rischio della
vita. Innanzi tutto, dicono, si trattava di tagliare a Cesare la strada
per l'esercito prima che venissero conosciuti i loro piani segreti. Era
facile: assente il comandante in capo, le legioni non avrebbero osato
lasciare gli accampamenti invernali, né Cesare avrebbe potuto
raggiungerle, senza la scorta dovuta. Infine, era meglio morire sul campo
piuttosto che non recuperare l'antica gloria militare e la libertà
ereditata dagli avi.
[2
Dopo tali discorsi, i Carnuti si dichiarano pronti ad affrontare qualsiasi
pericolo per la salvezza comune e promettono di aprire, primi tra tutti,
le ostilità. E siccome al momento non potevano scambiarsi ostaggi come
reciproca garanzia, per non rendere manifesti i propri piani, chiedono di
sancire i patti con un giuramento e una promessa, raccolte in un fascio
tutte le insegne militari, come vuole la cerimonia più solenne secondo i
loro costumi: non intendevano trovarsi soli, una volta dato inizio al
conflitto. Allora tutti i presenti lodano i Carnuti e pronunciano il
giuramento solenne. Fissano la data della sollevazione e sciolgono il
concilio.
[3
Nel giorno stabilito, i Carnuti, sotto la guida di Cotuato e
Conconnetodumno, uomini pronti a tutto, al segnale convenuto corrono su
Cenabo: massacrano i cittadini romani che si erano qui stabiliti per
ragioni di commercio e ne saccheggiano i beni. Una delle vittime fu C.
Fufio Cita, rispettabile cavaliere romano, che per disposizione di Cesare
sovrintendeva ai rifornimenti di grano. La notizia giunge rapidamente a
tutte le genti della Gallia. Infatti, quando si verificano eventi di una
certa importanza e rilievo, li comunicano di campo in campo, di regione in
regione con grandi clamori; gli altri, a loro volta, odono le grida e le
trasmettono ai vicini, come accadde allora. Tant'è vero che l'episodio,
avvenuto a Cenabo all'alba, era già noto prima delle nove di sera nelle
terre degli Arverni, ovvero a circa centosessanta miglia di distanza.
[4
Allo stesso modo Vercingetorige convoca i suoi clienti e con facilità li
infiamma. Vercingetorige, arverno, era un giovane di grandissima potenza,
figlio di Celtillo, che aveva ottenuto il principato su tutta la Gallia e,
reo di aspirare al trono, era stato ucciso dal suo popolo. Non appena
vengono conosciute le intenzioni del giovane, si corre alle armi. Gli si
oppongono suo zio Gobannizione e gli altri capi, che non erano dell'avviso
di tentare l'impresa: viene cacciato dalla città di Gergovia; ma non
desiste e assolda, nelle campagne, i poveri e i delinquenti. Raccolto un
pugno d'uomini, guadagna alla sua causa tutti i concittadini che riesce ad
avvicinare, li incita a prendere le armi per la libertà comune. Raduna
ingenti forze ed espelle dalla città quegli stessi avversari che, poco
prima, avevano bandito lui. I suoi lo proclamano re. Invia ambascerie in
tutte le direzioni, esorta alla lealtà. In breve tempo unisce a sé i
Senoni, i Parisi, i Pictoni, i Cadurci, i Turoni, gli Aulerci, i Lemovici,
gli Andi e tutti gli altri popoli che si affacciano sull'Oceano. Per
consenso generale, gli viene conferito il comando supremo. Assunto il
potere, esige ostaggi da tutti i popoli suddetti, ordina la rapida
consegna di un determinato contingente di soldati, stabilisce la quantità
di armi che ciascun popolo, nei propri territori, doveva fabbricare ed
entro quale termine. Si preoccupa in particolare della cavalleria.
Accompagna lo straordinario zelo con un'assoluta inflessibilità nel
comando; grazie alla severità dei provvedimenti tiene a freno chi è
titubante. Infatti, per un delitto piuttosto grave condanna alla morte tra
le fiamme e tormenti d'ogni genere, mentre per una colpa di minor entità
punisce tagliando le orecchie o cavando un occhio, e rimanda il reo in
patria, che sia di monito, per atterrire gli altri con l'atrocità delle
pene.
[5
Dopo aver ben presto ridotto con tali supplizi l'esercito alla disciplina,
alla testa di parte delle truppe invia nelle terre dei Ruteni il cadurco
Lucterio, uomo di estrema audacia; dal canto suo, si dirige nella regione
dei Biturigi. Al suo arrivo i Biturigi inviano un'ambasceria agli Edui, di
cui erano clienti: chiedono aiuti per poter resistere con maggior facilità
all'attacco nemico. Dietro suggerimento dei legati rimasti con l'esercito
per ordine di Cesare, gli Edui inviano contingenti di cavalleria e
fanteria in appoggio ai Biturigi. I rinforzi, quando arrivano alla Loira,
fiume che segna il confine tra Biturigi ed Edui, sostano pochi giorni e
poi rientrano in patria senza aver osato varcare il fiume. Ai nostri
legati riferiscono di aver ripiegato per timore di un tradimento dei
Biturigi. Ne avevano, infatti, scoperto il piano: se avessero attraversato
la Loira, si sarebbero visti accerchiati dai Biturigi stessi da un lato,
dagli Arverni dall'altro. Avranno deciso così per le ragioni addotte ai
legati oppure per loro tradimento? Non abbiamo alcuna prova, perciò non ci
sembra giusto dare nulla per certo. Subito dopo l'allontanamento degli
Edui, i Biturigi si uniscono agli Arverni.
[6
Quando in Italia gli giunse notizia dell'accaduto, Cesare, rendendosi
conto che a Roma le cose si erano accomodate grazie alla fermezza di Cn.
Pompeo, partì per la Gallia transalpina. Appena arrivato, si trovò in
grave difficoltà, perché non sapeva come raggiungere l'esercito. Infatti,
se avesse richiamato le legioni in provincia, capiva che durante la marcia
avrebbero dovuto combattere senza di lui; se invece, si fosse diretto egli
stesso verso l'esercito, sapeva di non poter affidare senza rischi la
propria vita, in quel frangente, neppure ai popoli che sembravano
tranquilli.
[7
Nel frattempo, il cadurco Lucterio, inviato tra i Ruteni, li guadagna
all'alleanza con gli Arverni. Procede nelle terre dei Nitiobrogi e dei
Gabali, riceve ostaggi da entrambi i popoli e, raccolte ingenti truppe,
tenta un'incursione in provincia, verso Narbona. Appena ne è informato,
Cesare ritenne di dover subordinare qualsiasi piano alla partenza per
Narbona. Una volta giunto, rassicura chi nutre timori, colloca guarnigioni
nelle terre dei Ruteni provinciali, dei Volci Arecomici, dei Tolosati e
tutt'intorno a Narbona, ossia nelle zone di confine col nemico. Ordina che
parte delle truppe della provincia, insieme ai rinforzi da lui stesso
condotti dall'Italia, si concentrino nella regione degli Elvi, popolo
limitrofo agli Arverni.
[8
Dopo aver approntato tutto ciò (mentre ormai Lucterio era stato fermato e
arretrava, perché riteneva pericoloso inoltrarsi nelle zone presidiate),
Cesare si dirige nelle terre degli Elvi. Le Cevenne, monti che segnano il
confine tra Arverni ed Elvi, ostacolavano il cammino, la stagione era la
più inclemente, la neve molto alta; tuttavia, spalò la neve per una
profondità di sei piedi, si aprì un varco grazie all'enorme sforzo dei
soldati e raggiunse i territori degli Arverni. Piombò inatteso sui nemici,
che si ritenevano protetti dalle Cevenne come da un muro: mai, neppure un
uomo isolato, in quella stagione era riuscito a praticarne i sentieri.
Ordina ai cavalieri di effettuare scorrerie nel raggio più ampio e di
seminare il panico tra i nemici quanto più potevano. La voce e le notizie,
ben presto, giungono a Vercingetorige: tutti gli Arverni, spaventati, lo
attorniano e lo scongiurano di pensare alla loro sorte, di impedire ai
Romani le razzie, tanto più ora che vedeva tutto il peso della guerra
ricadere su di loro. Sotto la pressione delle preghiere, sposta il campo
dalle terre dei Biturigi in direzione degli Arverni.
[9
Ma Cesare si trattiene nella regione degli Arverni due giorni: prevista la
mossa di Vercingetorige, si allontana col pretesto di raccogliere rinforzi
e cavalleria. Affida il comando al giovane Bruto e lo incarica di compiere
in ogni direzione scorrerie con la cavalleria, il più lontano possibile:
dal canto suo, avrebbe fatto di tutto per rimaner lontano dal campo non
più di tre giorni. Impartite tali disposizioni, contro le attese dei suoi
si reca a Vienna, forzando al massimo le tappe. Sfrutta la cavalleria
fresca lì inviata molti giorni prima e, senza mai interrompere la marcia
né di giorno, né di notte, attraversa il territorio degli Edui verso i
Lingoni, dove svernavano due legioni: così, se gli Edui gli avessero teso
qualche insidia, li avrebbe prevenuti con la rapidità del suo passaggio.
Appena giunto, invia messi alle altre legioni e le raccoglie tutte in un
solo luogo, prima che gli Arverni potessero sapere del suo arrivo. Quando
ne è informato, Vercingetorige riconduce l'esercito nei territori dei
Biturigi e, da qui, raggiunge e comincia a stringere d'assedio Gorgobina,
una città dei Boi, popolo che Cesare aveva qui stanziato sotto la tutela
degli Edui dopo averlo sconfitto nella guerra contro gli Elvezi.
[10
La mossa di Vercingetorige metteva in grave difficoltà Cesare, incerto sul
da farsi: se per il resto dell'inverno avesse tenuto le legioni
concentrate in un solo luogo, temeva che la caduta di un popolo vassallo
degli Edui potesse causare una defezione generale della Gallia, visto che
lui non rappresentava una garanzia di difesa per gli alleati; d'altronde,
se avesse mobilitato l'esercito troppo presto, lo preoccupava
l'approvvigionamento di grano per i disagi del trasporto. Gli sembrò
meglio, tuttavia, affrontare qualsiasi difficoltà piuttosto che subire
un'onta così grave e alienarsi l'animo di tutti i suoi. Perciò, incita gli
Edui a occuparsi del trasporto dei viveri e invia messaggeri ai Boi per
informarli del suo arrivo ed esortarli a mantenere i patti e a reggere con
grande coraggio all'assalto nemico. Lascia ad Agedinco due legioni con le
salmerie di tutto l'esercito e parte alla volta dei Boi.
[11
Due giorni dopo, giunse a Vellaunoduno, città dei Senoni- Non volendo
lasciarsi nemici alle spalle per facilitare i rifornimenti, cominciò
l'assedio e in due giorni costruì tutt'attorno un vallo. Il terzo giorno
la città gli invia emissari per offrire la resa, Cesare esige la consegna
delle armi, dei giumenti e di seicento ostaggi. Lascia il legato C.
Trebonio a sbrigare la faccenda e punta subito su Cenabo, città dei
Carnuti, per coprire al più presto la distanza. Pervenuta soltanto allora
notizia dell'assedio di Vellaunoduno, i Carnuti pensavano che le cose
sarebbero andate per le lunghe e preparavano una guarnigione da inviare a
Cenabo. Qui Cesare giunge in due giorni. Pone il campo dinnanzi alla
città, ma è costretto a rimandare l'attacco all'indomani, vista l'ora
tarda. Comanda ai soldati di approntare il necessario per l'assedio e dà
ordine a due legioni di vegliare in armi, temendo una fuga di notte dalla
città, in quanto un ponte sulla Loira collegava Cenabo con la sponda
opposta. Poco prima di mezzanotte i Cenabensi uscirono in silenzio dalla
città e cominciarono ad attraversare il fiume. Appena ne è informato dagli
esploratori, Cesare invia le due legioni che, per suo ordine, si tenevano
pronte all'intervento; dà fuoco alle porte, irrompe in città e la prende:
ben pochi sfuggono alla cattura, perché il ponte e le strade, stretti
com'erano, avevano ostacolato la fuga del grosso dei nemici. Saccheggia e
incendia la città, dona ai soldati il bottino, varca con l'esercito la
Loira e perviene nei territori dei Biturigi.
[12
Vercingetorige, non appena è messo al corrente dell'arrivo di Cesare,
toglie l'assedio e gli si fa incontro. Cesare aveva intrapreso il blocco
di una città dei Biturigi, Novioduno, posta lungo la sua strada. Dalla
città gli erano stati inviati emissari per scongiurarne il perdono, la
grazia. Al fine di condurre a termine il resto delle operazioni con la
rapidità che gli aveva fruttato la maggior parte dei successi, impone la
consegna di armi, cavalli e ostaggi. Una parte degli ostaggi era già stata
inviata, al resto si stava provvedendo; in città si erano addentrati
alcuni centurioni con pochi legionari, per raccogliere le armi e i
giumenti. Ma ecco che in lontananza si scorge la cavalleria nemica, che
precedeva l'esercito di Vercingetorige. Non appena gli abitanti la videro
e nacque in loro la speranza di rinforzi, tra alte grida cominciarono a
impugnare le armi, a chiudere le porte, a riversarsi sulle mura. I
centurioni presenti in città, essendosi resi conto, dal loro
comportamento, che i Galli avevano preso qualche nuova decisione,
sguainate le spade, assunsero il controllo delle porte e condussero tutti
i loro in salvo.
[13
Cesare ordina alla cavalleria di scendere in campo e attacca battaglia;
poiché i suoi erano in difficoltà, invia in loro appoggio circa
quattrocento cavalieri germani, che fin dall'inizio della guerra era
solito portare con sé. I Galli non riuscirono a resistere all'attacco e
volsero le spalle: si rifugiarono presso il loro esercito in marcia, ma
subirono gravi perdite. Di fronte alla rotta della loro cavalleria, gli
abitanti della città, presi nuovamente dal panico, catturarono i presunti
responsabili dell'istigazione del popolo e li consegnarono a Cesare,
arrendendosi. Sistemata la questione, Cesare si diresse ad Avarico, la più
importante e munita città dei Biturigi, posta nella regione più fertile:
era convinto che, presa Avarico, avrebbe ridotto in suo potere i Biturigi.
[14
Vercingetorige, dopo tanti, continui rovesci, subiti a Vellaunoduno,
Cenabo e Novioduno, convoca i suoi a concilio. Occorreva adottare, spiega,
una strategia ben diversa rispetto al passato. Bisognava sforzarsi, con
ogni mezzo, di impedire ai Romani la raccolta di foraggio e viveri. Era
facile: avevano una cavalleria molto numerosa e la stagione giocava in
loro favore. I Romani non avevano la possibilità di trovare foraggio nei
campi, dovevano dividersi e cercarlo casa per casa: tutte queste truppe,
di giorno in giorno, le poteva annientare la cavalleria. Poi, per la
salvezza comune, era necessario trascurare i beni privati; occorreva
incendiare villaggi e case in ogni direzione, dove sembrava che i Romani
si sarebbero recati in cerca di foraggio. Le loro scorte, invece, erano
sufficienti, perché sarebbero stati riforniti dal popolo nelle cui terre
si fosse combattuto. I Romani o non avrebbero potuto far fronte alla
mancanza di viveri o si sarebbero allontanati troppo dall'accampamento,
esponendosi a grossi rischi. E non faceva alcuna differenza tra ucciderli
o privarli delle salmerie, perché senza di esse non si poteva condurre una
guerra. Inoltre, bisognava incendiare le città che, per fortificazioni o
conformazione naturale, non erano del tutto sicure, in modo da non offrire
ai disertori galli un rifugio e ai Romani l'opportunità di trovare viveri
o far bottino. Se tali misure sembravano dure o severe, dovevano pensare
quanto più dura sarebbe stata la schiavitù per i figli e le mogli e la
morte per loro stessi, destino dei vinti.
[15
Il parere di Vercingetorige riscuote il consenso generale: in un solo
giorno vengono date alle fiamme più di venti città dei Biturigi. Lo stesso
avviene nei territori degli altri popoli: ovunque si scorgono incendi.
Anche se tutti provavano grande dolore per tali provvedimenti, tuttavia si
consolavano nella convinzione di avere la vittoria pressoché in pugno e di
poter recuperare a breve termine i beni perduti. Nell'assemblea comune si
delibera su Avarico, se incendiarla o difenderla. I Biturigi si gettano ai
piedi di tutti i capi galli, li pregano di non costringerli a incendiare,
di propria mano, la più bella o quasi tra le città di tutta la Gallia,
presidio e vanto del loro popolo. Sostengono che si sarebbero difesi con
facilità grazie alla conformazione naturale della zona: la città,
circondata su quasi tutti i lati da un fiume e da una palude, aveva un
unico accesso, molto angusto. La loro richiesta viene accolta:
Vercingetorige, in un primo momento contrario, aveva poi acconsentito, sia
per le loro preghiere, sia per la compassione che tutti provavano. Si
scelgono per la città i difensori adatti.
[16
Vercingetorige segue Cesare a piccole tappe e sceglie per l'accampamento
un luogo munito da paludi e selve, a sedici miglia da Avarico. Lì,
mediante una rete stabile di esploratori, ora per ora si teneva al
corrente delle novità di Avarico e diramava gli ordini. Sorvegliava tutti
i nostri spostamenti: quando i legionari si disunivano, dovendo per forza
di cose allontanarsi in cerca di foraggio e grano, li assaliva procurando
loro gravi perdite, sebbene i nostri, per quanto si poteva provvedere,
adottassero ogni misura per muoversi a intervalli irregolari e seguire vie
diverse.
[17
Cesare pose l'accampamento nei pressi della zona che, libera dal fiume e
dalle paludi, lasciava uno stretto passaggio, come abbiamo in precedenza
illustrato. Cominciò a costruire il terrapieno, a spingere in avanti le
vinee, a fabbricare due torri; la natura del luogo, infatti, impediva di
circondare la città con un vallo. Quanto all'approvvigionamento di grano,
non cessò di raccomandarsi ai Boi e agli Edui: quest'ultimi, che agivano
senza zelo alcuno, non risultavano di grande aiuto; i primi, invece, non
disponendo di grandi mezzi, perché erano un popolo piccolo e debole,
esaurirono in breve tempo le proprie scorte. Una totale penuria di viveri,
dovuta alla povertà dei Boi, alla negligenza degli Edui e agli incendi
degli edifici, attanagliò l'esercito a tal punto, che per parecchi giorni
i nostri soldati rimasero senza grano e placarono i morsi della fame
grazie ai capi di bestiame tratti dai villaggi più lontani. Tuttavia, non
si udì da parte loro nessuna parola indegna della maestà del popolo romano
e delle loro precedenti vittorie. Anzi, quando Cesare interpellò ciascuna
legione durante i lavori e disse che avrebbe tolto l'assedio, se la
mancanza di viveri risultava troppo dura, tutti, nessuno eccetto, lo
scongiurarono di non farlo: sotto il suo comando, in tanti anni, non
avevano patito affronti, né si erano ritirati senza portare a termine
un'impresa; l'avrebbero considerata una vergogna interrompere l'assedio in
corso; era meglio sopportare privazioni d'ogni sorta piuttosto che
rinunciare alla vendetta dei cittadini romani massacrati a Cenabo dalla
slealtà dei Galli. Simili considerazioni vennero espresse ai centurioni e
ai tribuni militari, perché le riferissero a Cesare.
[18
Quando già accostavano le torri alle mura, Cesare venne a sapere dai
prigionieri che Vercingetorige, terminato il foraggio, aveva spostato il
campo e si era avvicinato ad Avarico: alla testa della cavalleria e della
fanteria leggera, abituata a combattere tra i cavalieri, si era diretto
dove riteneva che il giorno seguente i nostri si sarebbero recati in cerca
di foraggio e si apprestava a un'imboscata. Saputo ciò, a mezzanotte
Cesare parte in silenzio e giunge al campo nemico la mattina successiva. I
Galli, immediatamente informati dell'arrivo di Cesare dagli esploratori,
nascosero i carri e le salmerie nel folto dei boschi, poi dispiegarono
tutte le truppe in una zona elevata e aperta. Appena lo venne a sapere,
Cesare ordinò di radunare in fretta i bagagli e di preparare le armi.
[19
Il colle si alzava dal basso in dolce pendio. Lo cingeva su quasi tutti i
lati una palude difficile da superare e impraticabile, non più larga di
cinquanta piedi. I Galli, tagliati i ponti, si tenevano sul colle,
confidando nella loro posizione. Divisi per popoli, presidiavano tutti i
guadi e i passaggi della palude, pronti a premere dall'alto i Romani
impantanati, se avessero tentato di varcarla. Così, chi avesse notato solo
la vicinanza dei due eserciti, avrebbe ritenuto i nemici risoluti allo
scontro a condizioni uguali o quasi, ma chi avesse considerato la
disparità delle posizioni, avrebbe capito che il loro farsi ostentatamente
vedere era una vana simulazione. I legionari, irritati che il nemico
riuscisse a reggere alla loro vista così da vicino, chiedono il segnale
d'attacco, ma Cesare spiega quante perdite, quanti uomini valorosi ci
sarebbe inevitabilmente costata la vittoria; vedendoli così pronti ad
affrontare qualsiasi pericolo per la sua gloria, avrebbe dovuto essere
tacciato di estrema ingiustizia, se non avesse tenuto alla loro vita più
che alla propria. Così, dopo aver confortato i soldati, quel giorno stesso
li riconduce all'accampamento e inizia a impartire le rimanenti
disposizioni per l'assedio della città.
[20
Appena ritorna tra i suoi, Vercingetorige viene accusato di tradimento:
aveva spostato il campo troppo vicino ai Romani, si era allontanato con
tutta la cavalleria, aveva lasciato truppe così numerose senza un capo,
alla sua partenza erano piombati tanto tempestivi e rapidi i Romani -
tutto ciò non poteva essersi verificato per caso o senza un piano
prestabilito, la verità era che preferiva regnare sulla Gallia per
concessione di Cesare piuttosto che per beneficio loro. A tali accuse così
Vercingetorige risponde: se aveva mosso il campo, dipendeva dalla mancanza
di foraggio, e loro stessi lo avevano sollecitato; si era sì avvicinato
troppo ai Romani, ma lo aveva indotto la posizione vantaggiosa, che da
sola permetteva la difesa senza bisogno di fortificazioni; non si doveva,
poi, rimpiangere l'apporto della cavalleria nelle paludi, quando era stata
utile là dove l'aveva condotta. Quanto al comando, alla sua partenza non
l'aveva lasciato a nessuno deliberatamente, per evitare che il capo
designato fosse indotto dall'ardore della moltitudine allo scontro, che
tutti desideravano - lo vedeva - per la debolezza del carattere e perché
incapaci di sopportare più a lungo le fatiche della guerra. Se i Romani
erano intervenuti guidati dal caso, bisognava ringraziare la Fortuna, se
erano stati richiamati dalle informazioni di un delatore, si doveva essere
grati a costui, perché così, dall'alto, i Galli avevano potuto constatare
quanto fossero pochi e codardi i Romani, che non avevano osato misurarsi e
si erano vergognosamente ritirati nell'accampamento. Non aveva affatto
bisogno di ricevere da Cesare, con il tradimento, il comando che poteva
ottenere con la vittoria, ormai nelle mani sue e di tutti i Galli. Anzi,
era disposto a deporre la carica, se pensavano di avergli concesso un
potere troppo grande rispetto alla salvezza che da lui ricevevano. "E
perché comprendiate la sincerità delle mie parole - esclamò - ascoltate i
soldati romani". Introduce alcuni servi catturati pochi giorni prima
mentre erano in cerca di foraggio e torturati con la fame e le catene. I
servi, già istruiti in precedenza su cosa dovevano rispondere, si
dichiarano legionari: erano usciti di nascosto dal campo, spinti dalla
fame e dalla mancanza di viveri, nella speranza di trovare nelle campagne
un po' di grano o del bestiame; tutto l'esercito versava nelle stesse
condizioni di precarietà, nessuno aveva più forze, ormai, né poteva
reggere alla fatica dei lavori; perciò, il comandante aveva deciso che, se
l'assedio non sortiva effetto, dopo tre giorni avrebbe ritirato
l'esercito. Vercingetorige aggiunge: "Ecco i benefici che io vi ho
procurato, e voi mi accusate di tradimento. Grazie a me, senza versare una
goccia di sangue, ora vedete annientato dalla fame un esercito forte e
vittorioso. E quando si ritirerà vergognosamente in fuga, ho già
provveduto in modo che nessun popolo lo accolga nelle proprie terre".
[21
Tutta la moltitudine acclama e, secondo il loro costume, fa risonare le
armi, come di solito fanno quando approvano il discorso di qualcuno:
Vercingetorige era il capo supremo, non si doveva dubitare della sua
lealtà, né era possibile condurre le operazioni con una strategia
migliore. Decidono di inviare in città diecimila uomini scelti tra tutte
le truppe, ritenendo inopportuno delegare ai soli Biturigi la lotta per la
salvezza comune: capivano che loro sarebbe stata la vittoria finale, se la
città non cadeva.
[22
Allo straordinario valore dei nostri soldati, i Galli opponevano
espedienti d'ogni sorta: sono una razza molto ingegnosa, abilissima
nell'imitare e riprodurre qualsiasi cosa abbiano appreso da chiunque.
Infatti, dalle mura rimuovevano le falci per mezzo di lacci e, quando le
avevano ben serrate nei loro nodi. le tiravano all'interno mediante
argani. Provocavano frane nel terrapieno scavando cunicoli, con tanta
maggior abilità, in quanto nelle loro regioni ci sono molte miniere di
ferro, per cui conoscono e usano ogni tipo di cunicolo. Poi, lungo tutto
il perimetro di cinta avevano innalzato torri e le avevano protette con
pelli. Inoltre, di giorno e di notte operavano frequenti sortite, nel
tentativo di appiccare il fuoco al terrapieno o di assalire i nostri
impegnati nei lavori. E quanto più le nostre torri ogni giorno salivano
grazie al terrapieno, tanto più i Galli alzavano le loro con l'aggiunta di
travi. Infine, utilizzando pali dalla punta acutissima e indurita al
fuoco, pece bollente e massi enormi, bloccavano i cunicoli aperti dai
nostri e ci impedivano di accostarci alle mura.
[23
Le mura dei Galli sono tutte costruite all'incirca così: pongono a terra,
su tutta la lunghezza della cinta, travi ad essa perpendicolari, a un
intervallo regolare di due piedi. Ne collegano le estremità all'interno e
le ricoprono con molta terra. I suddetti spazi tra l'una e l'altra trave,
li chiudono all'esterno con grosse pietre. Una volta inserite e ben
connesse le prime travi, sopra ne aggiungono un'altra serie, facendo in
modo che mantengano la stessa distanza e non si tocchino, ma che ciascuna,
a pari intervallo, poggi sulle pietre frapposte e risulti saldamente
unita. Così, di seguito, tutta l'opera viene costruita fino all'altezza
voluta. Le mura, per forma e varietà, non hanno un aspetto sgradevole, con
quest'alternanza di travi e massi che conservano paralleli i propri
ordini; al tempo stesso risultano molto utili ed efficaci per la difesa
delle città, perché la pietra le preserva dagli incendi, il legno le
difende dall'ariete, che non può spezzare o sconnettere le travi, unite in
modo continuo all'interno per una lunghezza di quaranta piedi in genere.
[24
Tutto ciò rendeva difficile l'assedio, ma i nostri, pur frenati
continuamente dal freddo e dalle piogge incessanti, lavorarono senza
sosta: superato ogni ostacolo, in venticinque giorni costruirono un
terrapieno lungo trecentotrenta piedi e alto ottanta. L'opera raggiungeva
quasi le mura nemiche; Cesare, come suo solito, vegliava sul luogo dei
lavori e incitava i soldati a non fermarsi neppure per un istante. Ma ecco
che poco prima di mezzanotte si vide uscire del fumo dal terrapieno: i
nemici gli avevano dato fuoco da un cunicolo. Mentre da tutte le mura si
levavano alte grida, i Galli contemporaneamente tentarono una sortita
dalle due porte ai lati delle torri. Altri, dall'alto della cinta,
lanciavano sul terrapieno fiaccole e legna secca, cospargendole di pece e
di altre sostanze infiammabili: era ben difficile decidere dove dirigersi,
dove recar aiuto. Tuttavia, per abitudine di Cesare, due legioni stavano
sempre all'erta di fronte all'accampamento, mentre parecchie, a turno,
continuavano i lavori. Così, rapidamente accadde che parte dei nostri
tenesse testa ai nemici usciti dalla città, parte ritraesse le torri e
scindesse il terrapieno, mentre il grosso dell'esercito presente al campo
accorreva per estinguere l'incendio.
[25
Si combatteva in ogni settore, quando era trascorsa ormai la parte
restante della notte. Nei nemici, man mano, si rafforzava la speranza di
vittoria, tanto più che vedevano i plutei delle torri distrutti dal fuoco
e intuivano le difficoltà dei nostri, che dovevano uscire allo scoperto
per portar soccorso. Forze fresche nemiche, via via, davano il cambio a
chi era stanco, ed erano convinti che tutte le sorti della Gallia
dipendessero da quel frangente. Allora, sotto i nostri occhi, accadde un
fatto degno di ricordo, che crediamo di non dover tacere. Davanti a una
porta della città, un Gallo scagliava in direzione di una torre palle di
sego e pece passate di mano in mano: trafitto al fianco destro dal dardo
di uno scorpione, cadde senza vita. Uno dei più vicini scavalcò il
compagno morto e ne prese il posto. Quando anch'egli, allo stesso modo,
cadde colpito dallo scorpione, gli subentrò un terzo, e al terzo un
quarto. I difensori non abbandonarono quella posizione fino a che, estinto
l'incendio sul terrapieno e respinto il loro attacco in tutto quel
settore, la battaglia non ebbe termine.
[26
I Galli le provarono tutte, ma senza successo: il giorno seguente decisero
di evacuare la città, su consiglio e ordine di Vercingetorige. Speravano
che la manovra non costasse loro gravi perdite, se tentata nel silenzio
della notte: il campo di Vercingetorige, infatti, non era lontano dalla
città, e una palude, che si frapponeva interminabile, ritardava
l'inseguimento dei Romani. Già si apprestavano di notte alla ritirata,
quando all'improvviso le madri di famiglia scesero nelle strade, si
gettarono in lacrime ai piedi dei loro e li scongiurarono con preghiere
d'ogni sorta di non abbandonare alla ferocia nemica loro stesse e i figli
comuni, che non potevano fuggire, deboli com'erano per il sesso o l'età.
Quando videro che gli uomini non recedevano dalla decisione - in caso di
pericolo estremo, in genere, il timore non lascia spazio alla compassione
- cominciarono a gridare e a segnalare ai Romani la fuga. I Galli,
preoccupati che la cavalleria romana li prevenisse e occupasse le strade,
rinunciarono al loro proposito.
[27
Il giorno successivo, quando Cesare aveva già spinto in avanti una torre e
raddrizzato il terrapieno che aveva cominciato a costruire, si abbatté un
violento acquazzone. Cesare la considerò una circostanza favorevole per
risolversi ad attaccare, poiché vedeva le sentinelle nemiche disposte
sulle mura con minor cautela. Così, ai suoi diede ordine di rallentare
leggermente i lavori e mostrò loro che cosa dovevano fare. Di nascosto
preparò le legioni al di qua delle vinee, le esortò a raccogliere una
buona volta, dopo tante fatiche, il frutto della vittoria, promise
ricompense per i primi che avessero scalato le mura e diede il segnale ai
soldati. I nostri si lanciarono repentinamente all'attacco da tutti i lati
e in breve si riversarono sulle mura.
[28
I nemici, atterriti dall'attacco improvviso, furono scacciati dalle mura e
dalle torri. Si attestarono nel foro e nelle zone più aperte, disponendosi
a cuneo, decisi ad affrontare in uno scontro regolare i nostri, se fossero
venuti avanti. Quando videro che nessuno scendeva in campo aperto (anzi, i
nostri li circondavano lungo tutto il muro di cinta), temendo di perdere
ogni via di scampo, gettarono le armi e si slanciarono verso le parti
estreme della città, senza mai fermarsi. Qui, chi si accalcava per via
delle porte strette, venne ucciso dai legionari; gli altri, già usciti,
furono massacrati dai cavalieri. Ma nessuno dei nostri pensò al bottino.
Aizzati dalla strage di Cenabo e dalla fatica dell'assedio, non
risparmiarono né i vecchi, né le donne, né i bambini. Insomma, del numero
totale dei nemici, circa quarantamila, appena ottocento, che ai primi
clamori fuggirono dalla città, raggiunsero salvi Vercingetorige. Costui li
accolse a notte fonda, in silenzio, perché temeva che il loro arrivo al
campo e la compassione della folla provocassero una sedizione. Dispose
lontano, lungo la via, i compagni d'arme e i principi dei vari popoli, con
l'incarico di smistarli e di condurli dai loro, nelle zone del campo
assegnate a ciascuna gente fin dall'inizio.
[29
L'indomani, convocata l'assemblea, li consola ed esorta a non perdersi
affatto d'animo, a non lasciarsi turbare dalla sconfitta. I Romani non
avevano vinto né col valore, né in campo aperto, ma solo grazie a una
certa loro abilità e perizia nell'arte dell'assedio, di cui i Galli erano
inesperti. Era in errore chi in guerra si aspettava solo successi. Non era
mai stato fautore della difesa di Avarico, loro stessi ne erano testimoni.
L'imprudenza dei Biturigi e l'eccessiva compiacenza degli altri avevano
portato alla sconfitta. Tuttavia, vi avrebbe posto rimedio ben presto, con
successi più importanti. Infatti, sarebbe stata sua cura guadagnare alla
causa i popoli che dissentivano dagli altri Galli e formare un consiglio
unico di tutto il paese, alla cui unità d'intenti non avrebbe potuto
resistere neppure il mondo intero. Ed era ormai cosa fatta. Ma per la
salvezza comune era giusto, intanto, che si decidessero a fortificare il
campo, per resistere con maggior facilità ai repentini attacchi dei
nemici.
[30
Il discorso non riuscì sgradito ai Galli, soprattutto perché
Vercingetorige non si era abbattuto dopo un rovescio così grave, non si
era rintanato, né sottratto alla vista della gente. Si pensava che sapesse
prevedere e presentire nell'animo più degli altri, perché, quando le cose
non erano ancora compromesse, aveva prima consigliato di incendiare
Avarico, poi di evacuarla. E come gli insuccessi indeboliscono il
prestigio degli altri comandanti, così al contrario, dopo la sconfitta, la
dignità di Vercingetorige cresceva di giorno in giorno. Al contempo, si
sperava nella sua garanzia circa l'alleanza con gli altri popoli. Allora,
per la prima volta, i Galli cominciarono a fortificare l'accampamento:
uomini non avvezzi alle fatiche, si erano convinti a tal punto, da credere
di dover ubbidire a qualsiasi ordine.
[31
E non meno di quanto avesse garantito, Vercingetorige rivolgeva ogni suo
pensiero a come unire a sé i rimanenti popoli e ne allettava i capi con
doni e promesse. Sceglieva persone adatte allo scopo, ciascuna capace di
guadagnarli alla causa con la massima facilità, o grazie alla sottile
eloquenza o per ragioni d'amicizia. Rifornisce di armi e vestiti i reduci
di Avarico. Al tempo stesso, per ricompletare i ranghi dopo le perdite
subite, esige dai vari popoli un determinato contingente di soldati, ne
fissa l'entità e la data di consegna. Ordina il reclutamento e l'invio di
tutti gli arcieri, numerosissimi in Gallia. Con tali misure, in breve
rimedia alle perdite di Avarico. Nel frattempo, il re dei Nitiobrogi,
Teutomato, figlio di Ollovicone, che aveva ricevuto dal nostro senato il
titolo di amico, raggiunge Vercingetorige con una forte cavalleria e
truppe assoldate in Aquitania.
[32
Cesare si trattenne diversi giorni ad Avarico: vi trovò grano e viveri in
abbondanza e lasciò che l'esercito si riprendesse dalla fatica e dalle
privazioni. L'inverno era ormai quasi finito, la stagione stessa invitava
alle operazioni militari: Cesare aveva già deciso di puntare sul nemico,
nel tentativo di stanarlo dalle paludi e dalle selve oppure di stringerlo
d'assedio. Ma ecco che, in veste di ambasciatori, i principi degli Edui
gli si presentano e lo pregano di soccorrere il loro popolo nell'ora più
grave. La situazione era assai critica: mentre la consuetudine, fin dai
tempi antichi, voleva che un unico magistrato fosse eletto e rivestisse la
potestà regale per un anno, adesso due persone ricoprivano tale carica e
ciascuno sosteneva che la propria nomina era conforme alle leggi. L'uno
era Convictolitave, giovane ricco e nobile, l'altro Coto, persona di
antichissima stirpe, lui pure assai potente, che vantava molti legami di
parentela, il cui fratello, Valeziaco, aveva rivestito la stessa
magistratura l'anno precedente. Tutti gli Edui avevano impugnato le armi,
diviso era il senato, diviso il popolo, come pure i clienti dei due
rivali. Se il contrasto si fosse protratto, si arrivava alla guerra
civile. Impedirlo dipendeva dallo zelo e dal prestigio di Cesare.
[33
Cesare, sebbene stimasse dannoso rinviare lo scontro e allontanarsi dal
nemico, ritenne tuttavia necessario dar la precedenza alla questione edua,
ben conscio di quanti danni siano soliti derivare da tali dissensi: non
voleva che un popolo tanto importante e così legato a Roma, da lui stesso
sempre favorito e fregiato di ogni onore, giungesse alla guerra civile e
che il partito che si sentiva meno forte chiedesse aiuto a Vercingetorige.
Poiché le leggi edue non permettevano al magistrato in carica di lasciare
il paese, Cesare decise di recarsi di persona nelle loro terre, per
evitare l'impressione che intendesse calpestarne il diritto o le leggi.
Convocò a Decezia il senato al completo e i due responsabili della
controversia. Lì si raccolsero pressoché tutti i notabili edui e gli
notificarono che Coto era stato nominato da suo fratello nel corso di un
concilio segreto. con pochi partecipanti, al di fuori dei luoghi e dei
tempi dovuti, mentre le leggi prescrivevano che nessuno poteva essere
eletto magistrato e neppure ammesso in senato, se un membro della sua
famiglia aveva ricoperto la carica ed era ancora in vita. Allora Cesare
costrinse Coto a deporre il comando e ordinò che assumesse il potere
Convictolitave, che era stato designato dai sacerdoti secondo le usanze
edue, quando la magistratura era vacante.
[34
Dopo tale decreto, esortò gli Edui a dimenticare contrasti e dissensi e a
lasciare tutto da parte, li invitò a occuparsi della guerra in corso e ad
attendersi i premi che si fossero meritati, una volta piegata la Gallia.
Chiese il rapido invio di tutta la cavalleria e di diecimila fanti, che
avrebbe disposto a difesa delle provviste di grano. Divise in due
contingenti l'esercito: quattro legioni le affidò a Labieno per condurle
nelle terre dei Senoni e dei Parisi, sei le guidò personalmente nella
regione degli Arverni, verso Gergovia, seguendo il corso dell'Allier.
Parte della cavalleria la concesse a Labieno, parte la tenne con sé.
Appena lo seppe, Vercingetorige distrusse tutti i ponti e cominciò a
marciare sulla sponda opposta.
[35
I due eserciti rimanevano l'uno al cospetto dell'altro, ponevano i campi
quasi dirimpetto. La sorveglianza degli esploratori nemici impediva ai
Romani di costruire in qualche luogo un ponte per varcare il fiume. Cesare
correva il rischio di rimanere bloccato dal fiume per la maggior parte
dell'estate, in quanto l'Allier non consente con facilità il guado prima
dell'autunno. Così, per evitare tale evenienza, pose il campo in una zona
boscosa, dinnanzi a uno dei ponti distrutti da Vercingetorige; il giorno
seguente si tenne nascosto con due legioni. Le altre truppe, con tutte le
salmerie, ripresero il cammino secondo il solito, ma alcune coorti vennero
frazionate perché sembrasse inalterato il numero delle legioni. Ad esse
comandò di protrarre la marcia il più possibile: a tarda ora, supponendo
che le legioni si fossero accampate, intraprese la ricostruzione del
ponte, utilizzando gli stessi piloni rimasti intatti nella parte
inferiore. L'opera venne rapidamente realizzata e le legioni furono
condotte sull'altra sponda. Scelse una zona adatta all'accampamento e
richiamò le rimanenti truppe. Vercingetorige, informato dell'accaduto, per
non trovarsi costretto a dar battaglia contro la sua volontà, le
precedette e si allontanò a marce forzate.
[36
Da lì Cesare raggiunse Gergovia in cinque tappe. Quel giorno stesso, dopo
una scaramuccia di cavalleria, studiò la posizione della città, che si
ergeva su un monte altissimo ed era di difficile accesso. Disperando di
poterla prendere d'assalto, decise di non stringerla d'assedio prima di
aver pensato alle scorte di grano. Vercingetorige, invece, aveva stabilito
il campo nei pressi della città sul fianco del monte, disponendo
tutt'attorno, a breve intervallo, le truppe dei vari popoli, distinte.
Aveva occupato, per quanto si poteva vedere, tutte le cime del monte e
offriva uno spettacolo raccapricciante. I capi delle varie genti, da lui
scelti come consiglieri, avevano il compito di presentarsi
quotidianamente, all'alba, per eventuali comunicazioni o consegne. E non
lasciava passare giorno, o quasi, senza attaccar battaglia con la
cavalleria e gli arcieri in mezzo a essa, per misurare il coraggio e il
valore di ciascuno dei suoi. Di fronte alla città, proprio ai piedi del
monte, sorgeva un colle ben munito, con tutti i lati a strapiombo. Se i
nostri l'avessero preso, avrebbero sottratto ai nemici, così almeno
sembrava, la maggior parte delle fonti d'acqua e la possibilità di
foraggiarsi liberamente. Ma il colle era tenuto da una salda guarnigione
nemica. Tuttavia, Cesare uscì dal campo nel silenzio della notte e, prima
che dalla città potessero giungere rinforzi, mise in fuga il presidio
nemico e occupò il colle. Vi alloggiò due legioni e scavò una coppia di
fosse parallele, larghe dodici piedi, che collegavano l'accampamento
maggiore con il minore: così, anche singoli uomini avrebbero potuto
spostarsi dall'uno all'altro al sicuro da improvvisi attacchi nemici.
[37
Mentre a Gergovia le cose andavano così, l'eduo Convictolitave, al quale
Cesare - l'abbiamo detto - aveva assegnato la magistratura, si lascia
corrompere dal denaro degli Arverni e si accorda con alcuni giovani,
capeggiati da Litavicco e dai suoi fratelli, rampolli di stirpe assai
nobile. Divide con loro la somma ricevuta e li esorta a ricordarsi che
sono uomini liberi, nati per il comando. Gli Edui erano gli unici a
ritardare l'indubbia vittoria della Gallia; la loro autorità frenava le
altre genti; ma se avessero cambiato partito, i Romani non avrebbero più
avuto modo di rimanere in Gallia. Cesare, è vero, gli aveva reso un grande
beneficio, ma non aveva fatto altro che riconoscere l'assoluta legittimità
delle sue ragioni. Del resto, la libertà comune era per lui più
importante. Perché mai gli Edui, per il loro diritto e le loro leggi,
dovevano ricorrere al giudizio di Cesare, e non piuttosto i Romani alla
sentenza degli Edui? I giovani vengono ben presto catturati dalle parole
del magistrato e dal denaro: pur dichiarandosi addirittura pronti a
prendere l'iniziativa, cercavano un piano d'azione, perché erano sicuri di
non poter indurre gli Edui alla guerra senza un motivo. Si decise di porre
Litavicco a capo dei diecimila uomini da inviare a Cesare, con l'incarico
di guidarli; i suoi fratelli avrebbero raggiunto Cesare prima di lui.
Mettono a punto il piano in tutti gli altri particolari.
[38
Litavicco assume il comando dell'esercito. A un tratto, a circa trenta
miglia da Gergovia, convoca i suoi: "Dove andiamo, soldati?" dice tra le
lacrime. "Tutti i nostri cavalieri, tutti i nobili sono caduti. I capi,
Eporedorige e Viridomaro, accusati di tradimento dai Romani, sono stati
messi a morte senza neppure un processo. Ma sentitelo da costoro, che sono
scampati al massacro: i miei fratelli e tutti i miei parenti sono morti,
il dolore mi impedisce di narrarvi l'accaduto". Si fanno avanti alcune
persone già istruite su cosa dire. Ripetono alla massa dei soldati gli
stessi discorsi di Litavicco: i cavalieri edui erano stati trucidati, li
si accusava di una presunta complicità con gli Arverni; loro si erano
nascosti nel folto del gruppo e avevano preso la fuga proprio nel bel
mezzo della strage. Gli Edui levano alte grida, supplicano Litavicco di
prendersi cura di loro. "C'è forse bisogno di decidere?" risponde. "Non
dobbiamo forse dirigerci a Gergovia e unirci agli Averni? Oppure dubitiamo
che i Romani, dopo il loro empio crimine, esitino a gettarsi su di noi e a
massacrarci? Perciò, se ancora in noi è rimasto del coraggio, vendichiamo
la morte dei nostri, trucidati nel modo più indegno, uccidiamo questi
ladroni", e indica alcuni cittadini romani che, fidando nella sua
protezione. erano al suo seguito. Saccheggia frumento e viveri in
quantità, uccide i cittadini romani tra crudeli tormenti. Invia messi in
tutta la regione edua, solleva il popolo sempre con la falsa notizia della
strage dei cavalieri e dei principi. Esorta a seguire il suo esempio e a
vendicare le ingiurie.
[39
Su specifica richiesta di Cesare, si erano uniti alla cavalleria l'eduo
Eporedorige, giovane di alto lignaggio e di grande potenza tra i suoi, e
Viridomaro, altrettanto giovane e influente, ma di diversi natali, che
Cesare, dietro suggerimento di Diviziaco, aveva innalzato alle cariche più
alte nonostante le sue umili origini. I due lottavano per il primato tra
gli Edui, e durante la recente controversia per la magistratura si erano
battuti con ogni mezzo l'uno per Convictolitave, l'altro per Coto.
Eporedorige, quando scopre il piano di Litavicco, lo riferisce a Cesare
verso mezzanotte. Lo supplica di non permettere agli Edui di venir meno
all'alleanza con il popolo romano per colpa dei perfidi piani di alcuni
giovani, lo prega di tener conto delle conseguenze, se tante migliaia di
uomini si fossero unite ai nemici: la loro sorte non avrebbe lasciato
indifferenti i loro cari, né il popolo poteva stimarla cosa di poco conto.
[40
La notizia desta viva preoccupazione in Cesare, perché aveva sempre
nutrito una benevolenza particolare nei confronti degli Edui. Senza alcun
indugio guida fuori dall'accampamento quattro legioni prive di bagagli e
la cavalleria al completo. In quel frangente non si ebbe il tempo di
restringere il campo: l'esito dell'azione sembrava dipendere dalla
rapidità. A presidio dell'accampamento lascia il legato C. Fabio con due
legioni. Ordina di imprigionare i fratelli di Litavicco, ma viene a sapere
che poco prima erano fuggiti presso i nemici. Esorta i soldati a non
sgomentarsi, in un momento così critico, per le fatiche della marcia: tra
il fervore generale avanza di venticinque miglia e avvista la schiera
degli Edui. Manda in avanti la cavalleria e rallenta la loro avanzata, ma
dà ordine tassativo di non uccidere nessuno. A Eporedorige e Viridomaro,
che gli Edui credevano morti, comanda di rimanere tra i cavalieri e di
chiamare i loro. Appena riconoscono i capi e comprendono l'inganno di
Litavicco, gli Edui cominciano a tendere le mani in segno di resa, a
gettare le armi, a implorare la grazia. Litavicco con i suoi clienti -
secondo i costumi dei Galli non è lecito abbandonare i patroni neppure nei
momenti più gravi - ripara a Gergovia.
[41
Agli Edui Cesare invia messi per spiegare che per suo beneficio
risparmiava i loro, mentre avrebbe potuto farne strage secondo il diritto
di guerra. Di notte concede all'esercito tre ore di riposo, poi muove il
campo verso Gergovia. Quando aveva percorso circa metà del cammino, i
cavalieri inviati da C. Fabio gli espongono quali pericoli abbia corso il
campo. I nemici - illustrano - l'avevano attaccato in forze: truppe
fresche davano continuamente il cambio a chi era stanco, i nostri erano
spossati dalla fatica che non conosceva pause, perché le dimensioni
dell'accampamento li costringevano a rimanere sempre sul vallo. Molti
erano stati colpiti dai nugoli di frecce e proiettili d'ogni tipo
scagliati dai nemici; per resistere all'attacco, erano state di grande
utilità le macchine da lancio. Quando il nemico si era allontanato, Fabio
aveva barricato tutte le porte tranne due e aggiunto plutei al vallo,
preparandosi a un identico assalto per il giorno successivo. Conosciuta la
situazione, Cesare, grazie allo straordinario impegno dei soldati,
raggiunge l'accampamento prima dell'alba.
[42
Mentre a Gergovia tale era la situazione, gli Edui, alle prime notizie di
Litavicco, non perdono neppure un istante a sincerarsene. Chi spinto
dall'avidità, chi dall'iracondia e dall'avventatezza - è la loro
caratteristica congenita - tutti danno per sicura una voce priva di
fondamento. Saccheggiano i beni dei cittadini romani, ne fanno strage, li
rendono schiavi. Convictolitave dà l'ultima spinta a una situazione già in
bilico, aizza la folla, perché, una volta commesso il crimine, la vergogna
le impedisca di ritornare alla ragione. M. Aristio, tribuno militare, era
in marcia verso la legione: gli promettono via libera e lo lasciano uscire
dalla città di Cavillono. Con lui costringono alla partenza anche chi si
era lì stabilito per commercio. Appena i nostri si mettono in marcia,
però, li assalgono e li spogliano di tutti i bagagli. I nostri si
difendono, vengono assediati giorno e notte. Quando le perdite erano già
molte da entrambe le parti, i Galli chiamano alle armi una folla più
numerosa.
[43
Nel frattempo, giunge notizia che tutte le truppe edue sono sotto
l'autorità di Cesare: corrono da Aristio, gli spiegano che l'accaduto non
dipendeva certo da una delibera ufficiale. Aprono un'inchiesta sul
saccheggio, confiscano i beni di Litavicco e dei suoi fratelli, inviano
una legazione a Cesare per discolparsi. Si comportano così nel tentativo
di recuperare le proprie truppe, ma, macchiati dalla colpa commessa e
trattenuti dai guadagni del saccheggio - molti ne erano coinvolti - e
anche per timore di una punizione, assumono segretamente iniziative per
riprendere la guerra e sobillano gli altri popoli mediante ambascerie.
Anche se lo intuiva, Cesare tuttavia si rivolge agli emissari edui con le
parole più miti possibili: per via dell'incoscienza e della leggerezza del
popolo non voleva pronunciare una condanna troppo dura nei confronti degli
Edui, né intendeva diminuire la sua benevolenza verso di loro. Cesare, in
effetti, si aspettava una più grave sollevazione della Gallia e, per non
trovarsi circondato da tutti i popoli, stava valutando come lasciare
Gergovia e riunire nuovamente l'esercito, ma cercava di evitare che il suo
ripiegamento, dettato dal timore di una defezione, sembrasse una fuga.
[44
Mentre era immerso in tali pensieri, gli parve presentarsi un'occasione
favorevole. Infatti, quando giunse al campo minore per ispezionare i
lavori, notò che un colle, prima in mano nemica, era adesso sguarnito,
mentre nei giorni precedenti lo si poteva appena scorgere, tanti erano i
soldati che lo presidiavano. La cosa lo colpì e ne chiese spiegazione ai
disertori, che ogni giorno arrivavano al nostro campo in gran numero. Da
tutti risultava che, come Cesare già sapeva dagli esploratori, il dorso
del colle era quasi in piano, ma stretto e pieno di vegetazione nella
parte che conduceva dall'altro lato della città. I Galli nutrivano forti
apprensioni per questo punto e sapevano bene che si sarebbero visti
praticamente circondati, con ogni via d'uscita preclusa e i foraggiamenti
tagliati, se i Romani, già padroni di un colle, avessero preso anche
quest'altro. Quindi Vercingetorige aveva chiamato tutti a munire la zona.
[45
Saputo ciò, Cesare verso mezzanotte invia sul luogo vari squadroni di
cavalleria. Comanda di compiere scorrerie dappertutto, producendo un po'
più rumore del solito. All'alba fa uscire dal campo un gran numero di
bagagli e muli, ai mulattieri ordina di togliere il basto ai loro animali
e di mettersi l'elmo: fingendosi cavalieri, avrebbero dovuto aggirare il
colle. Invia con essi pochi cavalieri veri, che avevano l'incarico di
spingersi più lontano a scopo di simulazione. A tutti, poi, dà istruzione
di convergere su un unico punto dopo un lungo giro. Le nostre manovre
venivano scorte dalla città, perché da Gergovia la vista dava proprio sul
nostro accampamento, ma a tale distanza non era possibile comprendere che
cosa stesse accadendo con esattezza. Invia una legione verso il colle e,
dopo un certo tratto, la ferma ai piedi del rialzo e la tiene nascosta tra
la vegetazione. I sospetti dei Galli aumentano, mandano tutte le truppe ai
lavori di fortificazione. Cesare, appena vede il campo nemico sguarnito,
guida i soldati dal campo maggiore al minore, a piccoli gruppi, ordinando
di non applicare i fregi e di tener nascoste le insegne, per non essere
scorti dalla città. Ai legati preposti alle varie legioni spiega come
dovevano agire: primo, li ammonisce a tenere a freno i soldati, che non si
allontanassero troppo per desiderio di lotta o speranza di bottino;
illustra gli svantaggi della posizione; li si poteva eludere solo con la
rapidità; si trattava di un colpo di mano, non di una battaglia. Detto
ciò, dà il segnale e, al contempo, ordina agli Edui di sferrare l'attacco
da un altro lato, sulla destra.
[46
Le mura della città distavano dalla pianura e dall'inizio della salita
milleduecento passi in linea retta, se non ci fosse stata di mezzo nessuna
tortuosità. E tutte le curve che si aggiungevano per attenuare la salita,
aumentavano la distanza. Sul colle, a mezza altezza, i Galli avevano
costruito in senso longitudinale un muro di grosse pietre, alto sei piedi,
che assecondava la natura del monte e aveva lo scopo di frenare l'assalto
dei nostri. Tutta la zona sottostante era stata evacuata, mentre nella
parte superiore, fin sotto le mura della città, i Galli avevano posto
fittissime le tende del loro campo. Al segnale i legionari raggiungono
rapidamente il muro, lo superano e conquistano tre accampamenti. L'azione
fu così rapida, che Teutomato, re dei Nitiobrogi, sorpreso ancora nella
tenda durante il riposo pomeridiano, a stento riuscì a sfuggire ai nostri
in cerca di bottino, mezzo nudo, dopo che anche il suo cavallo era stato
colpito.
[47
Raggiunto lo scopo prefisso, Cesare ordinò di suonare la ritirata, si
fermò e tenne l'arringa alla decima legione, che era al suo seguito. I
soldati delle altre legioni, invece, pur non avendo udito il suono della
tromba, perché si frapponeva una valle abbastanza estesa, erano comunque
trattenuti dai tribuni militari e dai legati, secondo gli ordini di
Cesare. Trascinati, però, dalla speranza di una rapida vittoria, dalla
fuga dei nemici e dai successi precedenti, pensarono che non vi fosse
impresa impossibile per il loro valore. Così, non cessarono l'inseguimento
finché non ebbero raggiunto le mura e le porte della città. A quel punto,
da tutte le zone della città si levano alti clamori: i Galli che si erano
spinti più lontano, atterriti dal tumulto improvviso, pensando che il
nemico fosse entro le porte, si lanciarono fuori dalla città. Dalle mura
le madri di famiglia gettavano vesti e oggetti d'argento, a petto nudo si
sporgevano e con le mani protese scongiuravano i Romani di risparmiarle,
di non massacrare donne e bambini, come invece era accaduto ad Avarico.
Alcune, calate giù dalle altre a forza di braccia, si consegnavano ai
nostri soldati. Quel giorno stesso, a quanto constava, L. Fabio,
centurione dell'ottava legione, aveva detto ai suoi che lo riempiva
d'ardore il bottino di Avarico e che non avrebbe tollerato che un altro
scalasse le mura prima di lui. Infatti, con l'aiuto di tre soldati del suo
manipolo salì sulle mura; poi lì afferrò per mano uno a uno e, a sua volta
li sollevò.
[48
Nel frattempo, i nemici confluiti nella parte opposta della città per i
lavori di fortificazione, come abbiamo illustrato, ai primi clamori e alle
insistenti notizie che volevano la città caduta, lanciano in avanti la
cavalleria e accorrono in massa. Ciascuno di loro, come arrivava, si
piazzava ai piedi delle mura e infoltiva la schiera dei suoi. Quando si
era radunato un gruppo consistente, le madri di famiglia, che dalle mura
poco prima tendevano le mani verso i nostri, cominciarono a scongiurare i
loro, a sciogliersi i capelli secondo l'uso gallico, a mostrare i figli. I
Romani non combattevano a parità di condizioni, né per posizione, né per
numero. Inoltre, stanchi per la corsa e la durata dello scontro, reggevano
con difficoltà agli avversari freschi e riposati.
[49
Cesare si rese conto che la posizione era svantaggiosa e che le truppe
nemiche continuavano ad aumentare. Allora, in apprensione per i suoi,
inviò al legato T. Sestio, rimasto a presidio del campo minore, l'ordine
di far uscire rapidamente le sue coorti e di schierarle sul fianco destro
del nemico, ai piedi del colle: se i nostri venivano respinti, doveva
atterrire il nemico per rendergli difficile l'inseguimento. Rispetto al
luogo in cui si era fermato, Cesare aveva guidato la legione leggermente
più avanti e attendeva l'esito della battaglia.
[50
Si combatteva corpo a corpo, con asprezza: i nemici confidavano nella
posizione e nel numero, i Romani nel valore. All'improvviso comparvero sul
nostro fianco scoperto gli Edui, inviati da Cesare sulla destra per
dividere le truppe nemiche. Al loro arrivo, la somiglianza delle armi
galliche seminò il panico tra i nostri, che avevano sì visto il braccio
destro scoperto, segno convenzionale di riconoscimento, ma pensavano che
si trattasse di una mossa nemica per ingannarli. Al tempo stesso, il
centurione L. Fabio e i soldati che avevano scalato con lui la cinta,
circondati e uccisi, vengono precipitati dalle mura. M. Petronio,
centurione della stessa legione, mentre tentava di abbattere le porte, fu
sopraffatto da una massa di nemici. Ferito a più riprese, senza ormai
speranza di salvezza, gridò ai soldati del suo manipolo, che lo avevano
seguito: "Non posso salvarmi insieme a voi, ma voglio almeno preoccuparmi
della vostra vita, io che vi ho messo in pericolo per sete di gloria. Ne
avete la possibilità, pensate a voi stessi". E subito si lanciò
all'attacco nel folto dei nemici, ne uccise due e allontanò alquanto gli
altri dalla porta. Ai suoi che cercavano di corrergli in aiuto, disse:
"Tentate invano di soccorrermi, perdo troppo sangue e mi mancano le forze.
Perciò fuggite, finché ne avete modo, raggiungete la legione". Poco dopo
cadde, con le armi in pugno, ma fu la salvezza dei suoi.
[51
I nostri, pressati da ogni lato, vennero respinti e persero quarantasei
centurioni. Ma i Galli che si erano lanciati all'inseguimento con troppa
foga, li frenò la decima legione, che era schierata di rincalzo in una
zona un po' più pianeggiante. A sua volta, la decima ricevette sostegno
dalle coorti della tredicesima, che aveva lasciato il campo minore con il
legato T. Sestio e si era attestata su un rialzo. Le legioni, non appena
raggiunsero la pianura, volsero le insegne contro il nemico e presero
posizione. Vercingetorige chiamò entro le fortificazioni i suoi, che si
erano spinti fino ai piedi del colle. Quel giorno le nostre perdite
sfiorarono i settecento uomini.
[52
L'indomani Cesare ordinò l'adunata e rimproverò l'avventatezza e la smania
dei soldati: da soli avevano giudicato fin dove si doveva avanzare o come
bisognava agire, non si erano fermati al segnale di ritirata, né i tribuni
militari, né i legati erano riusciti a trattenerli. Spiegò quale peso
avesse un luogo svantaggioso e quali erano state le sue considerazioni ad
Avarico, quando, pur avendo sorpreso i nemici privi di comandante e di
cavalleria, aveva rinunciato a una vittoria sicura per evitare anche il
minimo danno nello scontro, e tutto perché la posizione era sfavorevole. E
quanto ammirava il loro coraggio - né le fortificazioni dell'accampamento,
né l'altezza dei monte, né le mura della città erano valsi a frenarli -
tanto biasimava la loro insubordinazione e arroganza, perché credevano di
saper valutare circa la vittoria e l'esito dello scontro meglio del
comandante. Da un soldato esigeva modestia e disciplina non meno che
valore e coraggio.
[53
Tenuto questo discorso, nella parte finale rinfrancò i soldati: non
dovevano turbarsi nell'animo per la sconfitta, né ascrivere al valore
nemico ciò che dipendeva solo dagli svantaggi del campo di battaglia. E
benché pensasse alla partenza, già prima considerata opportuna, guidò
fuori dal campo le legioni e le schierò in un luogo adatto.
Vercingetorige, non di meno, continuava a tenersi all'interno delle
fortificazioni e non scendeva in pianura. Allora Cesare, dopo una
scaramuccia tra le cavallerie, in cui riportò la meglio, ricondusse
l'esercito all'accampamento. Il giorno seguente si ripeté la stessa cosa.
Cesare, convinto di aver fatto quanto bastava per sminuire la baldanza dei
Galli e rinfrancare il morale dei nostri soldati, mosse il campo verso il
territorio degli Edui. Neppure allora i nemici si mossero
all'inseguimento. Il terzo giorno ricostruì i ponti sull'Allier e condusse
l'esercito sull'altra sponda.
[54
Qui, gli edui Viridomaro ed Eporedorige gli chiedono un colloquio e lo
mettono al corrente che Litavicco era partito con tutta la cavalleria alla
volta degli Edui per istigarli alla rivolta: occorreva che loro stessi lo
precedessero e rientrassero in patria per tenere a bada il popolo. Cesare
aveva già ricevuto molte prove della perfidia degli Edui e pensava che la
loro partenza avrebbe accelerato lo scoppio dell'insurrezione, tuttavia
decise di non trattenerli, per non dare l'idea di voler recare offese o di
nutrire timori. Prima della partenza, ai due illustrò i suoi meriti nei
confronti degli Edui: chi erano, quanto erano deboli quando li aveva
accolti sotto la sua protezione, costretti a barricarsi nelle città, con i
campi confiscati, privi di tutte le truppe, costretti a pagare un tributo
e a consegnare ostaggi, offesa gravissima; per contro, ricordò loro a
quale prosperità e potenza li aveva poi condotti, non solo fino a
recuperare il precedente stato, ma a raggiungere un grado di dignità e
prestigio mai conosciuti in passato. Con tale incarico li congedò.
[55
Novioduno era una città degli Edui sulle rive della Loira, in posizione
favorevole. Qui Cesare aveva raccolto tutti gli ostaggi della Gallia, il
grano, il denaro pubblico, gran parte dei bagagli suoi e dell'esercito,
qui aveva inviato molti cavalli acquistati in Italia e in Spagna per la
guerra in corso. Eporedorige e Viridomaro, non appena arrivarono a
Novioduno e seppero come andavano le cose tra gli Edui (avevano accolto
Litavicco a Bibracte, la loro città più importante; il magistrato
Convictolitave e la maggior parte del senato lo aveva raggiunto; a titolo
ufficiale erano stati inviati emissari a Vercingetorige per trattare pace
e alleanza), ritennero di non doversi lasciar sfuggire un'occasione
simile. Perciò, eliminarono la guarnigione di Novioduno e i commercianti
che lì risiedevano, si spartirono il denaro e i cavalli. Condussero a
Bibracte, dal magistrato, gli ostaggi dei vari popoli e, giudicando di non
poterla difendere, incendiarono la città, per impedire ai Romani di
servirsene. Tutto il grano che lì per lì riuscirono a caricare sulle navi,
lo trasportarono via, il resto lo gettarono in acqua o lo bruciarono.
Intrapresero la raccolta di truppe dalle regioni limitrofe, disposero
presidi e guarnigioni lungo la Loira, mentre la loro cavalleria compariva
in ogni zona per incutere timore, nella speranza di tagliare ai Romani
l'approvvigionamento di grano oppure di costringerli al ripiegamento in
provincia, dopo averli condotti allo stremo. Ad alimentare le loro
speranze contribuiva molto la Loira in piena per le nevi, al punto che
sembrava proprio impossibile guadarla.
[56
Appena ne fu informato, Cesare ritenne di dover accelerare i tempi: se
proprio doveva correre il rischio di costruire ponti, voleva combattere
prima che si radunassero lì truppe nemiche più consistenti. Infatti,
nessuno giudicava inevitabile modificare i piani e ripiegare verso la
provincia, neppure in quel frangente: oltre all'onta e alla vergogna, lo
impedivano i monti Cevenne e le strade impraticabili, che sbarravano il
cammino; ma, soprattutto, Cesare nutriva grande apprensione per Labieno
lontano e le legioni al suo seguito. Perciò, forzando al massimo le tappe
e marciando di giorno e di notte, giunge alla Loira contro ogni
aspettativa. I cavalieri trovano un guado adatto, almeno per quanto le
circostanze permettevano: restavano fuori dall'acqua solo le braccia e le
spalle per tenere sollevate le armi. Dispone la cavalleria in modo da
frangere l'impeto della corrente e guida sano e salvo l'esercito
sull'altra sponda, col nemico atterrito alla nostra vista. Nelle campagne
trova grano e una grande quantità di bestiame, con cui rifornisce in
abbondanza l'esercito. Dopo comincia la marcia sui Senoni.
[57
Mentre Cesare prendeva tali iniziative, Labieno lascia ad Agedinco, a
presidio delle salmerie, i rinforzi recentemente giunti dall'Italia e
punta su Lutezia con quattro legioni- Lutezia è una città dei Parisi che
sorge su un'isola della Senna. Quando i nemici vengono a sapere del suo
arrivo, raccolgono numerose truppe inviate dai popoli limitrofi. Il
comando supremo viene conferito all'aulerco Camulogeno, persona ormai
piuttosto anziana, chiamata a rivestire tale carica per la sua
straordinaria perizia in campo militare. Camulogeno, avendo notato una
palude interminabile, che alimentava la Senna e rendeva poco praticabile
tutta la zona, vi si stabilì e si apprestò a sbarrare la strada ai nostri.
[58
Labieno prima tentò di spingere in avanti le vinee, di riempire la palude
con fascine e zolle e di costruirsi un passaggio. Quando capi che
l'operazione era troppo difficile, dopo mezzanotte uscì in silenzio
dall'accampamento e raggiunse Metlosedo per la stessa strada da cui era
venuto. Metlosedo è una città dei Senoni che sorge su un'isola della
Senna, come Lutezia, di cui si è detto. Cattura circa cinquanta navi, le
collega rapidamente e imbarca i soldati. Gli abitanti (i pochi rimasti,
perché la maggior parte era lontana in guerra) rimangono atterriti
dall'evento improvviso: Labieno prende la città senza neppure combattere.
Ricostruisce il ponte distrutto dai nemici nei giorni precedenti, guida
l'esercito sull'altra sponda e punta su Lutezia, seguendo il corso del
fiume. I nemici, avvertiti dai fuggiaschi di Metlosedo, ordinano di
incendiare Lutezia e di distruggere i ponti della città. Abbandonano la
palude e si attestano lungo le rive della Senna, davanti a Lutezia,
proprio di fronte a Labieno.
[59
Era già corsa voce della partenza di Cesare da Gergovia e giungevano
notizie sulla defezione degli Edui e sui successi dell'insurrezione; nei
loro abboccamenti, i Galli confermavano che Cesare si era trovato la
strada sbarrata dalla Loira e che aveva ripiegato verso la provincia,
costretto dalla mancanza di grano. I Bellovaci, poi, che già in passato di
per sé non si erano dimostrati alleati fedeli, alla notizia della
defezione degli Edui avevano cominciato la raccolta di truppe e scoperti
preparativi di guerra. Allora Labieno, di fronte a un tale mutamento della
situazione, capiva di dover prendere decisioni ben diverse dai suoi piani
e non mirava più a riportare successi o a provocare il nemico a battaglia,
ma solo a ricondurre incolume l'esercito ad Agedinco. Infatti, su un
fronte incombevano i Bellovaci, che in Gallia godono fama di straordinario
valore, sull'altro c'era Camulogeno con l'esercito pronto e schierato.
Inoltre, un fiume imponente separava le legioni dal presidio e dalle
salmerie. Con tante, improvvise difficoltà, vedeva che era necessario far
ricorso a un atto di coraggio.
[60
Verso sera convoca il consiglio di guerra e incita a eseguire gli ordini
con scrupolo e impegno. Ciascuna delle navi portate da Metlosedo viene
affidata a un cavaliere romano. Li incarica di discendere in silenzio,
dopo le nove di sera, il fiume per quattro miglia e di attendere lì il suo
arrivo. Lascia a presidio dell'accampamento le cinque coorti che riteneva
meno valide per il combattimento. Alle altre cinque della stessa legione
comanda di partire con tutti i bagagli dopo mezzanotte e di risalire il
corso del fiume con molto baccano. Si procura anche zattere: spinte a
forza di remi con grande frastuono, le invia nella stessa direzione. Dal
canto suo, poco dopo lascia in silenzio il campo alla testa di tre legioni
e raggiunge il punto dove le navi dovevano approdare.
[61
Appena giungono, i nostri sopraffanno gli esploratori nemici - ce n'erano
lungo tutto il fiume - cogliendoli alla sprovvista per lo scoppio di un
violento temporale. Sotto la guida dei cavalieri romani preposti alle
operazioni, l'esercito e la cavalleria passano velocemente sull'altra
riva. Quasi nello stesso istante, verso l'alba, i nemici vengono informati
che un tumulto insolito regnava nel campo romano e che una schiera
numerosa risaliva il fiume, mentre nella stessa direzione si udivano colpi
di remi e, un po' più in basso, altri soldati trasbordavano su nave. A
tale notizia, i nemici si convincono che le legioni stavano varcando il
fiume in tre punti e si apprestavano alla fuga, sconvolte dalla defezione
degli Edui. Allora anch'essi suddivisero in tre reparti le truppe.
Lasciarono un presidio proprio di fronte all'accampamento e inviarono
verso Metlosedo un piccolo contingente, che doveva avanzare a misura di
quanto procedevano le navi. Poi, guidarono il resto dell'esercito contro
Labieno.
[62
All'alba tutti i nostri avevano ormai varcato il fiume ed erano in vista
della schiera nemica. Labieno esorta i soldati a ricordarsi dell'antico
valore e delle loro grandissime vittorie, a far conto che fosse presente
Cesare in persona, sotto la cui guida tante volte avevano battuto il
nemico. Quindi, dà il segnale d'attacco. Al primo assalto, all'ala destra,
dove era schierata la settima legione, il nemico viene respinto e
costretto alla fuga; sulla sinistra, settore presidiato dalla dodicesima
legione, le prime file dei Galli erano cadute sotto i colpi dei
giavellotti, ma gli altri resistevano con estrema tenacia e nessuno dava
segni di fuga. Il comandante nemico stesso, Camulogeno, stava al fianco
dei suoi e li incoraggiava. E l'esito dello scontro era ancora incerto,
quando ai tribuni militari della settima legione venne riferito come
andavano le cose all'ala sinistra: la legione comparve alle spalle del
nemico e si lanciò all'attacco. Nessuno dei Galli, neppure allora,
abbandonò il proprio posto, ma tutti vennero circondati e uccisi. La
stessa sorte toccò a Camulogeno. I soldati nemici rimasti come presidio di
fronte al campo di Labieno, non appena seppero che si stava combattendo,
mossero in aiuto dei loro e si attestarono su un colle, ma non riuscirono
a resistere all'assalto dei nostri vittoriosi. Così, si unirono agli altri
in fuga: chi non trovò riparo nelle selve o sui monti, venne massacrato
dalla nostra cavalleria. Portata a termine l'impresa, Labieno rientra ad
Agedinco, dove erano rimaste le salmerie di tutto l'esercito. Da qui, con
tutte le truppe raggiunge Cesare.
[63
Quando si viene a sapere della defezione degli Edui, la guerra divampa
ancor più. Si inviano ambascerie ovunque: ogni risorsa a loro
disposizione, che fosse il prestigio, l'autorità o il denaro, la impiegano
per sollevare gli altri popoli. Sfruttano gli ostaggi lasciati da Cesare
in loro custodia, minacciano di metterli a morte e, così, spaventano chi
ancora esita. Gli Edui chiedono a Vercingetorige di raggiungerli per
concertare una strategia comune. Ottenuto ciò, pretendono il comando
supremo. La cosa sfocia in una controversia, viene indetto un concilio di
tutta la Gallia a Bibracte. Arrivano da ogni regione, in gran numero. La
questione è messa ai voti. Tutti, nessuno escluso, approvano
Vercingetorige come capo. Al concilio non parteciparono i Remi, i Lingoni,
i Treveri: i primi due perché rimanevano fedeli all'alleanza con Roma; i
Treveri perché erano troppo distanti e pressati dai Germani, motivo per
cui non parteciparono mai alle operazioni di questa guerra e non inviarono
aiuti a nessuno dei due contendenti. Per gli Edui è un duro colpo la
perdita del primato, lamentano il cambiamento di sorte e rimpiangono
l'indulgenza di Cesare nei loro confronti. Ma la guerra era ormai
iniziata, ed essi non osano separarsi dagli altri. Loro malgrado,
Eporedorige e Viridomaro, giovani molto ambiziosi, obbediscono a
Vercingetorige.
[64
Vercingetorige impone ostaggi agli altri popoli e ne fissa la data di
consegna. Ordina che tutti i cavalieri, in numero di quindicimila, lì si
radunino rapidamente. Quanto alla fanteria, diceva, si sarebbe
accontentato delle truppe che aveva già prima. Non avrebbe tentato la
sorte o combattuto in campo aperto; aveva una grande cavalleria, era assai
facile impedire ai Romani l'approvvigionamento di grano e foraggio;
bastava che i Galli si rassegnassero a distruggere le proprie scorte e a
incendiare le case: la perdita dei beni privati, lo vedevano anch'essi,
significava autonomia e libertà perpetue. Dopo aver così deciso, agli Edui
e ai Segusiavi, che confinano con la provincia, impone l'invio di
diecimila fanti. Vi aggiunge ottocento cavalieri. Ne affida il comando al
fratello di Eporedorige e gli ordina di attaccare gli Allobrogi. Sul
versante opposto, contro gli Elvi manda i Gabali e le tribù di confine
degli Arverni, mentre invia i Ruteni e i Cadurci a devastare le terre dei
Volci Arecomici. Non di meno, con emissari clandestini e ambascerie
sobilla gli Allobrogi, perché sperava che dall'ultima sollevazione i loro
animi non si fossero ancora assopiti. Ai capi degli Allobrogi promette
denaro, al popolo invece, il comando di tutta la provincia.
[65
Per far fronte a ogni evenienza, i nostri avevano provveduto a disporre un
presidio di ventidue coorti: arruolate nella provincia stessa dal legato
L. Cesare, formavano uno sbarramento lungo tutto il fronte. Gli Elvi,
scesi per proprio conto a battaglia con i popoli limitrofi, vengono
respinti e sono costretti a rifugiarsi all'interno delle loro città e
mura, dopo aver registrato gravi perdite: tra i tanti altri, era caduto C.
Valerio Domnotauro, figlio di Caburo e loro principe. Gli Allobrogi
dislocano parecchi presidi lungo il Rodano, sorvegliano con cura e
attenzione i propri territori. Cesare capiva che la cavalleria nemica era
superiore e che, con tutte le strade tagliate, non poteva contare su
rinforzi dalla provincia e dall'Italia. Allora invia emissari oltre il
Reno, in Germania, alle genti da lui sottomesse negli anni precedenti:
chiede cavalleria e fanti armati alla leggera, abituati a combattere tra i
cavalieri. Appena arrivano, Cesare, notando che montavano su cavalli non
di razza, requisisce i destrieri dei tribuni militari, degli altri
cavalieri romani e dei richiamati e li distribuisce ai Germani.
[66
Nel frattempo, mentre accadevano tali fatti, giungono le truppe degli
Arverni e i cavalieri che tutta la Gallia doveva fornire. Mentre
raccoglievano, così, ingenti truppe, Cesare attraversa i più lontani
territori dei Lingoni alla volta dei Sequani, allo scopo di portare aiuto
con maggior facilità alla provincia. Vercingetorige si stabilisce a circa
dieci miglia dai Romani, in tre distinti accampamenti. Convoca i
comandanti della cavalleria e spiega che l'ora della vittoria è giunta: i
Romani fuggivano in provincia, lasciavano la Gallia; al momento era
sufficiente a ottenere la libertà, ma per il futuro non garantiva pace e
quiete; i Romani avrebbero raccolto truppe più consistenti, sarebbero
ritornati, non avrebbero posto fine alla guerra. Perciò bisognava
attaccarli in marcia, quando erano impacciati dai bagagli. Se i legionari
soccorrevano gli altri e si attardavano, non potevano proseguire la
marcia; se abbandonavano le salmerie e pensavano a salvare la vita - e
sarebbe andata così, ne era certo - perdevano ogni bene di prima necessità
e, insieme, l'onore. Quanto ai cavalieri nemici, nessuno avrebbe osato
nemmeno uscire dallo schieramento, non c'era dubbio. E perché muovessero
all'attacco con maggior ardimento, avrebbe tenuto dinnanzi al campo tutte
le truppe e atterrito il nemico. I cavalieri galli acclamano: bisognava
giurare solennemente che si negava un tetto e la possibilità di avvicinare
figli, genitori o moglie a chi, sul proprio cavallo, non attraversava per
due volte le linee nemiche.
[67
La proposta viene approvata e tutti prestano giuramento. Il giorno
seguente dividono la cavalleria in tre gruppi: due compaiono sui fianchi
del nostro schieramento, la terza comincia a contrastarci il passo
all'avanguardia. Appena glielo comunicano, Cesare divide la cavalleria in
tre parti e ordina di affrontare il nemico. Si combatteva
contemporaneamente in ogni settore. L'esercito si ferma, le salmerie
vengono raccolte in mezzo alle legioni. Se in qualche zona i nostri
sembravano in difficoltà o troppo alle strette, lì Cesare ordinava di
muovere all'attacco e di formare la linea. La manovra ritardava
l'inseguimento nemico e rinfrancava i nostri con la speranza del sostegno.
Alla fine, i Germani all'ala destra respingono i nemici, sfruttando un
alto colle: inseguono i fuggiaschi sino al fiume, dove Vercingetorige si
era attestato con la fanteria, e ne uccidono parecchi. Appena se ne
accorgono, gli altri si danno alla fuga, temendo l'accerchiamento. È
strage ovunque. Tre Edui di stirpe assai nobile vengono catturati e
condotti a Cesare: Coto, il comandante della cavalleria. che aveva avuto
nell'ultima elezione un contrasto con Convictolitave; Cavarillo, preposto
alla fanteria dopo la defezione di Litavicco; Eporedorige, sotto la cui
guida gli Edui avevano combattuto contro i Sequani prima dell'arrivo di
Cesare.
[68
Vista la rotta della cavalleria, Vercingetorige ritirò le truppe schierate
dinnanzi all'accampamento e mosse direttamente verso Alesia, città dei
Mandubi, ordinando di condurre rapidamente le salmerie fuori dal campo e
di seguirlo. Cesare porta i bagagli sul colle più vicino e vi lascia due
legioni come presidio. Lo insegue finché c'è luce: uccide circa tremila
uomini della retroguardia e il giorno successivo si accampa davanti ad
Alesia. Esaminata la posizione della città e tenuto conto che i nemici
erano atterriti, perché era stata messa in fuga la loro cavalleria, ossia
il reparto su cui più confidavano, esorta i soldati all'opera e comincia a
circondare Alesia con un vallo.
[69
La città di Alesia sorgeva sulla cima di un colle molto elevato, tanto che
l'unico modo per espugnarla sembrava l'assedio. I piedi del colle, su due
lati, erano bagnati da due fiumi. Davanti alla città si stendeva una
pianura lunga circa tre miglia; per il resto, tutt'intorno, la cingevano
altri colli di uguale altezza, poco distanti l'uno dall'altro. Sotto le
mura, la parte del colle che guardava a oriente brulicava tutta di truppe
galliche; qui, in avanti, avevano scavato una fossa e costruito un muro a
secco alto sei piedi. Il perimetro della cinta di fortificazione iniziata
dai Romani raggiungeva le dieci miglia. Si era stabilito l'accampamento in
una zona vantaggiosa, erano state costruite ventitré ridotte: di giorno vi
alloggiavano corpi di guardia per prevenire attacchi improvvisi, di notte
erano tenute da sentinelle e saldi presidi.
[70
Quando i lavori erano già iniziati, le cavallerie vengono a battaglia
nella pianura che si stendeva tra i colli per tre miglia di lunghezza,
come abbiamo illustrato. Si combatte con accanimento da entrambe le parti.
In aiuto dei nostri in difficoltà, Cesare invia i Germani e schiera le
legioni di fronte all'accampamento, per impedire un attacco improvviso
della fanteria nemica. Il presidio delle legioni infonde coraggio ai
nostri. I nemici sono messi in fuga: numerosi com'erano, si intralciano e
si accalcano a causa delle porte, costruite troppo strette. I Germani li
inseguono con maggior veemenza fino alle fortificazioni. Ne fanno strage:
alcuni smontano da cavallo e tentano di superare la fossa e di scalare il
muro. Alle legioni schierate davanti al vallo Cesare ordina di avanzare
leggermente. Un panico non minore prende i Galli all'interno delle
fortificazioni: pensano a un attacco imminente, gridano di correre alle
armi. Alcuni, sconvolti dal terrore, si precipitano in città.
Vercingetorige comanda di chiudere le porte, perché l'accampamento non
rimanesse sguarnito. Dopo aver ucciso molti nemici e catturato parecchi
cavalli, i Germani ripiegano.
[71
Vercingetorige prende la decisione di far uscire di notte tutta la
cavalleria, prima che i Romani portassero a termine la linea di
fortificazione. Alla partenza, raccomanda a tutti di raggiungere ciascuno
la propria gente e di raccogliere per la guerra tutti gli uomini che, per
età, potevano portare le armi. Ricorda i suoi meriti nei loro confronti,
li scongiura di tener conto della sua vita, di non abbandonarlo al
supplizio dei nemici, lui che tanti meriti aveva nella lotta per la
libertà comune. E se avessero svolto il compito con minor scrupolo,
insieme a lui avrebbero perso la vita ottantamila uomini scelti. Fatti i
conti, aveva grano a malapena per trenta giorni, ma se lo razionava,
poteva resistere anche un po' di più. Con tali compiti, prima di
mezzanotte fa uscire, in silenzio, la cavalleria nel settore dove i nostri
lavori non erano ancora arrivati. Ordina la consegna di tutto il grano;
fissa la pena capitale per chi non avesse obbedito; quanto al bestiame,
fornito in grande quantità dai Mandubi, distribuisce a ciascuno la sua
parte; fa economia di grano e comincia a razionarlo; accoglie entro le
mura tutte le truppe prima schierate davanti alla città. Prese tali
misure, attende i rinforzi della Gallia e si prepara a guidare le
operazioni.
[72
Cesare, appena ne fu informato dai fuggiaschi e dai prigionieri, approntò
una linea di fortificazione come segue: scavò una fossa di venti piedi,
con le pareti verticali, facendo sì che la larghezza del fondo
corrispondesse alla distanza tra i bordi superiori; tutte le altre opere
difensive le costruì più indietro, a quattrocento piedi dalla fossa:
avendo dovuto abbracciare uno spazio così vasto e non essendo facile
dislocare soldati lungo tutto il perimetro, voleva impedire che i nemici,
all'improvviso o nel corso della notte, piombassero sulle nostre
fortificazioni, oppure che durante il giorno potessero scagliare dardi sui
nostri occupati nei lavori. A tale distanza, dunque, scavò due fosse della
stessa profondità, larghe quindici piedi. Delle due, la più interna,
situata in zone pianeggianti e basse, venne riempita con acqua derivata da
un fiume. Ancor più indietro innalzò un terrapieno e un vallo di dodici
piedi, a cui aggiunse parapetto e merli, con grandi pali sporgenti dalle
commessure tra i plutei e il terrapieno allo scopo di ritardare la scalata
dei nemici. Lungo tutto il perimetro delle difese innalzò torrette
distanti ottanta piedi l'una dall'altra.
[73
Bisognava contemporaneamente cercare legna e frumento e costruire
fortificazioni così imponenti, mentre i nostri effettivi non facevano che
diminuire, perché i soldati si allontanavano sempre più dal campo. E alle
volte i Galli assalivano le nostre difese e dalla città tentavano sortite
da più porte, con grande slancio. Perciò, Cesare ritenne opportuno
aggiungere altre opere alle fortificazioni già approntate, per poterle
difendere con un numero minore di soldati. Allora tagliò tronchi d'albero
con i rami molto robusti, li scortecciò e li rese molto aguzzi sulla
punta; poi, scavò fosse continue per la profondità di cinque piedi. Qui
piantò i tronchi e, perché non li potessero svellere, li legò alla base,
lasciando sporgere i rami. A cinque a cinque erano le file, collegate tra
loro e raccordate: chi vi entrava, rimaneva trafitto sui pali acutissimi.
Li chiamammo cippi. Davanti ai cippi scavò buche profonde tre piedi,
leggermente più strette verso il fondo e disposte per linee oblique, come
il cinque nei dadi. Vi conficcò tronchi lisci, spessi quanto una coscia,
molto aguzzi e induriti col fuoco sulla punta, non lasciandoli sporgere
dal terreno più di quattro dita. Inoltre, per renderli ben fermi e saldi,
in basso aggiunse terra per un piede d'altezza e la pressò; il resto del
tronco venne ricoperto di vimini e arbusti per nascondere l'insidia. Ne
allineò otto file, distanti tre piedi l'una dall'altra. Le denominammo,
per la somiglianza con il fiore, gigli. Davanti a esse vennero interrati
pioli lunghi un piede, forniti di un artiglio di ferro: ne disseminammo un
po' ovunque, a breve distanza. Presero il nome di stimoli.
[74
Terminate tali opere, seguendo i terreni più favorevoli per conformazione
naturale, costruì una linea difensiva dello stesso genere, lunga
quattordici miglia, ma opposta alla prima, contro un nemico proveniente
dalle spalle: così, anche nel caso di un attacco in massa dopo la sua
partenza, gli avversari non avrebbero potuto circondare i presidi delle
fortificazioni, né i nostri si sarebbero trovati costretti a sortite
rischiose. Ordina a tutti di portare con sé foraggio e grano per trenta
giorni.
[75
Così andavano le cose ad Alesia. Nel frattempo, i Galli indicono un
concilio dei capi, stabiliscono di non chiamare alle armi tutti gli uomini
abili, come aveva chiesto Vercingetorige, ma di imporre ad ogni popolo la
consegna di un contingente determinato, perché temevano che fosse
impossibile, tra tanta confusione di popoli, mantenere la disciplina,
riconoscere le proprie truppe, amministrare le provviste di grano. Agli
Edui e ai loro alleati, ossia i Segusiavi, gli Ambivareti, gli Aulerci
Brannovici, i Blannovi, ordinano di fornire trentacinquemila uomini;
altrettanti agli Arverni insieme agli Eleuteti, ai Cadurci, ai Gabali, ai
Vellavi, da tempo clienti degli Arverni stessi; ai Sequani, ai Senoni, ai
Biturigi, ai Santoni, ai Ruteni, ai Carnuti dodicimila ciascuno; ai
Bellovaci diecimila; ottomila ciascuno ai Pictoni, ai Turoni, ai Parisi e
agli Elvezi; agli Ambiani, ai Mediomatrici, ai Petrocori, ai Nervi, ai
Morini, ai Nitiobrogi cinquemila ciascuno; altrettanti agli Aulerci
Cenomani; agli Atrebati quattromila; ai Veliocassi, ai Lexovi e agli
Aulerci Eburovici tremila ciascuno; ai Rauraci e ai Boi mille ciascuno;
ventimila a tutti quei popoli che si affacciano sull'Oceano e che, come
dicono loro stessi, si chiamano Aremorici, tra i quali ricordiamo i
Coriosoliti, i Redoni, gli Ambibari, i Caleti, gli Osismi, i Lemovici, gli
Unelli. Di tutti i popoli citati, solo i Bellovaci non inviarono il
contingente completo, dicendo che avrebbero mosso guerra ai Romani per
proprio conto e arbitrio e che non avrebbero preso ordini da nessuno.
Tuttavia, su preghiera di Commio, in ragione dei vincoli di ospitalità che
li legavano a lui, inviarono duemila soldati.
[76
Dei fidati e preziosi servigi di Commio, Cesare si era avvalso negli anni
precedenti, lo abbiamo detto. In cambio, aveva decretato che gli Atrebati
fossero esenti da tributi, aveva loro restituito diritto e leggi e
assegnato la tutela dei Morini. Ma il consenso della Gallia, che voleva
riacquistare l'indipendenza e recuperare l'antica gloria militare, era
così unanime, da rendere chiunque insensibile anche ai benefici e al
ricordo dell'amicizia: tutti si gettavano nel conflitto col cuore e con
ogni risorsa. Vengono raccolti ottomila cavalieri e circa
duecentoquarantamila fanti; nelle terre degli Edui si procede a passarli
in rassegna, a contarli, a nominare gli ufficiali. Il comando supremo
viene affidato all'atrebate Commio, agli edui Viridomaro ed Eporedorige,
all'arverno Vercassivellauno, cugino di Vercingetorige. A essi vengono
affiancati alcuni rappresentanti dei vari popoli, che formavano il
consiglio per condurre le operazioni. Pieni di ardore e di fiducia si
dirigono ad Alesia. Nessuno credeva possibile reggere alla vista di un
tale esercito, tanto meno in uno scontro su due fronti, quando i Romani,
mentre combattevano per una sortita dalla città, avessero scorto alle loro
spalle truppe di fanteria e cavalleria così imponenti.
[77
Ma gli assediati in Alesia, scaduto il giorno previsto per l'arrivo dei
rinforzi ed esaurite tutte le scorte di grano, ignari di ciò che stava
accadendo nelle terre degli Edui, convocarono un'assemblea e si
consultarono sull'esito della propria sorte. E tra i vari pareri - c'era
chi propendeva per la resa, chi per una sortita, finché le forze bastavano
- crediamo di non dover tralasciare il discorso di Critognato per la sua
straordinaria ed empia crudeltà. Persona di altissimo lignaggio tra gli
Arverni e molto autorevole, così parlò: "Non spenderò una parola riguardo
al parere di chi chiama resa una vergognosissima schiavitù: costoro non li
considero cittadini e non dovrebbero avere neppure il diritto di
partecipare all'assemblea. È mia intenzione rivolgermi a chi approva la
sortita, soluzione che conserva l'impronta dell'antico valore, tutti voi
ne convenite. Non essere minimamente capaci di sopportare le privazioni,
non è valore, ma debolezza d'animo. È più facile trovare volontari pronti
alla morte piuttosto che gente disposta a sopportare pazientemente il
dolore. E anch'io - tanto è forte in me il senso dell'onore - sarei dello
stesso avviso, se vedessi derivare un danno solo per la nostra vita. Ma
nel prendere la decisione, rivolgiamo gli occhi a tutta la Gallia, che
abbiamo chiamato in soccorso. Quale sarà, secondo voi, lo stato d'animo
dei nostri parenti e consanguinei, quando vedranno ottantamila uomini
uccisi in un sol luogo e dovranno combattere quasi sui nostri cadaveri?
Non negate il vostro aiuto a chi, per salvare voi, non ha curato pericoli.
Non prostrate la Gallia intera, non piegatela a una servitù perpetua a
causa della vostra stoltezza e imprudenza o per colpa della fragilità del
vostro animo. Sì, i rinforzi non sono giunti nel giorno fissato, ma per
questo dubitate della loro lealtà e costanza? E allora? Credete che ogni
giorno i Romani là, nelle fortificazioni esterne, lavorino per
divertimento? Se non potete ricevere una conferma perché le vie sono tutte
tagliate, prendete allora i Romani come testimonianza del loro imminente
arrivo: è il timore dei nostri rinforzi che li spinge a lavorare giorno e
notte alle fortificazioni. Che cosa suggerisco, dunque? Di imitare i
nostri padri quando combattevano contro i Cimbri e i Teutoni, in una
guerra che non aveva nulla a che vedere con la nostra: costretti a
chiudersi nelle città e a patire come noi dure privazioni, si mantennero
in vita con i corpi di chi, per ragioni d'età, sembrava inutile alla
guerra, e non si arresero ai nemici. Se non avessimo già un precedente del
genere, giudicherei giusto istituirlo per la nostra libertà e tramandarlo
ai posteri come fulgido esempio. E poi, quali somiglianze ci sono tra la
loro guerra e la nostra? I Cimbri, devastata la Gallia e seminata rovina,
si allontanarono una buona volta dalle nostre campagne e si diressero
verso altre terre, lasciandoci il nostro diritto, le leggi, i campi, la
libertà. I Romani, invece, che altro cercano o vogliono, se non stanziarsi
nelle campagne e città di qualche popolo, spinti dall'invidia, appena
sanno che è nobile e forte in guerra? Oppure che altro, se non
assoggettarlo in un'eterna schiavitù? Non hanno mai mosso guerra con altre
intenzioni. E se ignorate le vicende delle regioni più lontane, volgete
gli occhi alla Gallia limitrofa, ridotta a provincia: ha mutato il diritto
e le leggi, è soggetta alle scuri e piegata in una perpetua servitù".
[78
Espressi i vari pareri, decidono di allontanare dalla città chi, per
malattia o età, non poteva combattere e di tentare tutto prima di
risolversi alla proposta di Critognato; tuttavia, in caso di necessità o
di ritardo dei rinforzi, bisognava giungere a un tale passo piuttosto che
accettare condizioni di resa o di pace. I Mandubi, che li avevano accolti
nella loro città, sono costretti a partire con i figli e le mogli. Giunti
ai piedi delle difese romane, tra le lacrime e con preghiere d'ogni
genere, supplicavano i nostri di prenderli come schiavi e di dar loro del
cibo. Ma Cesare, disposte sentinelle sul vallo, impediva di accoglierli.
[79
Nel frattempo, Commio e gli altri capi, a cui era stato conferito il
comando, giungono ad Alesia con tutte le truppe, occupano il colle esterno
e si attestano a non più di un miglio dalle nostre difese. Il giorno
seguente mandano in campo la cavalleria e riempiono tutta la pianura che
si stendeva per tre miglia, come sopra ricordato. Quanto alla fanteria, la
dispongono poco distante, nascosta sulle alture. Dalla città di Alesia la
vista dominava sulla pianura. Appena scorgono i rinforzi, i Galli
accorrono: esultano, gli animi di tutti si schiudono alla gioia. Così,
guidano le truppe fuori dalle mura e si schierano di fronte alla città,
coprono la prima fossa con fascine, la colmano di terra si preparano
all'attacco, al tutto per tutto.
[80
Cesare dispone l'esercito lungo entrambe le linee fortificate, perché
ciascuno, in caso di necessità, conoscesse il proprio posto e lì si
schierasse. Poi, guida la cavalleria fuori dal campo e ordina di dar
inizio alla battaglia. Da ogni punto del campo, situato sulla cima del
colle, la vista dominava; tutti i soldati, ansiosi, aspettavano l'esito
dello scontro. I Galli tenevano in mezzo alla cavalleria pochi arcieri e
fanti dall'armatura leggera, che avevano il compito di soccorrere i loro
quando ripiegavano e di frenare l'impeto dei nostri cavalieri. Gli arcieri
e i fanti avevano colpito alla sprovvista parecchi dei nostri,
costringendoli a lasciare la mischia. Da ogni parte tutti i Galli, sia chi
era rimasto all'interno delle difese, sia chi era giunto in rinforzo,
convinti della loro superiorità e vedendo i nostri pressati dalla loro
massa, incitavano i loro con grida e urla. Lo scontro si svolgeva sotto
gli occhi di tutti, perciò nessun atto di coraggio o di viltà poteva
sfuggire: il desiderio di gloria e la paura dell'ignominia spronavano al
valore gli uni e gli altri. Si combatteva da mezzogiorno, il tramonto era
ormai vicino e l'esito era ancora incerto, quand'ecco che, in un settore,
a ranghi serrati i cavalieri germani caricarono i nemici e li volsero in
fuga. Alla ritirata della cavalleria, gli arcieri vennero circondati e
uccisi. Anche nelle altre zone i nostri inseguirono fino all'accampamento
i nemici in fuga, senza permetter loro di raccogliersi. I Galli che da
Alesia si erano spinti in avanti, mesti, disperando o quasi della
vittoria, cercarono rifugio in città.
[81
I Galli lasciarono passare un giorno, durante il quale approntarono una
gran quantità di fascine, scale, ramponi. A mezzanotte, in silenzio,
escono dall'accampamento e si avvicinano alle nostre fortificazioni di
pianura. All'improvviso lanciano alte grida: era il segnale convenuto per
avvisare del loro arrivo chi era in città. Si apprestano a gettare
fascine, a disturbare i nostri sul vallo con fionde, frecce e pietre, ad
azionare ogni macchina che serve in un assalto. Contemporaneamente, appena
sente le grida, Vercingetorige dà ai suoi il segnale con la tromba e li
guida fuori dalla città. I nostri raggiungono le fortificazioni, ciascuno
nel posto che gli era stato assegnato nei giorni precedenti. Usando fionde
che lanciano proiettili da una libbra e con pali disposti sulle difese,
atterriscono i Galli e li respingono. Le tenebre impediscono la vista,
gravi sono le perdite in entrambi gli schieramenti. Le macchine da lancio
scagliano nugoli di frecce. E i legati M. Antonio e C. Trebonico cui era
toccata la difesa di questi settori, chiamano rinforzi dalle ridotte più
lontane e li mandano nelle zone dove capivano che i nostri si trovavano in
difficoltà.
[82
Finché i Galli erano abbastanza distanti dalle nostre fortificazioni,
avevano un certo vantaggio, per il nugolo di frecce da loro lanciate; una
volta avvicinatisi, invece, presi alla sprovvista, finivano negli stimoli
o cadevano nelle fosse rimanendo trafitti oppure venivano uccisi dai
giavellotti scagliati dal vallo e dalle torri. In tutti i settori subirono
parecchie perdite e non riuscirono a far breccia in nessun punto;
all'approssimarsi dell'alba ripiegarono, nel timore che i nostri
tentassero una sortita dall'accampamento più alto e li accerchiassero dal
fianco scoperto. E gli assediati, intenti a spingere in avanti le macchine
preparate da Vercingetorige per la sortita e a riempire le prime fosse,
mentre procedevano con troppa lentezza, vengono a sapere che i loro si
erano ritirati prima di aver raggiunto le nostre difese. Così, senza aver
concluso nulla, rientrano in città.
[83
I Galli, respinti due volte con gravi perdite, si consultano sul da farsi.
Chiamano gente pratica della zona. Da essi apprendono com'era disposto e
fortificato il nostro accampamento superiore. A nord c'era un colle che,
per la sua estensione, i nostri non avevano potuto abbracciare nella linea
difensiva: erano stati costretti a porre il campo in una posizione quasi
sfavorevole, in leggera pendenza. Il campo era occupato dai legati C.
Antistio Regino e C. Caninio Rebilo con due legioni. Gli esploratori
effettuano un sopralluogo della zona, mentre i comandanti nemici scelgono
sessantamila soldati tra tutti i popoli ritenuti più valorosi. In segreto
mettono a punto il piano e le modalità d'azione. Fissano l'ora
dell'attacco verso mezzogiorno. Il comando delle truppe suddette viene
affidato all'arverno Vercassivellauno, uno dei quattro capi supremi,
parente di Vercingetorige. Vercassivellauno uscì dal campo dopo le sei di
sera e giunse quasi a destinazione poco prima dell'alba, si nascose dietro
il monte e ordinò ai soldati di riposarsi dopo la fatica della marcia
notturna. Quando ormai sembrava avvicinarsi mezzogiorno, puntò
sull'accampamento di cui abbiamo parlato. Al contempo, la cavalleria
cominciò ad accostarsi alle nostre difese di pianura e le truppe rimanenti
comparvero dinnanzi al loro campo.
[84
Vercingetorige vede i suoi dalla rocca di Alesia ed esce dalla città.
Porta fascine, pertiche, ripari, falci e ogni altra arma preparata per la
sortita. Si combatte contemporaneamente in ogni zona, tutte le nostre
difese vengono attaccate: dove sembravano meno salde, là i nemici
accorrevano. Le truppe romane sono costrette a dividersi per l'estensione
delle linee, né è facile respingere gli attacchi sferrati
contemporaneamente in diversi settori. Il clamore che si alza alle spalle
dei nostri, mentre combattevano, contribuisce molto a seminare il panico,
perché capivano che la loro vita era legata alla salvezza degli altri: i
pericoli che non stanno dinnanzi agli occhi, in genere, turbano con
maggior intensità le menti degli uomini.
[85
Cesare, trovato un punto di osservazione adatto, vede che cosa accade in
ciascun settore. Invia aiuti a chi è in difficoltà. I due eserciti sentono
che è il momento decisivo, in cui occorreva lottare allo spasimo: i Galli,
se non forzavano la nostra linea, perdevano ogni speranza di salvezza; i
Romani, se tenevano, si aspettavano la fine di tutti i travagli. Lo
scontro era più aspro lungo le fortificazioni sul colle, dove, lo abbiamo
detto, era stato inviato Vercassivellauno. La posizione sfavorevole dei
nostri, in salita, aveva un peso determinante. Dei Galli, alcuni scagliano
dardi, altri formano la testuggine e avanzano. Forze fresche danno il
cambio a chi è stanco. Tutti quanti gettano sulle difese molta terra, che
permette ai Galli la scalata e ricopre le insidie nascoste nel terreno dai
Romani. Ai nostri, ormai, mancano le armi e le forze.
[86
Quando lo viene a sapere, a rinforzo di chi si trova in difficoltà Cesare
invia Labieno con sei coorti. Gli ordina, se non riusciva a respingere
l'attacco, di portar fuori le coorti e di tentare una sortita, ma solo in
caso di necessità estrema. Dal canto suo, raggiunge gli altri, li esorta a
non cedere, spiega che in quel giorno, in quell'ora era riposto ogni
frutto delle battaglie precedenti. I nemici sul fronte interno, disperando
di poter forzare le difese di pianura, salde com'erano, attaccano i
dirupi, cercando di scalarli: sulla sommità ammassano tutte le armi
approntate. Con nugoli di frecce scacciano i nostri difensori dalle torri,
riempiono le fosse con terra e fascine, spezzano il vallo e il parapetto
mediante falci.
[87
Cesare prima invia il giovane Bruto con alcune coorti, poi il legato C.
Fabio con altre. Alla fine egli stesso, mentre si combatteva sempre più
aspramente, reca in aiuto forze fresche. Capovolte le sorti dello scontro
e respinti i nemici, si dirige dove aveva inviato Labieno. Preleva quattro
coorti dalla ridotta più vicina e ordina che parte della cavalleria lo
segua, parte aggiri le difese esterne e attacchi il nemico alle spalle.
Poiché né i terrapieni, né le fosse valevano a frenare l'impeto dei
nemici, Labieno raduna trentanove coorti, che la sorte gli permise di
raccogliere dalle ridotte più vicine. Quindi, invia a Cesare messaggeri
per informarlo delle sue intenzioni.
[88
Cesare si affretta, per prendere parte alla battaglia. I nemici, dominando
dall'alto i declivi e i pendii dove transitava Cesare, mossero
all'attacco, non appena notarono il suo arrivo per il colore del mantello
che di solito indossava in battaglia e videro gli squadroni di cavalleria
e le coorti che avevano l'ordine di seguirlo. Entrambi gli eserciti levano
alte grida, un grande clamore risponde dal vallo e da tutte le
fortificazioni. I nostri lasciano da parte i giavellotti e mettono mano
alle spade. All'improvviso compare la cavalleria dietro i nemici. Altre
coorti stavano accorrendo: i Galli volgono le spalle. I cavalieri
affrontano gli avversari in fuga. È strage. Sedullo, comandante e principe
dei Lemovici aremorici, cade; l'arverno Vercassivellauno è catturato vivo,
mentre tentava la fuga; a Cesare vengono portate settantaquattro insegne
militari; di tanti che erano, solo pochi nemici raggiungono salvi
l'accampamento. Dalla città vedono il massacro e la ritirata dei loro:
persa ogni speranza di salvezza, richiamano le truppe dalle
fortificazioni. Appena odono il segnale di ritirata, i Galli fuggono
dall'accampamento. E se i nostri soldati non avessero risentito delle
continue azioni di soccorso e della fatica di tutta la giornata, avrebbero
potuto annientare le truppe avversarie. Verso mezzanotte la cavalleria si
muove all'inseguimento della retroguardia nemica: molti vengono catturati
e uccisi; gli altri, proseguendo la fuga, raggiungono i rispettivi popoli.
[89
Il giorno seguente, Vercingetorige convoca l'assemblea e spiega che quella
guerra l'aveva intrapresa non per proprio interesse, ma per la libertà
comune. E giacché si doveva cedere alla sorte, si rimetteva ai Galli,
pronto a qualsiasi loro decisione, sia che volessero ingraziarsi i Romani
con la sua morte o che volessero consegnarlo vivo. A tale proposito viene
inviata una legazione a Cesare, che esige la resa delle armi e la consegna
dei capi dei vari popoli. Pone il suo seggio sulle fortificazioni,
dinnanzi all'accampamento: qui gli vengono condotti i comandanti galli,
Vercingetorige si arrende, le armi vengono gettate ai suoi piedi. A
eccezione degli Edui e degli Arverni, tutelati nella speranza di poter
riguadagnare, tramite loro, le altre genti, Cesare distribuisce, a titolo
di preda, i prigionieri dei rimanenti popoli a tutto l'esercito, uno a
testa.
[90
Terminate le operazioni, parte verso le terre degli Edui; accetta la resa
del loro popolo. Qui lo raggiungono emissari degli Arverni che promettono
obbedienza, ordina la consegna di un gran numero di ostaggi. Invia le
legioni ai campi invernali. Restituisce agli Edui e agli Arverni circa
ventimila prigionieri. Ordina a T. Labieno di recarsi nella regione dei
Sequani con due legioni e la cavalleria e pone ai suoi ordini M. Sempronio
Rutilo. Alloggia il legato C. Fabio e L. Minucio Basilo con due legioni
nei territori dei Remi, per proteggere quest'ultimi da eventuali attacchi
dei Bellovaci. Manda C. Antistio Regino tra gli Ambivareti, T. Sestio
presso i Biturigi, C. Caninio Rebilo tra i Ruteni, ciascuno alla testa di
una legione. Pone Q. Tullio Cicerone e P. Sulpicio a Cavillono e
Matiscone, lungo la Saona, nelle terre degli Edui, incaricandoli di
provvedere ai rifornimenti di grano. Dal canto suo, decide di svernare a
Bibracte. Quando a Roma si ha notizia dell'accaduto da una lettera di
Cesare, gli vengono tributati venti giorni di feste solenni di
ringraziamento. |
LIBER OCTAVUS
(ab A. Hirtio scriptus)
Coactus assiduis tuis vocibus, Balbe, cum cotidiana mea recusatio non difficultatis excusationem, sed inertiae videretur deprecationem habere, rem difficillimam suscepi. Caesaris nostri commentarios rerum gestarum Galliae, non comparantibus superioribus atque insequentibus eius scriptis, contexui novissimumque imperfectum ab rebus gestis Alexandriae confeci usque ad exitum non quidem civilis dissensionis, cuius finem nullum videmus, sed vitae Caesaris. Quos utinam qui legent scire possint quam invitus susceperim scribendos, qua facilius caream stultitiae atque arrogantiae crimine, qui me mediis interposuerim Caesaris scriptis. Constat enim inter omnes nihil tam operose ab aliis esse perfectum, quod non horum elegantia commentariorum superetur: qui sunt editi, ne scientia tantarum rerum scriptoribus deesset, adeoque probantur omnium iudicio ut praerepta, non praebita, facultas scriptoribus videatur. Cuius tamen rei maior nostra quam reliquorum est admiratio: ceteri enim, quam bene atque emendate, nos etiam, quam facile atque celeriter eos perfecerit scimus. Erat autem in Caesare cum facultas atque elegantia summa scribendi, tum verissima scientia suorum consiliorum explicandorum. Mihi ne illud quidem accidit, ut Alexandrino atque Africano bello interessem; quae bella quamquam ex parte nobis Caesaris sermone sunt nota, tamen aliter audimus ea, quae rerum novitate aut admiratione nos capiunt, aliter, quae pro testimonio sumus dicturi. Sed ego nimirum, dum omnes excusationis causas colligo ne cum Caesare conferar, hoc ipsum crimen arrogantiae subeo, quod me iudicio cuiusquam existimem posse cum Caesare comparari. Vale.
[1] Omni Gallia devicta Caesar cum a superiore aestate nullum bellandi tempus intermisisset militesque hibernorum quiete reficere a tantis laboribus vellet, complures eodem tempore civitates renovare belli consilia nuntiabantur coniurationesque facere. Cuius rei verisimilis causa adferebatur, quod Gallis omnibus cogrutum esset neque ulla multitudine in unum locum coacta resisti posse Romanis, nec, si diversa bella complures eodem tempore intulissent civitates, satis auxili aut spati aut copiarum habiturum exercitum populi Romani ad omnia persequenda; non esse autem alicui civitati sortem incommodi recusandam, si tali mora reliquae possent se vindicare in libertatem.
[2] Quae ne opinio Gallorum confirmaretur, Caesar Marcum Antonium quaestorem suis praefecit hibernis; ipse equitum praesidio pridie Kal. Ianuarias ab oppido Bibracte proficiscitur ad legionem XIII, quam non longe a finibus Aeduorum collocaverat in finibus Biturigum, eique adiungit legionem XI, quae proxima fuerat. Binis cohortibus ad impedimenta tuenda relictis reliquum exercitum in copiosissimos agros Biturigum inducit, qui, cum latos fines et complura oppida haberent, unius legionis hibernis non potuerint contineri quin bellum pararent coniurationesque facerent.
[3] Repentino adventu Caesaris accidit, quod imparatis disiectisque accidere fuit necesse, ut sine timore ullo rura colentes prius ab equitatu opprimerentur quam confugere in oppida possent. Namque etiam illud vulgare incursionis hostium signum, quod incendiis aedificiorum intellegi consuevit, Caesaris erat interdicto sublatum, ne aut copia pabuli frumentique, si longius progredi vellet, deficeretur, aut hostes incendius terrerentur. Multis hominum milibus captis perterriti Bituriges; qui primum adventum potuerant effugere Romanorum, in finitimas civitates aut privatis hospitiis confisi aut societate consiliorum confugerant. Frustra: nam Caesar magni sitineribus omnibus locis occurrit nec dat ulli civitati spatium de aliena potius quam de domestica salute cogitandi; qua celeritate et fideles amicos retinebat et dubitantes terrore ad condiciones pacis adducebat. Tali condicione proposita Bituriges, cum sibi viderent clementia Caesaris reditum patere in eius amicitiam finitimasque civitates sine ulla poena dedisse obsides atque in fidem receptas esse, idem fecerunt.
[4] Caesar militibus pro tanto labore ac patientia, qui brumalibus diebus itineribus difficillimis, frigoribus intolerandis studiosissime permanserant in labore, ducenos sestertios, centurionibus tot milia nummum praedae nomine condonanda pollicetur legionibusque in hiberna remissis ipse se recipit die XXXX Bibracte. Ibi cum ius diceret, Bituriges ad eum legatos mittunt auxilium petitum contra Carnutes, quos intulisse bellum sibi querebantur. Qua re cognita, cum dies non amplius decem et octo in hibernis esset moratus, legiones XIIII et VI ex hibernis ab Arare educit, quas ibi collocatas explicandae rei frumentariae causa superiore commentario demonstratum est: ita cum duabus legionibus ad persequendos Carnutes proficiscitur.
[5] Cum fama exercitus ad hostes esset perlata, calamitate ceterorum ducti Carnutes desertis vicis oppidisque, quae tolerandae hiemis causa constitutis repente exiguis ad necessitatem aedificiis incolebant (nuper enim devicti complura oppida dimiserant), dispersi profugiunt. Caesar erumpentes eo maxime tempore acerrimas tempestates cum subire milites nollet, in oppido Carnutum Cenabo castra ponit atque in tecta partim Gallorum, partim quae coniectis celeriter stramentis tentoriorum integendorum gratia erant inaedificata, milites compegit. Equites tamen et auxiliarios pedites in omnes partes mittit quascumque petisse dicebantur hostes; nec frustra: nam plerumque magna praeda potiti nostri revertuntur. Oppressi Carnutes hiemis difficultate, terrore periculi, cum tectis expulsi nullo loco diutius consistere auderent nec silvarum praesidio tempestatibus durissimis tegi possent, dispersi magna parte amissa suorum dissipantur in finitimas civitates.
[6] Caesar tempore anni difficillimo, cum satis haberet convenientes manus dissipare, ne quod initium belli nasceretur, quantumque in ratione esset, exploratum haberet sub tempus aestivorum nullum summum bellum posse conflari, Gaium Trebonium cum duabus legionibus, quas secum habebat, in hibernis Cenabi collocavit; ipse, cum crebris legationibus Remorum certior fieret Bellovacos, qui belli gloria Gallos omnes Belgasque praestabant, finitimasque his civitates duce Correo Bellovaco et Commio Atrebate exercitus comparare atque in unum locum cogere, ut omni multitudine in fines Suessionum, qui Remis erant attributi, facerent impressionem, pertinere autem non tantum ad dignitatem sed etiam ad salutem suam iudicaret nullam calamitatem socios optime de re publica meritos accipere, legionem ex hibernis evocat rursus undecimam; litteras autem ad Gaium Fabium mittit, ut in fines Suessionum legiones duas quas habebat adduceret, alteramque ex duabus ab Labieno arcessit. Ita, quantum hibernorum opportunitas bellique ratio postulabat, perpetuo suo labore in vicem legionibus expeditionum onus iniungebat.
[7] His copiis coactis ad Bellovacos proficiscitur castrisque in eorum finibus positis equitum turmas dimittit in omnes partes ad aliquos excipiendos ex quibus hostium consilia cognosceret. Equites officio functi renuntiant paucos in aedificiis esse inventos, atque hos, non qui agrorum colendorum causa remansissent (namque esse undique diligenter demigratum), sed qui speculandi causa essent remissi. A quibus cum quaereret Caesar quo loco multitudo esset Bellovacorum quodve esset consilium eorum, inveniebat Bellovacos omnes qui arma ferre possent in unum locum convenisse, itemque Ambianos, Aulercos, Caletos, Veliocasses, Atrebatas; locum castris excelsum in silva circumdata palude delegisse, impedimenta omnia in ulteriores silvas contulisse. Complures esse principes belli auctores, sed multitudinem maxime Correo obtemperare, quod ei summo esse odio nomen populi Romani intellexissent. Paucis ante diebus ex his castris Atrebatem Commium discessisse ad auxilia Germanorum adducenda; quorum et vicinitas propinqua et multitudo esset infinita. Constituisse autem Bellovacos omnium principum consensu, summa plebis cupiditate, si, ut diceretur, Caesar cum tribus legionibus veniret, offerre se ad dimicandum, ne miseriore ac duriore postea condicione cum toto exercitu decertare cogerentur; si maiores copias adduceret, in eo loco permanere quem delegissent, pabulatione autem, quae propter anni tempus cum exigua tum disiecta esset, et frumentatione et reliquo commeatu ex insidiis prohibere Romanos.
[8] Quae Caesar consentientibus pluribus cum cognosset atque ea quae proponerentur consilia plena prudentiae longeque a temeritate barbarorum remota esse iudicaret, omnibus rebus inserviendum statuit, quo celerius hostis contempta sua paucitate prodiret in aciem. Singularis enim virtutis veterrimas legiones VII, VIII, VIIII habebat, summae spei delectaeque iuventutis XI, quae octavo iam stipendio tamen in collatione reliquarum nondum eandem vetustatis ac virtutis ceperat opinionem. Itaque consilio advocato, rebus eis quae ad se essent delatae omnibus eitis animos multitudinis confirmat. Si forte hostes trium legionum numero posset elicere ad dimicandum, agminis ordinem ita constituit, ut legio septima, octava, nona ante omnia irent impedimenta, deinde omnium impedimentorum agmen, quod tamen erat mediocre, ut in expeditionibus esse consuevit, cogeret undecima, ne maioris multitudinis species accidere hostibus posset quam ipsi depoposcissent. Hac ratione paene quadrato agmine instructo in conspectum hostium celerius opinione eorum exercitum adducit.
[9] Cum repente instructas velut in acie certo gradu legiones accedere Galli viderent, quorum erant ad Caesarem plena fiduciae consilia perlata, sive certamiuis periculo sive subito adventu sive exspectatione nostri consili copias instruunt pro castris nec loco superiore decedunt. Caesar, etsi dimicare optaverat, tamen admiratus tantam multitudinem hostium valle intermissa magis in altitudinem depressa quam late patente castra castris hostium confert. Haec imperat vallo pedum XII muniri, loriculam pro
[hac] ratione eius altitudinis inaedificari; fossam duplicem pedum denum quinum lateribus deprimi directis; turres excitari crebras in altitudinem trium tabulatorum, pontibus traiectis constratisque coniungi, quorum frontes viminea loricula munirentur; ut ab hostibus duplici fossa, duplici propugnatorum ordine defenderentur, quorum alter ex pontibus, quo tutior altitudine esset, hoc audacius longiusque permitteret tela, alter, qui propior hostem in ipso vallo collocatus esset, ponte ab incidentibus telis tegeretur. Portis fores altioresque turres imposuit.
[10] Huius munitionis duplex erat consilium. Namque et operum magnitudinem et timorem suum sperabat fiduciam barbaris allaturum, et cum pabulatum frumentatumque longius esset proficiscendum, parvis copiis castra munitione ipsa videbat posse defendi. Interim crebro paucis utrimque procurrentibus inter bina castra palude interiecta contendebatur; quam tamen paludem nonnumquam aut nostra auxilia Gallorum Germanorumque transibant acriusque hostes insequebantur, aut vicissim hostes eadem transgressi nostros longius summovebant. Accidebat autem cotidianis pabulationibus (id quod accidere erat necesse, cum raris disiectisque ex aedificius pabulum conquireretur), ut impeditis locis dispersi pabulatores circumvenirentur; quae res, etsi mediocre detrimentum iumentorum ac servorum nostris adferebat, tamen stultas cogitationes incitabat barbarorum, atque eo magis, quod Commius, quem profectum ad auxilia Germanorum arcessenda docui, cum equitibus venerat; qui, tametsi numero non amplius erant quingenti, tamen Germanorum adventu barbari nitebantur.
[11] Caesar, cum animadverteret hostem complures dies castris palude et loci natura munitis se tenere neque oppugnari castra eorum sine dimicatione perniciosa nec locum munitionibus claudi nisi a maiore exercitu posse, litteras ad Trebonium mittit, ut quam celerrime posset legionem XIlI, quae cum T. Sextio legato in Biturigibus hiemabat, arcesseret atque ita cum tribus legionibus magnis itineribus ad se veniret; ipse equites in vicem Remorum ac Lingonum reliquarumque civitatum, quorum magnum numerum evocaverat, praesidio pabulationibus mittit, qui subitas hostium incursiones sustinerent.
[12] Quod cum cotidie fieret ac iam consuetudine diligentia minueretur, quod plerumque accidit diu turnitate, Bellovaci delecta manu peditum cognitis stationibus cotidianis equitum nostrorum silvestribus locis insidias disponunt eodemque equites postero die mittunt, qui primum elicerent nostros, deinde circumventos aggrederentur. Cuius mali sors incidit Remis, quibus ille dies fungendi muneris obvenerat. Namque hi, cum repente hostium equites animad vertissent ac numero superiores paucitatem contempsissent, cupidius insecuti peditibus undique sunt circumdati. Quo facto perturbati celerius quam consuetudo fert equestris proeli se receperunt amisso Vertisco, principe civitatis, praefecto equitum; qui cum vix equo propter aetatem posset uti, tamen consuetudine Gallorurn neque aetatis excusatione in suscipienda praefectura usus erat neque dimicari sine se voluerat. Inflantur atque incitantur hostium animi secundo proelio, principe et praefecto Remorum interfecto, nostrique detrimento admonentur diligentius exploratis locis stationes disponere ac mode ratius cedentem insequi hostem.
[13] Non intermittunt interim cotidiana proelia in conspectu utrorumque castrorum, quae ad vada transitus que fiebant paludis. Qua contentione Germani, quos propterea Caesar traduxerat Rhenum ut equitibus interpositi proeliarentur, cum constantius universi paludem transissent paucisque resistentibus interfectis pertinacius reliquam multitudinem essent insecuti, perterriti non solum ei qui aut comminus opprimebantur aut eminus vulnerabantur, sed etiam qui longius subsidiari consuerant, turpiter refugerunt, nec prius finem fugae fecerunt saepe amissis superioribus locis quam se aut in castra suorum reciperent, aut nonnulli pudore coacti longius profugerent. Quorum periculo sic omnes copiae sunt perturbatae ut vix iudicari posset, utrum secundis minimisque rebus insolentiores an adverso mediocri casu timidiores essent.
[14] Compluribus diebus isdem in castris consumptis, cum propius accessisse legiones et Gaium Trebonium legatum cognossent, duces Bellovacorum veriti similem obsessionem Alesiae noctu dimittunt eos quos aut aetate aut viribus inferiores aut inermes habebant, unaque reliqua impedimenta. Quorum perturbatum et confusum dum explicant agmen (magna enim multitudo carrorum etiam expeditos sequi Gallos consuevit), oppressi luce copias armatorum pro suis instruunt castris, ne prius Romani persequi se inciperent quam longius agmen impedimentorum suorum processisset. At Caesar neque resistentes adgrediendos tanto collis ascensu iudicabat, neque non usque eo legiones admovendas ut discedere ex eo loco sine periculo barbari militibus instantibus non possent. Ita, cum palude impedita a castris castra dividi videret, quae trans eundi difficultas celeritatem insequendi tardare posset, adque id iugum quod trans paludem paene ad hostium castra pertineret mediocri valle a castris eorum intercisum animum adverteret, pontibus palude constrata legiones traducit celeriterque in summam planitiem iugi pervenit, quae declivi fastigio duobus ab lateribus muniebatur. Ibi legionibus instructis ad ultimum iugum pervenit aciemque eo loco constituit unde tormento missa tela in llostium cuneos conici possent.
[15] Barbari confisi loci natura, cum dimicare non recusarent, si forte Romani subire collem conarentur, paulatim copias distributas dimittere non possent, ne dispersi perturbarentur, in acie permanserunt. Quorum pertinacia cogruta Caesar XX cohortibus instructis castrisque eo loco metatis muniri iubet castra. Absolutis operibus pro vallo legiones instructas collocat, equites frenatis equis in statione disponit. Bellovaci, cum Romanos ad insequendum paratos viderent neque pernoctare aut diutius permanere sine periculo eodem loco possent, tale consilium sui recipiendi ceperunt. Fasces, ubi consederant (namque in acie sedere Gallos consuesse superioribus commentariis Caesaris declaratum est), per manus stramentorum ac virgultorum, quorum summa erat in castris copia, inter se traditos ante aciem collocarunt extremoque tempore diei signo pronuntiato uno tempore incenderunt. Ita continens flamma copias omnes repente a conspectu texit Romanorum. Quod ubi accidit, barbari vehementissimo cursu refugerunt.
[16] Caesar, etsi discessum hostium animadvertere non poterat incendiis oppositis, tamen id consilium cum fugae causa initum suspicaretur, legiones promovet, turmas mittit ad insequendum; ipse veritus insidias, ne forte in eodem loco subsistere hostis atque elicere nostros in locum conaretur iniquum, tardius procedit. Equites cum intrare fumum et flammam densissimam timerent ac, si qui cupidius intraverant, vix suorum ipsi priores partes animadverterent equorum, insidias veriti liberam facultatem sui recipiendi Bellovacis dederunt. Ita fuga timoris simul calliditatisque plena sine ullo detrimento milia non amplius decem progressi hostes loco munitissimo castra posuerunt. Inde cum saepe in insidiis equites peditesque disponerent, magna detrimenta Romanis in pabulationibus inferebant.
[17] Quod cum crebrius accideret, ex captivo quodam comperit Caesar Correum, Bellovacorum ducem, fortissimorum milia sex peditum delegisse equitesque ex omni numero mille, quos in insidiis eo loco collocaret, quem in locum propter copiam frumenti ac pabuli Romanos missuros suspicaretur. Quo cognito consilio legiones plures quam solebat educit equitatumque, qua consuetudine pabulatoribus mittere praesidio consuerat, praemittit: huic interponit auxilia levis armaturae; ipse cum legionibus quam potest maxime appropinquat.
[18] Hostes in insidus dispositi, cum sibi delegissent campum ad rem gerendam non amplius patentem in omnes partes passibus mille, silvis undique aut impeditissimo flumine munitum, velut indagine hunc insidiis circumdederunt. Explorato hostium consilio nostri ad proeliandum animo atque armis parati, cum subsequentibus legionibus nullam dimicationem recusarent, turmatim in eum locum devenerunt. Quorum adventu cum sibi Correus oblatam occasionem rei gerendae existimaret, primum cum paucis se ostendit atque in proximas turmas impetum fecit. Nostri constanter incursum sustinent insidiatorum neque plures in unum locum conveniunt; quod plerumque equestribus proeliis cum propter aliquem timorem accidit, tum multitudine ipsorum detrimentum accipitur.
[19] Cum dispositis turmis in vicem rari proeliarentur neque ab lateribus circumveniri suos paterentur, erumpunt ceteri Correo proeliante ex silvis. Fit magna contentione diversum proelium. Quod cum diutius pari Marte iniretur, paulatim ex silvis instructa multitudo procedit peditum, quae nostros coegit cedere equites. Quibus celeriter subveniunt levis armaturae pedites, quos ante legiones missos docui, turmisque nostrorum interpositi constanter proeliantur. Pugnatur aliquamdiu pari contentione; deinde, ut ratio postulabat proeli, qui sustinuerant primos impetus insidiarum hoc ipso fiunt superiores, quod nullum ab insidiantibus imprudentes acceperant detrimentum. Accedunt propius interim legiones, crebrique eodem tempore et nostris et hostibus nuntii adferuntur, imperatorem instructis copiis adesse. Qua re cognita praesidio cohortium confisi nostri acerrime proeliantur, ne, si tardius rem gessissent, victoriae gloriam communicasse cum legionibus viderentur; hostes concidunt animis atque itineribus diversis fugam quaerunt. Nequiquam: nam quibus difficultatibus locorum Romanos claudere voluerant, eis ipsi tenebantur. Victi tamen perculsique maiore parte amissa consternati profugiunt partim silvis petitis, partim flumine (qui tamen in fuga a nostris acriter insequentibus conficiuntur), eum interim nulla calamitate victus Correus excedere proelio silvasque petere aut invitantibus nostris ad deditionem potuit adduci, quin fortissime proeliando compluresque vulnerando cogeret elatos iracundia victores in se tela conicere.
[20] Tali modo re gesta recentibus proeli vestigiis ingressus Caesar, cum victos tanta calamitate existimaret hostes nuntio accepto locum castrorum relicturos, quae non longius ab ea caede abesse plus minus octo milibus dicebantur, tametsi flumine impeditum transitum videbat, tamen exercitu traducto progreditur. At Bellovaci reliquaeque civitates repente ex fuga paucis atque his vulneratis receptis, qui silvarum benefieio casum evitaverant, omnibus adversis, cognita calamitate, interfecto Correo, amisso equitatu et fortissimis pcditibus, cum adventare Romanos existimarent, concilio repente cantu tubarum convocato conclamant, legati obsidesque ad Caesarem mittantur.
[21] Hoc omnibus probato consilio Commius Atrebas ad eos confugit Germanos, a quibus ad id bellum auxilia mutuatus erat. Ceteri e vestigio mittunt ad Caesarem legatos petuntque, ut ea poena sit contentus hostium, quam si sine dimicatione inferre integris posset, pro sua clementia atque humanitate numquam profecto esset illaturus. Adflictas opes equestri proelio Bellovacorum esse; delectorum peditum multa milia interisse, vix refugisse nuntios caedis. Tamen magnum ut in tanta calamitate Bellovacos eo proelio commodum esse consecutos, quod Correus, auctor belli, concitator multitudinis, esset interfectus. Numquam enim senatum tantum in civitate illo vivo quantum imperitam plebem potuisse.
[22] Haec orantibus legatis commemorat Caesar: Eodem tempore superiore anno Bellovacos ceterasque Galliae civitates suscepisse bellum: pertinacissime hos ex omnibus in sententia permansisse neque ad sanitatem reliquorum deditione esse perductos. Scire atque intellegere se causam peccati facillime mortuis delegari. Neminem vero tantum pollere, ut invitis principibus, resistente senatu, omnibus bonis repugnantibus infirma manu plebis bellum concitare et gerere posset. Sed tamen se contentum fore ea poena quam sibi ipsi contraxissent.
[23] Nocte insequenti legati responsa ad suos referunt, obsides conficiunt. Concurrunt reliquarum civitatium legati, quae Bellovacorum speculabantur eventum; obsides dant, imperata faciunt excepto Commio, quem timor prohibebat cuiusquam fidei suam committere salutem. Nam superiore anno Titus Labienus, Caesare in Gallia citeriore ius dicente, cum Commium comperisset sollicitare civitates et coniurationem contra Caesarem facere, infidelitatem eius sine ulla perfidia iudicavit comprimi posse. Quem quia non arbitrabatur vocatum in castra venturum, ne temptando cautiorem faceret, Gaium Volusenum Quadratum misit, qui eum per simulationem colloqui curaret interficiendum. Ad eam rem delectos idoneos ei tradit centuriones. Cum in colloquium ventum esset, et, ut convenerat, manum Commi Volusenus arripuisset, centurio vel insueta re permotus vel celeriter a familiaribus prohibitus Commi conficere hominem non potuit; graviter tamen primo ictu gladio caput percussit. Cum utrimque gladii destricti essent, non tam pugnandi quam diffugiendi fuit utrorumque consilium: nostrorum, quod mortifero vulnere Commium credebant adfectum; Gallorum, quod insidius cognitis plura quam videbant extimescebant. Quo facto statuisse Commius dicebatur numquam in conspectum cuiusquam Romani venire.
[24] Bellicosissimis gentibus devictis Caesar, cum videret nullam iam esse civitatem quae bellum pararet quo sibi resisteret, sed nonnullos ex oppidis demigrare, ex agris diffugere ad praesens imperium evitandum, plures in partes exercitum dimittere constituit. M. Antonium quaestorem cum legione duodecima sibi coniungit. C. Fabium legatum cum cohortibus XXV mittit in diversissimam partem Galliae, quod ibi quasdam civitates in armis esse audiebat neque C. Caninium Rebilum legatum, qui in illis regionibus erat, satis firmas duas legiones habere existimabat. Titum Labienum ad se evocat; legionem autem XV, quae cum eo fuerat in hibernis, in togatam Galliam mittit ad colonias civium Romanorum tuendas, ne quod simile incommodum accideret decursione barbarorum ac superiore aestate Tergestinis acciderat, qui repentino latrocinio atque impetu illorum erant oppressi. Ipse ad vastandos depopulandosque fines Ambiorigis proficiscitur; quem perterritum ac fugientem cum redigi posse in suam potestatem desperasset, proximum suae dignitatis esse ducebat, adeo fines eius vastare civibus, aedificiis, pecore, ut odio suorum Ambiorix, si quos fortuna reliquos fecisset, nullum reditum propter tantas calamitates haberet in civitatem.
[25] Cum in omnes partes finium Ambiorigis aut legiones aut auxilia dimisisset atque omnia caedibus, incendius, rapinis vastasset, magno numero hominum interfecto aut capto Labienum cum duabus legionibus in Treveros mittit, quorum civitas propter Germaniae vicinitatem cotidianis exercitata bellis cultu et feritate non multum a Germanis differebat neque imperata umquam nisi exercitu coacta faciebat.
[26] Interim Gaius Caninius legatus, cum magnam multitudinem convenisse hostium in fines Pictonum litteris nuntiisque Durati cognosceret, qui perpetuo in amicitia manserat Romanorum, cum pars quaedam civitatis eius defecisset, ad oppidum Lemonum contendit. Quo cum adventaret atque ex captivis certius cognosceret multis hominum milibus a Dumnaco, duce Andium, Duratium clausum Lemoni oppugnari neque infirmas legiones hostibus committere auderet, castra posuit loco munito. Dumnacus, cum appropinquare Caninium cognosset, copiis omnibus ad legiones conversis castra Romanorum oppugnare instituit. Cum complures dies in oppugnatione consumpsisset et magno suorum detrimento nullam partem munitionum convellere potuisset, rursus ad obsidendum Lemonum redit.
[27] Eodem tempore C. Fabius legatus complures civitates in fidem recipit, obsidibus firmat litterisque Gai Canini Rebili fit certior quae in Pictonibus gerantur. Quibus rebus cognitis proficiscitur ad auxilium Duratio ferendum. At Dumnacus adventu Fabi cognito desperata salute, si tempore eodem coactus esset et Romanum externum sustinere hostem et respicere ac timere oppidanos, repente ex eo loco cum copiis recedit nec se satis tutum fore arbitratur, nisi flumine Ligeri, quod erat ponte propter magnitudinem transeundum, copias traduxisset. Fabius, etsi nondum in conspectum venerat hostibus neque se Caninio coniunxerat, tamen doctus ab eis qui locorum noverant naturam potissimum credidit hostes perterritos eum locum, quem petebant, petituros. Itaque cum copiis ad eundem pontem contendit equitatumque tantum procedere ante agmen imperat legionum, quantum cum processisset, sine defatigatione equorum in eadem se reciperet castra. Consecuntur equites nostri, ut erat praeceptum, invaduntque Dumnaci agmen et fugientes perterritosque sub sarcinis in itinere adgressi magna praeda multis interfectis potiuntur. Ita re bene gesta se recipiunt in castra.
[28] Insequenti nocte Fabius equites praemittit sic paratos ut confligerent atque omne agmen morarentur, dum consequeretur ipse. Cuius praeceptis ut res gereretur, Quintus Atius Varus, praefectus equitum, singularis et animi et prudentiae vir, suos hortatur agmenque hostium consecutus turmas partim idoneis locis disponit, parte equitum proelium committit. Confligit audacius equitatus hostium succedentibus sibi peditibus, qui toto agmine subsistentes equitibus suis contra nostros ferunt auxilium. Fit proelium acri certamine. Namque nostri contemptis pridie superatis hostibus, cum subsequi legiones meminissent, et pudore cedendi et cupiditate per se conficiendi proeli fortissime contra pedites proeliantur, hostesque nihil amplius copiarum accessurum credentes, ut pridie cognoverant, delendi equitatus nostri nacti occasionem videbantur.
[29] Cum aliquamdiu summa contentione dimicaretur, Dumnacus instruit aciem quae suis esset equitibus in vicem praesidio, cum repente confertae legiones in conspectum hostium veniunt. Quibus visis perculsae barbarorum turmae ac perterritae acies hostium, perturbato impedimentorum agmine, magno clamore discursuque passim fugae se mandant. At nostri equites, qui paulo ante cum resistentibus fortissime conflixerant, laetitia victoriae elati magno undique clamore sublato cedentibus circumfusi, quantum equorum vires ad persequendum dextraeque ad caedendum valent, tantum eo proelio interficiunt. Itaque amplius milibus XII aut armatorum aut eorum qui eo timore arma proiecerant interfectis omnis multitudo capitur impedimentorum.
[30] Qua ex fuga cum constaret Drappetem Senonem, qui, ut primum defecerat Gallia, collectis undique perditis hominibus, servis ad libertatem vocatis, exulibus omnium civitatum adscitis, receptis latronibus impedimenta et commeatus Romanorum interceperat, non amplius hominum duobus milibus ex fuga collectis provinciam petere unaque consilium cum eo Lucterium Cadurcum cepisse, quem superiore commentario prima defectione Galliae facere in provinciam voluisse impetum cognitum est, Caninius legatus cum legionibus duabus ad eos persequendos contendit, ne detrimento aut timore provinciae magna infamia perditorum hominum latrociniis caperetur.
[31] Gaius Fabius cum reliquo exercitu in Carnutes ceterasque proficiscitur civitates, quarum eo proelio, quod cum Dumnaco fecerat, copias esse accisas sciebat. Non enim dubitabat quin recenti calamitate summissiores essent futurae, dato vero spatio ac tempore eodem instigante Dumnaco possent concitari. Qua in re summa felicitas celeritasque in recipiendis civitatibus Fabium consequitur. Nam Carnutes, qui saepe vexati numquam pacis fecerant mentionem, datis obsidibus veniunt in deditionem, ceteraeque civitates positae in ultimis Galliae finibus Oceano coniunctae, quae Armoricae appellantur, auctoritate adductae Carnutum adventu Fabi legio numque imperata sine mora faciunt. Dumnacus suis finibus expulsus errans latitansque solus extremas Galliae regiones petere est coactus.
[32] At Drappes unaque Lucterius, cum legiones Caniniumque adesse cognoscerent nec se sine certa pernicie persequente exercitu putarent provinciae fines intrare posse nec iam libere vagandi latrociniorumque faciendorum facultatem haberent, in finibus consistunt Cadurcorum. Ibi cum Lucterius apud suos cives quondam integris rebus multum potuisset, semperque auctor novorum consiliorum magnam apud barbaros auctoritatem haberet, oppidum Uxellodunum, quod in clientela fuerat eius, egregie natura loci munitum, occupat suis et Drappetis copiis oppidanosque sibi coniungit.
[33] Quo cum confestim Gaius Caninius venisset animadverteretque omnes oppidi partes praeruptissimis saxis esse munitas, quo defendente nullo tamen armatis ascendere esset difficile, magna autem impedimenta oppidanorum videret, quae si clandestina fuga subtrahere conarentur, effugere non modo equitatum, sed ne legiones quidem possent, tripertito cohortibus divisis trina excelsissimo loco castra fecit; a quibus paulatim, quantum copiae patiebantur, vallum in oppidi circuitum ducere instituit.
[34] Quod cum animadverterent oppidani miserrimaque Alesiae memoria solliciti similem casum obsessionis vererentur, maximeque ex omnibus Lucterius, qui fortunae illius periculum fecerat, moneret frumenti rationem esse habendam, constituunt omnium consensu parte ibi relicta copiarum ipsi cum expeditis ad importandum frumentum proficisci. Eo consilio probato proxima nocte duobus milibus armatorum relictis reliquos ex oppido Drappes et Lucterius educunt. Hi paucos dies morati ex finibus Cadurcorum, qui partim re frumentaria sublevare eos cupiebant, partim prohibere quo minus sumerent non poterant, magnum numerum frumenti comparant, nonnumquam autem expeditionibus nocturnis castella nostrorum adoriuntur. Quam ob causam Gaius Caninius toto oppido munitiones circumdare moratur, ne aut opus effectum tueri non possit aut plurimis in locis infirma disponat praesidia.
[35] Magna copia frumenti comparata considunt Drappes et Lucterius non longius ab oppido X milibus, unde paulatim frumentum in oppidum supportarent. Ipsi inter se provincias partiuntur: Drappes castris praesidio cum parte copiarum restitit; Lucterius agmen iumentorum ad oppidum ducit. Dispositis ibi praesidiis hora noctis circiter decima silvestribus angustisque itineribus frumentum importare in oppidum instituit. Quorum strepitum vigiles castrorum cum sensissent, exploratoresque missi quae gererentur renuntiassent, Caninius celeriter cum cohortibus armatis ex proximis castellis in frumentarios sub ipsam lucem impetum fecit. Ei repentino malo perterriti diffugiunt ad sua praesidia; quae nostri ut viderunt, acrius contra armatos incitati neminem ex eo numero vivum capi patiuntur. Profugit inde cum paucis Lucterius nec se recipit in eastra.
[36] Re bene gesta Caninius ex captivis comperit partem copiarum cum Drappete esse in castris a milibus longe non amplius XII. Qua re ex compluribus cognita, cum intellegeret fugato duce altero perterritos reliquos facile opprimi posse, magnae felicitatis esse arbitrabatur neminem ex caede refugisse in castra qui de accepta calamitate nuntium Drappeti perferret. Sed in experiendo cum periculum nullum videret, equitatum omnem Germanosque pedites, summae velocitatis homines, ad castra hostium praemittit; ipse legionem unam in trina castra distribuit, alteram secum expeditam ducit. Cum propius hostes accessisset, ab exploratoribus quos praemiserat cognoscit castra eorum, ut barbarorum fere consuetudo est, relictis locis superioribus ad ripas fluminis esse demissa; at Germanos equitesque imprudentibus omnibus de improviso advolasse proeliumque commisisse. Qua re cognita legionem armatam instructamque adducit. Ita repente omnibus ex partibus signo dato loca superiora capiuntur. Quod ubi accidit, Germani equitesque signis legionis visis vehementissime proeliantur. Confestim cohortes undique impetum faciunt omnibusque aut interfectis aut captis magna praeda potiuntur. Capitur ipse eo proelio Drappes.
[37] Caninius felicissime re gesta sine ullo paene militis vulnere ad obsidendos oppidanos revertitur externoque hoste deleto, cuius timore antea dividere praesidia et munitione oppidanos circumdare prohibitus erat, opera undique imperat administrari. Venit eodem cum suis copiis postero die Gaius Fabius partemque oppidi sumit ad obsidendum.
[38] Caesar interim M. Antonium quaestorem cum cohortibus XV in Bellovacis relinquit, ne qua rursus novorum consiliorum capiendorum Belgis facultas daretur. Ipse reliquas civitates adit, obsides plures imperat, timentes omnium animos consolatione sanat. Cum in Carnutes venisset, quorum in civitate superiore commentario Caesar euit initium belli esse ortum, quod praecipue eos propter conscientiam facti timere animadvertebat, quo celerius civitatem timore liberaret, principem sceleris illius et concitatorem belli, Gutruatum, ad supplicium depoposcit. Qui etsi ne civibus quidem suis se committebat, tamen celeriter omnium cura quaesitus in castra perducitur. Cogitur in eius supplicium Caesar contra suam naturam concursu maximo militum, qui ei omnia pericula et detrimenta belli accepta referebant, adeo ut verberibus exanimatum corpus securi feriretur.
[39] Ibi crebris litteris Canini fit certior quae de Drappete et Lucterio gesta essent, quoque in consilio permanerent oppidani. Quorum etsi paucitatem contemnebat, tamen pertinaciam magna poena esse adficiendam iudicabat, ne universa Gallia non sibi vires defuisse ad resistendum Romanis, sed constantiam putaret, neve hoc exemplo ceterae civitates locorum opportunitate fretae se vindicarent in libertatem, cum omnibus Gallis notum esse sciret reliquam esse unam aestatem suae provinciae, quam si sustinere potuissent, nullum ultra periculum vererentur. Itaque Q. Calenum legatum cum legionibus reliquit qui iustis itineribus subsequeretur; ipse cum omni equitatu quam potest celerrime ad Caninium contendit.
[40] Cum contra exspectationem omnium Caesar Uxellodunum venisset oppidumque operibus clausum animadverteret neque ab oppugnatione recedi videret ulla condicione posse, magna autem copia frumenti abundare oppidanos ex perfugis cognosset, aqua prohibere hostem temptare coepit. Flumen infimam vallem dividebat, quae totum paene montem cingebat, in quo positum erat praeruptum undique oppidum Uxellodunum. Hoc avertere loci natura prohibebat: in infimis enim sic radicibus montis ferebatur, ut nullam in partem depressis fossis derivari posset. Erat autem oppidanis difficilis et praeruptus eo descensus, ut prohibentibus nostris sine vulneribus ac periculo vitae neque adire flumen neque arduo se recipere possent ascensu. Qua difficultate eorum cogmta Caesar sagittariis funditoribusque dispositis, tormentis etiam quibusdam locis contra facillimos descensus collocatis aqua fluminis prohibebat oppidanos.
[41] Quorum omnis postea multitudo aquatorum unum in locum conveniebat sub ipsius oppidi murum, ubi magnus fons aquae prorumpebat ab ea parte, quae fere pedum CCC intervallo fluminis circuitu vacabat. Hoc fonte prohiberi posse oppidanos cum optarent reliqui, Caesar unus videret, e regione eius vineas agere adversus montem et aggerem instruere coepit magno cum labore et continua dimicatione. Oppidani enim loco superiore decurrunt et eminus sine periculo proeliantur multosque pertinaciter succedentes vulnerant; non deterrentur tamen milites nostri vineas proferre et labore atque operibus locorum vincere difficultates. Eodem tempore cuniculos tectos ab vineis agunt ad caput fontis; quod genus operis sine ullo periculo, sine suspicione hostium facere licebat. Exstruitur agger in altitudinem pedum sexaginta, collocatur in eo turris decem tabulatorum, non quidem quae moenibus aequaret (id enim nullis operibus effici poterat), sed quae superare fontis fastigium posset. Ex ea cum tela tormentis iacerentur ad fontis aditum, nec sine periculo possent aquari oppidani, non tantum pecora atque iumenta, sed etiam magna hostium multitudo siti consumebatur.
[42] Quo malo perterriti oppidani cupas sebo, pice, scandulis complent; eas ardentes in opera provolvunt eodemque tempore acerrime proeliantur, ut ab incendio restinguendo dimicationis periculo deterreant Romanos. Magna repente in ipsis operibus flamma exstitit. Quaecumque enim per locum praecipitem missa erant, ea vineis et aggere suppressa comprehendebant id ipsum quod morabatur. Milites contra nostri, quamquam periculoso genere proeli locoque iniquo premebantur, tamen omnia fortissimo sustinebant animo. Res enim gerebatur et excelso loco et in conspectu exercitus nostri, magnusque utrimque clamor oriebatur. Ita quam quisque poterat maxime insignis, quo notior testatiorque virtus esset eius, telis hostium flammaeque se offerebat.
[43] Caesar cum complures suos vulnerari videret, ex omnibus oppidi partibus cohortes montem ascendere et simulatione moenium occupandorum clamorem undique iubet tollere. Quo facto perterriti oppidani, cum quid ageretur in locis reliquis essent suspensi, revocant ab impugnandis operibus armatos murisque disponunt. Ita nostri fine proeli facto celeriter opera flamma comprehensa partim restinguunt, partim interscindunt. Cum pertinaciter resisterent oppidani, magna etiam parte amissa siti suorum in sententia permanerent, ad postremum cuniculis venae fontis intercisae sunt atque aversac. Quo facto repente perennis exaruit fons tantamque attulit oppidanis salutis desperationem, ut id non hominum consilio, sed deorum voluntate factum putarent. Itaque se necessitate coacti tradiderunt.
[44] Caesar, cum suam lenitatem cognnitam omnibus sciret neque vereretur ne quid crudelitate naturae videretur asperius fecisse, neque exitum consiliorum suorum animadverteret, si tali ratione diversis in locis plures consilia inissent, exemplo supplici deterrendos reliquos existimavit. Itaque omnibus qui arma tulerant manus praecidit vitamque concessit, quo testatior esset poena improborum. Drappes, quem captum esse a Caninio docui, sive indignitate et dolore vinculorum sive timore gravioris supplici paucis diebus cibo se abstinuit atque ita interiit. Eodem tempore Lacterius, quem profugisse ex proelio scripsi, cum in potestatem venisset Epasnacti Arverni (crebro enim mutandis locis multorum fidei se committebat, quod nusquam diutius sine periculo commoraturus videbatur, cum sibi conscius esset, quam inimicum deberet Caesarem habere), hunc Epasnactus Arvernus, amicissimus populi Romani, sine dubitatione ulla vinctum ad Caesarem deduxit.
[45] Labienus interim in Treveris equestre proelium facit secundum compluribusque Treveris interfectis et Germanis, qui nullis adversus Romanos auxilia denegabant, principes eorum vivos redigit in suam potestatem atque in his Surum Aedmlm, qui et virtutis et generis summam nobilitatem habebat solusque ex Aeduis ad id tempus permanserat in armis.
[46] Ea re cognita Caesar, cum in omnibus partibus Galliae bene res geri videret iudicaretque superioribus aestivis Galliam devictam subactamque esse, Aquitaniam numquam adisset, per Publium Crassum quadam ex parte devicisset, cum duabus legionibus in eam partem Galliae est profectus, ut ibi extremum tempus consumeret aestivorum. Quam rem sicuti cetera celeriter feliciterque confecit. Namque omnes Aquitaniae civitates legatos ad Caesarem miserunt obsidesque ei dederunt. Quibus rebus gestis ipse equitum praesidio Narbonem profecto est, exercitum per legatos in hiberna deduxit: quattuor legiones in Belgio collocavit cum M. Antonio et C. Trebonio et P. Vatinio legatis, duas legiones in Aeduos deduxit, quorum in omni Gallia summam esse auctoritatem sciebat, duas in Turonis ad fines Carnutum posuit, quae omnem illam regionem coniunctam Oceano continerent, duas reliquas in Lemovicum finibus non longe ab Arvernis, ne qua pars Galliae vacua ab exercitu esset. Paucos dies ipse in provincia moratus, cum celeriter omnes conventus percucurrisset, publicas controversias cognosset, bene meritis praemia tribuisset (cognoscendi enim maximam facultatem habebat, quali quisque fuisset animo in totius Galliae defectione, quam sustinuerat fidelitate atque auxiliis provinciae illius), his confectis rebus ad legiones in Belgium se recipit hibernatque Nemetocennae.
[47] Ibi cognoscit Commium Atrebatem proelio cum equitatu suo contendisse. Nam cum Antonius in hiberna venisset, civitasque Atrebatum in officio esset, Commius, qui post illam vulnerationem, quam supra commemoravi, semper ad omnes motus paratus suis civibus esse consuesset, ne consilia belli quaerentibus auctor armorum duxque deesset, parente Romanis civitate cum suis equitibus latrociniis se suos que alebat infestisque itineribus commeatus complures, qui comportabantur in hiberna Romanorum, intercipiebat.
[48] Erat attributus Antonio praefectus equitum C. Volusenus Quadratus qui cum eo hibernaret. Hunc Antonius ad persequendum equitatum hostium mittit. Volusenus ad eam virtutem, quae singularis erat in eo, magnum odium Commi adiungebat, quo libentius id faceret quod imperabatur. Itaque dispositis insidiis saepius equites eius adgressus secunda proelia faciebat. Novissime, cum vehementius contenderetur, ac Volusenus ipsius intercipiendi Commi cupiditate pertinacius eum cum paucis insecutus esset, ille autem fuga vehementi Volusenum produxisset longius, inimicus homini suorum invocat fidem atque auxilium, ne sua vulnera per fidem imposita paterentur impunita, conversoque equo se a ceteris incautius permittit in praefectum. Faciunt hoc idem omnes eius equites paucosque nostros convertunt atque insequuntur. Commius incensum calcaribus equum coniungit equo Quadrati lanceaque infesta magnis viribus medium femur traicit Voluseni. Praefecto vulnerato non dubitant nostri resistere et conversis equis hostem pellere. Quod ubi accidit, complures hostium magno nostrorum impetu perculsi vulnerantur ac partim in fuga proteruntur, partim intercipiuntur; quod malum dux equi velocitate evitavit: graviter adeo vulneratus praefectus, ut vitae periculum aditurus videretur, refertur in castra. Commius autem sive expiato suo dolore sive magna parte amissa suorum legatos ad Antonium mittit seque et ibi futurum, ubi praescripserit, et ea facturum, quae imperarit, obsidibus firmat; unum illud orat, ut timori suo concedatur, ne in conspectum veniat cuiusquam Romani. Cuius postulationem Antonius cum iudicaret ab iusto nasci timore, veniam petenti dedit, obsides accepit.
Scio Caesarem singulorum annorum singulos commentarios confecisse; quod ego non existimavi mihi esse faciendum, propterea quod insequens annus, L. Paulo C. Marcello consulibus, nullas habet magnopere Galliae res gestas. Ne quis tamen ignoraret, quibus in locis Caesar exercitusque eo tempore fuissent, pauca esse scribenda coniungendaque huic commentario statui.
[49] Caesar in Belgio cum hiemaret, unum illud propositum habebat, continere in amicitia civitates, nulli spem aut causam dare armorum. Nihil enim minus volebat quam sub decessu suo necessitatem sibi aliquam imponi belli gerendi, ne, cum exercitum deducturus esset, bellum aliquod relinqueretur quod omnis Gallia libenter sine praesenti periculo susciperet. Itaque honorifice civitates appellando, principes maximis praemiis adficiendo, nulla onera iniungendo defessam tot adversis proeliis Galliam condicione parendi meliore facile in pace continuit.
[50] Ipse hibernis peractis contra consuetudinem in Italiam quam maximis itineribus est profectus, ut municipia et colonias appellaret, quibus M. Antoni quaestoris sui, commendaverat sacerdoti petitionem. Contendebat enim gratia cum libenter pro homine sibi coniunctissimo, quem paulo ante praemiserat ad petitionem, tum acriter contra factionem et potentiam paucorum, qui M. Antoni repulsa Caesaris decedentis gratiam convellere cupiebant. Hunc etsi augurem prius faetum quam Italiam attingeret in itinere audierat, tamen non minus iustam sibi causam municipia et colonias adeundi existimavit, ut eis gratias ageret, quod frequentiam atque officium suum Antonio praestitissent, simulque se et honorem suum sequentis anni commendaret, propterea quod insolenter adversarii sui gloriarentur L. Lentulum et C. Marcellum consules creatos qui omnem honorem et dignitatem Caesaris spoliarent, ereptum Ser. Galbae consulatum, cum is multo plus gratia suffragiisque valuisset, quod sibi coniunctus et familiaritate et consuetudine legationis esset.
[51] Exceptus est Caesaris adventus ab omnibus municipiis et coloniis incredibili honore atque amore. Tum primum enim veniebat ab illo universae Galliae bello. Nihil relinquebatur quod ad ornatum portarum, itinerum, locorum omnium qua Caesar iturus erat excogitari poterat. Cum liberis omnis multitudo obviam procedebat, hostiae omnibus locis immolabantur, tricliniis stratis fora templaque occupabantur, ut vel exspectatissimi triumphi laetitia praecipi posset. Tanta erat magnificentia apud opulentiores, cupiditas apud humiliores.
[52] Cum omnes regiones Galliae togatae Caesar percucurrisset, summa celeritate ad exercitum Nemetocennam rediit legionibusque ex omnibus hibernis ad fines Treverorum evocatis eo profectus est ibique exercitum lustravit. T. Labienum Galliae togatae praefecit, quo maiore commendatione conciliaretur ad consulatus petitionem. Ipse tantum itinerum faciebat, quantum satis esse ad mutationem locorum propter salubritatem existimabat. Ibi quamquam crebro audiebat Labienum ab inimicis suis sollicitari certiorque fiebat id agi paucorum consiliis, ut interposita senatus auctoritate aliqua parte exercitus spoliaretur, tamen neque de Labieno credidit quidquam neque contra senatus auctoritatem ut aliquid faceret potuit adduci. Iudicabat enim liberis sententiis patrum conscriptorum causam suam facile obtineri. Nam C. Curio, tribunus plebis, cum Caesaris causam dignitatemque defendendam suscepisset, saepe erat senatui pollicitus, si quem timor armorum Caesaris laederet, et quoniam Pompei dominatio atque arma non minimum terrorem foro inferrent, discederet uterque ab armis exercitusque dimitteret: fore eo facto liberam et sui iuris civitatem. Neque hoc tantum pollicitus est, sed etiam sc. per discessionem facere coepit; quod ne fieret consules amicique Pompei iusserunt atque ita rem morando discusserunt.
[53] Magnum hoc testimonium senatus erat universi conveniensque superiori facto. Nam Marcellus proximo anno, cum impugnaret Caesaris dignitatem, contra legem Pompei et Crassi rettulerat ante tempus ad senatum de Caesaris provinciis, sententiisque dictis discessionem faciente Marcello, qui sibi omnem dignitatem ex Caesaris invidia quaerebat, senatus frequens in alia omnia transiit. Quibus non frangebantur animi inimicorum Caesaris, sed admonebantur quo maiores pararent necessitates, quibus cogi posset senatus id probare, quod ipsi constituissent.
[54] Fit deinde senatus consultum, ut ad bellum Parthi cum legio una a Cn. Pompeio, altera a C. Caesare mitteretur; neque obscure duae legiones uni detrahuntur. Nam Cn. Pompeius legionem primam, quam ad Caesarem miserat, confectam ex delectu provinciae Caesaris, eam tamquam ex suo numero dedit. Caesar tamen, cum de voluntate minime dubium esset adversariorum suorum, Pompeio legionem remisit et suo nomine quintam decimam, quam in Gallia citeriore habuerat, ex senatus consulto iubet tradi. In eius locum tertiam decimam legionem in Italiam mittit quae praesidia tueretur, ex quibus praesidiis quinta decima deducebatur. Ipse exercitui distribuit hiberna: C. Trebonium cum legionibus quattuor in Belgio collocat, C. Fabium cum totidem in Aeduos deducit. Sic enim existimabat tutissimam fore Galliam, si Belgae, quorum maxima virtus, Aedui, quorum auctoritas summa esset, exercitibus continerentur. Ipse in Italiam profectus est.
[55] Quo cum venisset, cognoscit per C. Marcellum consulem legiones duas ab se remissas, quae ex senatus consulto deberent ad Parthicum bellum duci, Cn. Pompeio traditas atque in Italia retentas esse. Hoc facto quamquam nulli erat dubium, quidnam contra Caesarem pararetur, tamen Caesar omnia patienda esse statuit, quoad sibi spes aliqua relinqueretur iure potius disceptandi quam belli gerendi. Contendit . . .
|
LIBRO OTTAVO
Costretto dalle tue assidue esortazioni, Balbo, visto che il mio
quotidiano rifiuto non sembrava ammettere la scusa della difficoltà, ma
incontrava il biasimo dell'inerzia, ho assunto un compito davvero
difficile: i commentari del nostro Cesare sulle sue imprese in Gallia, li
ho integrati con le vicende che non comparivano e li ho collegati ai suoi
scritti successivi; inoltre, l'ultima opera, da lui lasciata incompiuta,
l'ho terminata a partire dalle imprese alessandrine per arrivare non dico
al termine della guerra civile, di cui non vediamo ancora la fine, ma alla
morte di Cesare. Vorrei che i lettori sapessero quanto malvolentieri mi
sia assunto il compito di scriverli, per essere con più facilità assolto
dall'accusa di stoltezza e arroganza, io che ho inserito tra gli scritti
di Cesare i miei. Tutti lo sanno: non c'è opera di altri autori che sia
stata composta con altrettanta cura e che non sia superata dall'eleganza
di questi commentari. Furono pubblicati perché agli storici non mancasse
il materiale su imprese così grandi; ma tutti ne riconobbero il valore, al
punto che sembrava preclusa, e non offerta, la possibilità di narrarle. In
tal senso, comunque, la nostra ammirazione supera quella degli altri:
perché tutti ne vedono la bellezza e la perfezione. ma noi sappiamo anche
con quale facilità e rapidità li abbia composti. Cesare, infatti, aveva
sia una straordinaria disposizione ed eleganza nello scrivere, sia
un'autentica capacità di illustrare i suoi disegni. Io non ho partecipato
direttamente alla guerra alessandrina e africana; sebbene in parte esse mi
siano note per bocca di Cesare, tuttavia un conto è udire i fatti che ci
colpiscono per la loro singolarità o che ci riempiono d'ammirazione, un
altro è esporre gli avvenimenti per testimonianza diretta. Ma proprio
mentre cerco ogni motivo di scusa per non essere accostato a Cesare, mi
espongo all'accusa di arroganza, per aver pensato che qualcuno possa
paragonarmi a lui. Stammi bene.
[1
Piegata tutta la Gallia, Cesare, che dall'estate precedente non aveva mai
cessato di combattere, voleva concedere un po' di riposo ai soldati negli
accampamenti invernali, dopo tante fatiche. Giungeva, però, notizia che
diversi popoli contemporaneamente rinnovavano i piani di guerra e
stringevano alleanze. Motivo di tali iniziative, verosimilmente, era che
tutti i Galli ben sapevano che nessun esercito concentrato in un solo
luogo poteva resistere ai Romani e che, se parecchie genti, nello stesso
istante, li avessero attaccati su diversi fronti, l'esercito del popolo
romano non avrebbe avuto appoggi, tempo, truppe sufficienti per
fronteggiare tutti. E nessun popolo doveva sottrarsi al destino d'un
rovescio, se, impegnando i Romani, avesse permesso agli altri di
riacquistare la libertà.
[2
Per evitare che le aspettative dei Galli trovassero conferme, Cesare
affida al questore M. Antonio il comando dei suoi quartieri d'inverno; la
vigilia delle calende di gennaio, con una scorta di cavalieri parte da
Bibracte verso la tredicesima legione, da lui stanziata nei territori dei
Biturigi, non lontano dagli Edui. Alla tredicesima unisce l'undicesima
legione, la più vicina. Lasciate due coorti a guardia delle salmerie,
guida il resto dell'esercito nelle fertilissime campagne dei Biturigi.
Quest'ultimi avevano vasti territori e molte città, per cui la presenza di
una sola legione nei campi invernali non era valsa a impedire i
preparativi di guerra e i patti di alleanza.
[3
Al repentino arrivo di Cesare accadde l'inevitabile per gente colta alla
sprovvista e sparpagliata: mentre i nemici, senza timore alcuno,
attendevano ai lavori nei campi, vennero sopraffatti dalla cavalleria
prima di potersi rifugiare nelle città. Infatti, per ordine di Cesare, era
stato eliminato anche l'indizio più comune di un'incursione nemica, ovvero
il fuoco appiccato agli edifici, sia perché in caso di ulteriore avanzata
non venissero a mancare foraggio e grano, sia perché i nemici non fossero
messi in allarme dagli incendi stessi. Dopo la cattura di molte migliaia
di uomini, chi tra i Biturigi, in preda alla paura, era riuscito a
sfuggire al primo attacco dei Romani, era riparato presso i popoli vicini,
fidando o in vincoli personali d'ospitalità oppure nell'alleanza comune.
Invano: a marce forzate Cesare accorre dappertutto e non lascia a nessun
popolo il tempo di pensare alla salvezza altrui più che alla propria. Con
la rapidità della sua azione teneva a freno gli alleati fedeli, con il
terrore costringeva alla pace i titubanti. Di fronte a tale situazione, i
Biturigi, vedendo che la clemenza di Cesare lasciava spazio per un ritorno
all'alleanza con lui e che i popoli limitrofi non avevano subito pena
alcuna, ma dietro la consegna di ostaggi erano stati accolti sotto la sua
protezione, ne seguirono l'esempio.
[4
Ai soldati, che avevano senza sosta condotto le operazioni con
straordinario impegno anche nelle giornate invernali, lungo strade davvero
disagevoli e con un freddo insopportabile, come premio a titolo di bottino
Cesare promette, per le tante fatiche e sopportazioni, duecento sesterzi a
testa, e ai centurioni mille. Invia le legioni ai quartieri d'inverno e
ritorna a Bibracte dopo quaranta giorni. Mentre vi amministrava la
giustizia, i Biturigi gli inviano emissari per chiedergli aiuto contro i
Carnuti, lamentando attacchi da parte loro. Appena ne è informato, dopo
aver sostato nei campi invernali non più di diciotto giorni, richiama la
diciottesima e la sesta legione dagli accampamenti sulla Saona, dove erano
state dislocate per occuparsi del vettovagliamento, come si è detto nel
libro precedente. Così, con due legioni parte all'inseguimento dei
Carnuti.
[5
Quando la notizia di truppe in movimento giunse ai nemici, i Carnuti,
edotti dalle sciagure altrui, abbandonano i villaggi e le città in cui
abitavano dopo aver frettolosamente allestito piccole costruzioni per
ripararsi dall'inverno (infatti, in seguito alla recente sconfitta avevano
perduto parecchie città) e fuggono sbandati. Cesare non voleva che i
soldati affrontassero i rigori della stagione, tremendi proprio in quel
periodo: pone il campo in una città dei Carnuti, Cenabo, ammassa parte dei
soldati nelle case dei Galli, parte in ripari approntati gettando alla
svelta paglia sulle tende. Comunque, manda i cavalieri e i fanti ausiliari
in tutte le direzioni in cui si diceva che si fossero mossi i nemici. E
non invano: i nostri, infatti, rientrano per lo più con un ricco bottino.
I Carnuti si trovarono stretti dalle difficoltà dell'inverno e atterriti
dal pericolo; cacciati dalle loro case, non osavano fermarsi stabilmente
in nessun luogo, né potevano sfruttare il riparo delle selve per
l'inclemenza della stagione. Divisi, perdono gran parte dei loro e si
sparpagliano presso le popolazioni vicine.
[6
Cesare, in una stagione davvero ostile, al fine di prevenire l'inizio di
una guerra riteneva di aver fatto a sufficienza per disperdere le forze
nemiche che si stavano concentrando ed era convinto, per quanto si poteva
ragionevolmente supporre, che nessun grave conflitto potesse scoppiare
fino all'estate. Allora, alloggiò a Cenabo, nei quartieri d'inverno, C.
Trebonio alla testa delle due legioni che aveva con sé. I Remi, con
frequenti ambascerie, lo informavano che i Bellovaci, superiori a tutti i
Galli e ai Belgi quanto a gloria militare, e i popoli limitrofi, sotto la
guida del bellovaco Correo e dell'atrebate Commio, allestivano truppe e le
radunavano in un solo luogo, per attaccare in massa le terre dei
Suessioni, vassalli dei Remi. Che alleati benemeriti verso la nostra
repubblica non patissero alcun torto, Cesare la ritenne questione
riguardante non solo la sua dignità, ma anche la sua sicurezza. Perciò,
richiama nuovamente dal campo invernale l'undicesima legione, poi invia
una lettera a C. Fabio, perché guidi nei territori dei Suessioni le due
legioni che aveva ai suoi ordini; a Labieno richiede una delle due legioni
di cui disponeva. Così, conciliando le necessità dei campi invernali e le
esigenze del conflitto, alle legioni imponeva a turno l'onere delle
spedizioni, ma non concedeva mai riposo a se stesso.
[7
Riunite queste truppe, punta sui Bellovaci, stabilisce il campo nei loro
territori e manda dappertutto squadroni di cavalleria per catturare
prigionieri, che lo avrebbero messo al corrente dei piani nemici. I
cavalieri, eseguito l'ordine, riferiscono di aver trovato solo pochi
nemici in case isolate, ma non si trattava di gente rimasta a coltivare i
campi (tutte le zone, infatti, erano state scrupolosamente evacuate),
bensì di osservatori rispediti a sorvegliare le nostre mosse. Avendo
chiesto ai prigionieri dove si trovava il grosso dei Bellovaci e quali ne
fossero i disegni, Cesare ricevette le seguenti indicazioni: tutti i
Bellovaci in grado di portare armi si erano radunati in un solo luogo,
come pure gli Ambiani, gli Aulerci, i Caleti, i Veliocassi, gli Atrebati;
avevano scelto per l'accampamento una località in alto, in una selva
circondata da una palude e avevano ammassato tutti i bagagli nei boschi
alle spalle. Parecchi erano i capi, fautori della guerra, ma la massa
obbediva in particolare a Correo, in quanto era noto il suo odio mortale
per il nome del popolo romano. Pochi giorni prima, l'atrebate Commio si
era allontanato dal campo in cerca di rinforzi presso i Germani, che erano
vicini e di numero sterminato. Poi, i Bellovaci, col consenso di tutti i
capi, tra l'entusiasmo generale, avevano deciso di esporsi a un
combattimento, se davvero Cesare fosse giunto con tre legioni, come si
diceva; in tal modo, non sarebbero stati costretti, in seguito, a lottare
contro tutto l'esercito in condizioni più difficili e ardue; se, invece,
Cesare avesse condotto truppe più numerose, si sarebbero attestati nella
posizione che avevano scelto e avrebbero impedito ai Romani, mediante
imboscate, la raccolta di foraggio (che non solo scarseggiava, ma era
anche disperso qua e là per via della stagione), nonché di grano e di
altri viveri.
[8
Quando da diverse e concordi fonti conobbe il piano nemico e giudicò molto
accorti i propositi che gli venivano illustrati e ben lontani dalla solita
avventatezza dei barbari, decise di sfruttare ogni mezzo per indurre gli
avversari a scendere in campo al più presto, per disprezzo dell'esiguità
dei suoi effettivi. Aveva con sé, infatti, le legioni più anziane, la
settima, l'ottava, la nona, straordinarie per valore, nonché una legione
di belle speranze, composta da giovani scelti, l'undicesima, che già da
otto anni riceveva la paga, ma, in confronto alle altre, non si era ancora
guadagnata la stessa fama di provato valore. Così, convocato il consiglio
di guerra, espone tutte le notizie che gli erano state riferite e rafforza
il coraggio delle truppe. Per attirare i nemici a battaglia, illudendoli
di avere di fronte tre legioni, fissa l'ordine di marcia come segue: la
settima, l'ottava e la nona legione dovevano procedere in testa, seguite
dalla colonna delle salmerie, poco numerose ovviamente, come succede di
solito nelle spedizioni; l'undicesima doveva costituire la coda, per non
mostrare ai nemici una consistenza numerica superiore a quanto essi
sperassero. Con tale schieramento, formando in pratica il quadrato, arriva
con i suoi in vista dei nemici più presto di quanto essi pensassero.
[9
Non appena vedono all'improvviso le nostre legioni, schierate a battaglia,
avanzare con passo deciso, i Galli, benché i loro propositi, secondo le
informazioni avute da Cesare, fossero molto baldanzosi, schierano le
truppe dinnanzi al campo e non scendono dalle alture, forse per evitare i
rischi dello scontro o per la sorpresa del nostro arrivo repentino oppure
in attesa delle nostre mosse. Cesare, anche se prima desiderava il
combattimento, colpito adesso dalla massa degli avversari, da cui ci
separava una valle più profonda che larga, piazza il campo davanti a
quello nemico. Ordina di fortificarlo con un vallo di dodici piedi e di
aggiungervi un piccolo parapetto di altezza proporzionata; fa scavare una
coppia di fosse di quindici piedi a pareti verticali, erigere parecchie
torri a tre piani, raccordate mediante ponti, coperti e protetti verso
l'esterno da un parapetto di graticcio. Così, la difesa era assicurata da
una coppia di fosse e da un duplice ordine di combattenti: il primo
ordine, dai ponti, più sicuro per via dell'altezza, poteva scagliare le
frecce con maggior audacia e più lontano; l'altro, situato più vicino al
nemico, proprio sul vallo, grazie ai ponti stessi era protetto dalla
pioggia di dardi. Dota di battenti le porte e le affianca con torri più
alte.
[10
Lo scopo di tale fortificazione era duplice. Sperava, appunto, che la mole
dei lavori e la sua simulata paura infondessero fiducia ai barbari;
inoltre, vedeva che, grazie appunto alle opere di fortificazione, era
possibile difendere il campo anche con pochi uomini, quando occorreva
allontanarsi troppo in cerca di foraggio e di grano. Frattanto, piccoli
gruppi dei due eserciti davano luogo a frequenti scaramucce tra gli
accampamenti, che pure erano separati da una palude. Talvolta, comunque, o
le nostre truppe ausiliarie, Galli e Germani, attraversavano la palude e
incalzavano con maggior vigore i nemici, o erano i barbari, a loro volta,
a superarla e a ricacciare i nostri, costringendoli al ripiegamento. Poi,
durante le quotidiane spedizioni in cerca di foraggio, accadeva
l'inevitabile, dato che la ricerca avveniva per casolari sparsi e isolati:
i nostri soldati, disuniti, venivano circondati in zone difficilmente
praticabili. Il che ci procurava solo la perdita di pochi animali e servi,
ma alimentava gli stolti pensieri dei barbari, tanto più che Commio,
partito per chiedere aiuti ai Germani, come ho già detto, era rientrato
con un contingente di cavalieri. Non erano più di cinquecento, tuttavia
l'arrivo dei Germani esaltò i barbari.
[11
Cesare, constatato che ormai da parecchi giorni il nemico si teneva
nell'accampamento, difeso dalla palude e dalla conformazione naturale
della zona, si era anche reso conto che non poteva né espugnare il loro
campo senza un combattimento rovinoso, né circondarlo con opere d'assedio,
a meno dell'impiego di truppe più ingenti. Allora invia una lettera a
Trebonio, ordinandogli di richiamare quanto prima la tredicesima legione
(che svernava nelle terre dei Biturigi con il legato T. Sestio) e di
raggiungerlo con le tre legioni a marce forzate. Intanto, ai cavalieri dei
Remi, dei Lingoni e degli altri popoli, che aveva richiesto in gran
numero, dà l'incombenza di scortare a turno i nostri in cerca di foraggio,
per proteggerli da improvvisi attacchi dei nemici.
[12
La cosa accadeva ogni giorno, e ormai le precauzioni diminuivano per via
dell'abitudine, come spesso accade quando si ripetono le stesse azioni. I
Bellovaci, una volta conosciuti i punti dove stazionavano quotidianamente
i nostri cavalieri, con un gruppo scelto di fanti preparano un agguato in
una zona ricca di vegetazione. Lì inviano, il giorno seguente, dei
cavalieri, che dovevano attirare i nostri nel bosco, dove poi i fanti
appostati li avrebbero circondati e assaliti. La mala sorte capitò ai
Remi, a cui quel giorno era toccato il servizio di scorta. Quando
all'improvviso videro i cavalieri nemici, i nostri, sentendosi superiori
per numero, disprezzarono le forze avversarie: li inseguirono con troppa
foga e vennero circondati dai fanti. Scossi dall'accaduto, si ritirarono
più rapidamente di quanto non comporti, di regola, un combattimento di
cavalleria; ma persero il principe del loro popolo e comandante della
cavalleria, Vertisco, persona ormai anziana, a stento in grado di
cavalcare, che però, com'è costume dei Galli, non aveva accampato la scusa
dell'età al momento di rivestire il comando, né aveva voluto che si
lottasse senza di lui. Il successo nello scontro esalta e accende lo
spirito dei nemici, vista anche l'uccisione del principe e comandante dei
Remi, mentre la sconfitta insegna ai nostri a disporre i posti di guardia
dopo aver esplorato con più attenzione i luoghi e a inseguire con maggior
criterio il nemico in fuga.
[13
Frattanto, non conoscono pausa le scaramucce quotidiane al cospetto dei
due accampamenti, nei pressi dei guadi e dei passaggi della palude. In una
di esse i Germani, che Cesare aveva portato al di qua del Reno perché
combattessero frammischiati ai cavalieri, varcarono tutti la palude con
molta decisione, uccisero i pochi che tentavano la resistenza e
inseguirono piuttosto caparbiamente gli altri, seminando il panico non
solo in chi era pressato da vicino o veniva colpito da distante, ma anche
tra i rincalzi, che stazionavano più lontano, come al solito. Fu una rotta
vergognosa: scalzati, via via, dalle posizioni dominanti, non si fermarono
finché non trovarono riparo nel loro accampamento; altri, in preda alla
vergogna, proseguirono la fuga anche oltre il campo. Il pericolo corso
sconvolse l'intero corpo nemico, al punto che si rende difficile stabilire
se i Galli siano più inclini alla boria per insignificanti vittorie oppure
pavidi di fronte a mediocri avversità.
[14
Dopo aver trascorso parecchi giorni sempre nell'accampamento, i capi dei
Bellovaci, quando vennero a sapere che il legato C. Trebonio si stava
avvicinando con le legioni, nel timore di un assedio come ad Alesia, fanno
allontanare di notte le persone inutili troppo anziane o deboli o prive di
armi; con loro mandano tutti i bagagli. Mentre dispiegavano la colonna,
ancora in scompiglio e in disordine (un gran numero di carri, infatti,
segue di solito i Galli anche negli spostamenti brevi), vengono sorpresi
dal sorgere del sole. Allora schierano le truppe dinnanzi al loro campo,
per impedire ai Romani l'inizio dell'inseguimento prima che la colonna dei
bagagli si fosse allontanata abbastanza. Cesare, visto il pendio così
erto, non giudicò opportuno attaccare i nemici pronti alla difesa e decise
invece di far avanzare le legioni di quel tanto, che impedisse ai barbari
di muoversi dalla loro posizione senza rischi, data la minaccia dei
nostri. Poi notò che i due accampamenti erano sì divisi da una palude
impraticabile - un ostacolo in grado di frenare la rapidità
dell'inseguimento - ma che una catena di colli, al di là della palude,
raggiungeva quasi il campo nemico e ne era separata solo da una piccola
valle. Allora, getta ponti sulla palude, la varca con le legioni e giunge
rapidamente su una spianata in cima ai colli, protetta su entrambi i lati
da scoscesi pendii. Qui ricompone le legioni e raggiunge l'estremità della
spianata, dove forma la linea di battaglia. Da qui, i dardi scagliati
dalle macchine da lancio potevano piovere sui nemici disposti a cuneo.
[15
I barbari, forti della posizione, non avrebbero rifiutato lo scontro, se i
Romani avessero tentato un attacco al colle; ma non potevano inviare
soldati in piccoli gruppi, per evitare che si scoraggiassero, una volta
sparpagliati; perciò mantennero la stessa formazione. Cesare, di fronte
alla loro pervicacia, lascia pronto un distaccamento di venti coorti e,
tracciato il campo, ordina di fortificarlo. Terminati i lavori, schiera le
legioni, le dispone, in pieno assetto, dinnanzi al vallo e piazza di
guardia i cavalieri con i loro cavalli tenuti a briglia. I Bellovaci,
vedendo i Romani pronti all'inseguimento e non potendo né pernottare, né
rimanere più a lungo in quel luogo senza correre pericoli, decidono la
ritirata con il seguente stratagemma: le fascine di paglia e frasche su
cui sedevano (infatti, i Galli sono soliti sedere su fascine, come ricorda
Cesare nei precedenti commentari) e che abbondavano nel loro accampamento,
se le passarono di mano in mano e le posero dinnanzi alla loro linea.
Quando il giorno volgeva al termine, contemporaneamente, a un segnale
stabilito, le incendiano. Così, un muro di fiamme, all'improvviso, coprì
ai Romani la vista di tutte le truppe nemiche. E subito i barbari
ripiegarono con grandissima rapidità.
[16
Cesare, anche se non aveva potuto vedere la ritirata dei nemici per le
fiamme che gli si paravano dinnanzi, sospettava comunque che lo
stratagemma servisse a una fuga. Perciò, fa avanzare le legioni e lancia
all'inseguimento gli squadroni di cavalleria. Temendo, però, un'imboscata,
nel caso che i nemici fossero rimasti nella loro posizione e cercassero
solo di attirare i nostri in una zona svantaggiosa, procede con una certa
lentezza. I cavalieri non osavano spingersi nella densissima cortina di
fumo e di fiamme; se qualcuno vi era entrato per l'eccessivo slancio,
vedeva a stento la testa del proprio cavallo; temendo, dunque, un agguato,
lasciarono che i Bellovaci si ritirassero senza difficoltà. Così, dopo una
fuga dettata dal timore, ma al contempo piena di astuzia, senza aver
subito alcuna perdita, i nemici procedettero per non più di dieci miglia e
si attestarono in una zona ben munita. Da lì, appostandosi di continuo con
i cavalieri e i fanti, infliggevano gravi perdite ai Romani in cerca di
foraggio.
[17
Mentre gli agguati si facevano sempre più frequenti, da un prigioniero
Cesare venne a sapere che Correo, il capo dei Bellovaci, aveva scelto
seimila fanti tra i più forti e mille cavalieri tra il numero totale, per
tendere una trappola nella zona in cui presumeva che si sarebbero spinti i
Romani, vista l'abbondanza di grano e foraggio. Avvertito del piano,
Cesare guida fuori dal campo più legioni del solito e manda in avanti la
cavalleria, che, come di consueto, scortava i soldati in cerca di
foraggio. Inserisce tra i cavalieri gruppi di ausiliari armati alla
leggera. Dal canto suo, si avvicina il più possibile con le legioni.
[18
I nemici, in agguato, dopo aver scelto una pianura non più ampia di un
miglio in tutte le direzioni, circondata su ogni lato da selve o da un
fiume inguadabile, si erano disposti tutt'attorno, per accalappiare la
preda. I nostri, al corrente delle intenzioni nemiche, erano pronti alla
lotta sia con le armi, sia nell'animo, e visto l'arrivo imminente delle
legioni, non avrebbero rinunciato a nessun tipo di scontro: sul luogo
dell'imboscata giunsero squadrone per squadrone. Al loro arrivo, Correo
pensò che gli si offrisse l'occasione di agire: cominciò a mostrarsi con
pochi uomini e attaccò i primi squadroni. I nostri resistono saldamente
all'assalto, non si ammassano in un sol luogo, cosa che, quando si
verifica negli scontri di cavalleria per un senso di paura, determina un
grave danno proprio per il numero dei soldati.
[19
I nostri, divisi in squadroni, si impegnavano a turno e in ordine sparso,
senza permettere che il nemico aggirasse dai fianchi la fanteria. Ed ecco
che, mentre Correo combatteva, altri rincalzi erompono dalle selve. Si
scatenano accese mischie qua e là. Mentre la lotta si protraeva incerta, a
poco a poco dalle selve avanza a ranghi serrati il grosso della fanteria
nemica, che costringe alla ritirata i nostri cavalieri. In loro soccorso
interviene rapidamente la nostra fanteria leggera, che precedeva le
legioni, come avevo già detto: mescolati ai nostri squadroni di cavalleria
affrontano con fermezza gli avversari. Per un certo tratto ci si batte con
pari ardore; poi, conforme a una legge dei fatti d'arme, chi aveva
resistito ai primi assalti dell'imboscata, ha la meglio, proprio perché
non aveva patito lo svantaggio della sorpresa. Nel frattempo, le legioni
si avvicinano e pervengono, di continuo, ai nostri e ai nemici notizie
sull'arrivo del comandante con l'esercito in assetto di guerra. Di
conseguenza, i nostri, rassicurati dal sostegno delle coorti, moltiplicano
gli sforzi per non dover dividere l'onore del successo con le legioni, nel
caso in cui la battaglia fosse andata troppo per le lunghe. I nemici si
perdono d'animo e cercano da ogni parte vie di salvezza. Invano: vengono
intrappolati dalle difficoltà dei luoghi, in cui avevano voluto rinserrare
i Romani. Vinti e travolti, dopo aver perso il grosso delle truppe,
scappano in preda al terrore, dirigendosi verso le selve o verso il fiume,
ma tutti i fuggiaschi vengono massacrati dai nostri che li inseguivano con
accanimento. Al contempo nessuna traversia piegò Correo: né si risolse a
lasciare la mischia e a cercar riparo nelle selve, né acconsentì alla
resa, che pure i nostri gli offrivano. Anzi, poiché combatté con estremo
valore e ferì parecchi dei nostri, i vincitori, pieni d'ira, furono
costretti a bersagliarlo di frecce.
[20
Conclusasi così l'operazione, Cesare sopraggiunse mentre erano ancora
freschi i segni della battaglia e pensò che i nemici, alla notizia di una
tale disfatta, avrebbero spostato il campo, non distante - a quanto si
diceva - oltre le otto miglia, più o meno, dal luogo della strage; perciò,
nonostante il serio ostacolo rappresentato dal fiume, lo varca con
l'esercito e avanza. I Bellovaci e gli altri popoli, intanto, accolgono i
fuggiaschi, pochi e per di più feriti, che avevano evitato il peggio
grazie alle boscaglie: apprendono che era stata una catastrofe, Correo era
morto, la cavalleria e i fanti più valorosi annientati. Convinti che i
Romani sarebbero ben presto sopraggiunti, al suono delle trombe radunano
rapidamente l'assemblea e chiedono a gran voce di inviare a Cesare
emissari e ostaggi.
[21
Poiché tutti approvano la proposta, l'atrebate Commio ripara presso le
genti germaniche da cui aveva ricevuto rinforzi per la guerra in corso.
Gli altri inviano lì per lì un'ambasceria a Cesare e gli chiedono di
accontentarsi, come punizione, dei danni che avevano subito: non l'avrebbe
certo mai riservata, nella sua clemenza e umanità, neppure a nemici nel
pieno delle forze e ai quali la potesse infliggere senza colpo ferire; le
forze di cavalleria dei Bellovaci erano state distrutte; avevano perduto
la vita molte migliaia di fanti scelti, a stento si erano salvati i pochi
che avevano dato la notizia della strage. Comunque, pur di fronte a una
disfatta così grave, dalla battaglia i Bellovaci un vantaggio lo avevano
conseguito: Correo, il fautore della guerra, l'agitatore della folla, era
morto. Finché lui era in vita, infatti, il senato non aveva mai avuto
tanto potere, quanto la plebe ignorante.
[22
Agli emissari che così lo pregavano, Cesare ricorda che nello stesso
periodo, l'anno precedente, i Bellovaci e gli altri popoli della Gallia
avevano intrapreso la guerra; ma proprio loro, più di tutti, erano rimasti
ostinatamente attaccati alla decisione, né la resa degli altri li aveva
ricondotti alla ragione. Sapeva e capiva che era assai facile attribuire
ai morti la colpa dell'accaduto. Nessuno, però, è così potente da poter
provocare e sostenere guerre con il solo, fragile appoggio della plebe, se
incontra l'ostilità dei nobili, la resistenza del senato e l'opposizione
della gente onesta. Si sarebbe accontentato, tuttavia, della pena che si
erano attirati da soli.
[23
La notte successiva, gli emissari riferiscono ai loro la risposta di
Cesare e si radunano gli ostaggi. Si precipitano da Cesare le legazioni
degli altri popoli, che stavano a vedere cosa sarebbe successo ai
Bellovaci. Consegnano ostaggi, obbediscono agli ordini, tutti eccetto
Commio: la paura gli impediva di mettere la propria vita nelle mani di
chicchessia. L'anno precedente, infatti, mentre Cesare si trovava nella
Gallia cisalpina per amministrare la giustizia, T. Labieno, avendo saputo
che Commio sobillava i popoli e promuoveva una coalizione contro Cesare,
pensò che si potesse soffocare il tradimento del Gallo senza venir
tacciato di slealtà. Ritenne che Commio non avrebbe risposto a una
convocazione all'accampamento; allora, per non renderlo più cauto con un
tentativo del genere, inviò C. Voluseno Quadrato dietro pretesto di un
colloquio, ma col solo scopo di eliminarIo. Mise a sua disposizione
centurioni scelti, adatti al compito. Quando l'abboccamento ebbe luogo e
Voluseno, come erano d'accordo, afferrò la mano di Commio, il centurione,
o perché turbato dal compito insolito o per il pronto intervento del
seguito del Gallo, non riuscì a ucciderlo; tuttavia, con il primo colpo lo
ferì gravemente al capo. Le due parti sguainarono le spade, non tanto con
l'intenzione di affrontarsi, quanto di fuggire: i nostri credevano che la
ferita di Commio fosse mortale, i Galli avevano capito che si trattava di
una trappola e temevano che le insidie non si limitassero a quanto avevano
visto. Da allora, così almeno si diceva, Commio aveva deciso di non
presentarsi mai più al cospetto di un Romano.
[24
Dopo aver assoggettato le genti più bellicose, Cesare vide che ormai più
nessun popolo preparava la guerra per resistergli e che, anzi, molti
lasciavano le città e fuggivano dalle campagne per non sottostare al
dominio in atto. Decide, perciò, di inviare l'esercito in diverse zone del
paese. Unisce a sé il questore M. Antonio con la dodicesima legione. Con
venticinque coorti manda il legato C. Fabio al capo opposto della Gallia,
perché gli giungeva notizia che là alcuni popoli erano in armi e stimava
insufficiente il presidio delle due legioni agli ordini del legato C.
Caninio Rebilo, che si trovava nella zona. Richiama T. Labieno; la
quindicesima legione, che aveva svernato con Labieno, la spedisce nella
Gallia togata, a difesa delle colonie dei cittadini romani; lo scopo era
di evitare guai - dovuti alle scorrerie dei barbari - simili a quelli
capitati l'estate precedente ai Tergestini, che erano stati sorpresi da un
attacco improvviso e avevano visto saccheggiate le loro terre. Dal canto
suo, punta verso la regione di Ambiorige per devastarla e far razzie;
disperando di ridurre in suo potere l'uomo - Ambiorige, atterrito,
continuava a fuggire - stimava come cosa più confacente alla propria
dignità devastarne i territori, con popolazione, case, bestiame:
Ambiorige, odiato dai suoi, se la sorte ne avesse risparmiato qualcuno,
non avrebbe potuto ritornare nella sua città, dopo le tante sciagure che
aveva provocato.
[25
Dopo aver inviato in ogni angolo del paese di Ambiorige legioni o truppe
ausiliarie e aver seminato la desolazione con stragi, incendi, rapine,
dopo aver ucciso o catturato un gran numero di uomini, Cesare spedisce
Labieno con due legioni nelle terre dei Treveri. I Treveri, per la
vicinanza con i Germani, erano abituati a far guerra tutti i giorni; per
il loro grado di civiltà e la loro natura selvaggia non erano molto
diversi dai Germani stessi e non ubbidivano mai agli ordini, se non
costretti da un esercito.
[26
Nel frattempo, grazie a una lettera e ai messi inviati da Durazio -
rimasto sempre fedele all'alleanza con i Romani, mentre una parte del suo
popolo aveva defezionato - il legato C. Caninio, avvertito che un gran
numero di nemici si era raccolto nelle terre dei Pictoni, si dirige alla
città di Lemono. Era sul punto di raggiungerla, quando riceve dai
prigionieri informazioni più dettagliate: alla testa di molte migliaia di
uomini Dumnaco, capo degli Andi, aveva stretto d'assedio Durazio in
Lemono. Così, non osando arrischiare in uno scontro coi nemici le sue
legioni, troppo deboli, stabilì il campo in una zona ben munita. Dumnaco,
saputo dell'arrivo di Caninio, volge tutte le truppe contro le legioni e
comincia l'assalto all'accampamento dei Romani. Dopo aver speso diversi
giorni nell'attacco, a prezzo di gravi perdite e senza riuscire a far
breccia in nessun punto delle fortificazioni, Dumnaco torna ad assediare
Lemono.
[27
Nello stesso tempo il legato C. Fabio accetta la resa di parecchi popoli,
la sancisce mediante ostaggi e viene avvisato di ciò che stava accadendo
tra i Pictoni da una lettera di Caninio. A tale notizia, muove in soccorso
di Durazio. Appena lo informano dell'arrivo di Fabio, Dumnaco dispera
ormai della salvezza, perché avrebbe dovuto, a un tempo, affrontare sia i
Romani, sia i rinforzi esterni, nonché sorvegliare e temere gli abitanti
di Lemono. Con rapidità, dunque, ripiega con tutte le truppe e pensa di
non poter essere abbastanza al sicuro, se non dopo aver condotto
l'esercito oltre la Loira, un fiume che, per la sua imponenza, poteva
essere varcato solo su ponte. Fabio, anche se non aveva ancora avvistato i
nemici, né si era ricongiunto a Caninio, avvalendosi delle informazioni di
chi conosceva la natura della zona, ritenne assai probabile che i nemici,
atterriti, si sarebbero diretti là, dove effettivamente si stavano
dirigendo. Così, con le sue truppe muove verso lo stesso ponte e ordina
alla cavalleria di precedere l'esercito, ma a una distanza di marcia tale,
che le consentisse il rientro nell'accampamento comune senza affaticare i
cavalli. I nostri cavalieri, secondo gli ordini, partono all'inseguimento
e si rovesciano sulla schiera di Dumnaco: avendo aggredito i nemici, già
in fuga e atterriti, mentre erano ancora carichi di bagagli e in marcia,
ne uccidono molti, si impadroniscono di un ricco bottino. Eseguita con
successo la missione, rientrano al campo.
[28
La notte successiva Fabio manda in avanscoperta i cavalieri, pronti allo
scontro e a ritardare la marcia di tutto l'esercito nemico fino all'arrivo
di Fabio stesso. Perché le cose procedessero secondo gli ordini, Q. Azio
Varo, prefetto della cavalleria, uomo di straordinario coraggio e senno,
sprona i suoi e, dopo aver inseguito le schiere nemiche, dispone una parte
degli squadroni in zone favorevoli, mentre con il resto attacca battaglia.
La cavalleria nemica si batte con particolare audacia, perché a essa
subentravano i fanti, che, piazzatisi lungo tutta la colonna, recavano
aiuto ai propri cavalieri contro i nostri. Si accende un'aspra battaglia.
I nostri, infatti, disprezzavano i nemici già sconfitti il giorno
precedente e, ben sapendo che le legioni erano in arrivo, combattevano
contro i fanti con straordinario ardore, sia per la vergogna di
un'eventuale ritirata, sia per il desiderio di risolvere da soli la
battaglia; i nemici, dal canto loro, in base all'esperienza del giorno
precedente, credevano che non sarebbero giunte altre truppe romane e
pensavano di avere trovato l'occasione per annientare la nostra
cavalleria.
[29
La battaglia proseguiva già da un pezzo, violentissima. Dumnaco schiera in
formazione i fanti, in modo che loro e i cavalieri potessero darsi
reciproco aiuto. Ma ecco apparire, all'improvviso, le legioni a ranghi
serrati. A tale vista gli squadroni nemici sono colti da terrore, si
diffonde il panico tra i fanti, lo scompiglio regna tra le salmerie: con
alti clamori corrono qua e là, si danno a una fuga disordinata. Allora i
nostri cavalieri, che poco prima si erano battuti con estremo valore
contro la resistenza degli avversari, trascinati dalla gioia per la
vittoria, levano alte grida da ogni parte e circondano i nemici in rotta:
finché i cavalli hanno la forza di inseguire e le destre di tirar
fendenti, seminano morte. Così, dopo aver ucciso più di dodicimila nemici,
che fossero in armi oppure che le avessero gettate per il panico,
catturano tutta la colonna delle salmerie.
[30
Si viene a sapere che, dopo la fuga, il senone Drappete aveva raccolto non
più di duemila fuggiaschi e puntava contro la provincia (costui,
all'inizio dell'insurrezione in Gallia, aveva raccattato dovunque dei
furfanti, spinto gli schiavi alla libertà, chiamato a sé gli esuli di
tutte le genti, riuscendo poi, con razzie improvvise, a intercettare le
salmerie e i rifornimenti dei Romani). Con lui aveva preso l'iniziativa il
cadurco Lucterio, che all'inizio della defezione della Gallia aveva deciso
di attaccare la provincia, come sappiamo dal precedente commentario. Il
legato Caninio, alla testa di due legioni, parte al loro inseguimento, per
evitare che, per via dei danni o dei timori nutriti dalla provincia, su di
noi ricadesse grave onta per le scorrerie di un gruppo di criminali.
[31
C. Fabio, con il resto delle truppe, si dirige verso i Carnuti e gli altri
popoli, perché sapeva che le loro truppe avevano registrato gravi perdite
nella battaglia da lui combattuta contro Dumnaco. Non dubitava che dopo la
recente disfatta avrebbero abbassato la testa; ma passato un certo periodo
di tempo, avrebbero anche potuto riprendere la rivolta per istigazione
dello stesso Dumnaco. Nella circostanza C. Fabio agisce con la più felice
e rapida prontezza nel sottomettere i vari popoli. I Carnuti, che
nonostante i ripetuti rovesci non avevano mai chiesto pace, adesso gli
consegnano ostaggi e si arrendono; le altre genti, stanziate nelle regioni
più lontane della Gallia, che si affacciano sull'Oceano e si chiamano
aremoriche, indotte dal prestigio dei Carnuti, obbediscono agli ordini
senza frapporre indugi, appena arriva C. Fabio con le legioni. Dumnaco,
cacciato dalle sue terre, è costretto a vagare, solo e nascosto, e a
dirigersi verso le regioni estreme della Gallia.
[32
Ma Drappete e Lucterio, appreso l'arrivo di Caninio e delle legioni,
convinti di non poter entrare in provincia senza andar incontro a una
sicura disfatta - tanto più che li inseguiva l'esercito romano - e di non
aver più la libera possibilità di spostarsi e di compiere razzie, si
fermano nei territori dei Cadurci. Un tempo, quando le cose erano
tranquille, Lucterio aveva presso i suoi concittadini grande potere e
anche adesso, instancabile fautore di piani di rivolta, godeva tra i
barbari di grande autorità. Perciò, con i soldati suoi e di Drappete,
occupa la città di Uxelloduno, molto ben protetta per posizione e che era
già stata in passato sotto la sua tutela, e guadagna alla sua causa gli
abitanti.
[33
C. Caninio giunge lì in tutta fretta e si accorge che la città, su tutti i
lati, era difesa da rocce a picco, di modo che, pur in assenza di
difensori, la scalata risultava comunque difficile per degli armati.
D'altro canto, vede la quantità di salmerie degli assediati: se i barbari
avessero cercato di portarle via di nascosto, non avrebbero potuto
sfuggire non dico alla cavalleria, ma neppure alle legioni. Allora divide
in tre gruppi le coorti e pone tre distinti campi in un luogo molto
elevato. Da qui, a poco a poco, per quanto permetteva il numero delle sue
truppe, cominciò a circondare la città con un vallo.
[34
Appena se ne accorgono, gli assediati, inquieti per il tristissimo ricordo
di Alesia, temono l'eventualità di un blocco simile. Tra tutti Lucterio in
particolare, che quel pericolo lo aveva corso, invita a preoccuparsi del
grano. Decidono, per consenso generale, di lasciare lì parte dell'esercito
e di recarsi personalmente in cerca di frumento con truppe leggere.
Approvata la decisione, la notte successiva Drappete e Lucterio lasciano
duemila armati in città e si allontanano con i rimanenti. Si trattengono
pochi giorni e raccolgono una gran quantità di grano nelle terre dei
Cadurci, che in parte desideravano aiutarli nell'approvvigionamento, in
parte non potevano impedirne la raccolta. Di tanto in tanto, poi,
attaccano le nostre ridotte con assalti notturni. Per tale motivo, Caninio
rallenta i lavori di fortificazione tutt'intorno alla città, nel timore di
non poterli difendere, una volta terminati, oppure di essere costretto a
dislocare in più settori guarnigioni troppo deboli.
[35
Dopo essersi procurati grandi scorte di grano, Drappete e Lucterio si
attestano a non più di dieci miglia dalla città, nell'intento di portare
da qui, a poco a poco, il grano entro le mura. Si dividono le incombenze:
Drappete con parte delle truppe rimane al campo per difenderlo, Lucterio
guida verso la città le bestie da soma. Dispone dei presidi e, verso l'ora
decima della notte, comincia a introdurre il grano in città per anguste
strade tra i boschi. Ma i rumori della colonna in movimento erano stati
uditi dalle sentinelle del nostro campo: quando gli uomini mandati in
esplorazione riferiscono cosa stava accadendo, dalle ridotte più vicine
Caninio esce rapidamente con le coorti già pronte e, sul fare dell'alba,
attacca i nemici occupati nel trasporto del grano. I Galli, sconvolti
dall'attacco improvviso, fuggono verso i loro posti di difesa; non appena
i nostri videro i nemici armati, con furia ancora maggiore si lanciarono
su di essi e non ne fecero prigioniero nessuno. Da qui Lucterio cerca
scampo con pochi dei suoi, senza neppure rientrare al campo.
[36
Condotta a termine con successo l'operazione, Caninio apprende dai
prigionieri che parte delle truppe, con Drappete, era rimasta
nell'accampamento a non più di dodici miglia. La cosa gli viene confermata
da diverse fonti ed egli si rende conto che, dopo la rotta di uno dei due
capi, poteva con facilità schiacciare gli altri nemici atterriti, ma
riteneva ben difficile l'eventualità per lui più fortunata, ossia che
qualche superstite fosse rientrato all'accampamento nemico, portando a
Drappete la notizia della disfatta subita. Fare un tentativo, comunque,
gli sembrava che non comportasse alcun rischio: manda in avanti, verso il
campo nemico, la cavalleria al completo e i fanti germanici, uomini
straordinariamente veloci; dal canto suo, sistema una legione nei tre
diversi accampamenti, l'altra la porta con sé senza bagagli. Quando è
ormai vicino al nemico, gli esploratori, mandati in avanscoperta, lo
avvisano che i barbari, secondo la loro consuetudine, avevano lasciato le
alture e posto il campo lungo le rive del fiume; inoltre, i Germani e i
cavalieri erano piombati all'improvviso sui nemici che non se
l'aspettavano e avevano attaccato battaglia. Appena lo sa, avanza con la
legione in armi e schierata. Così, al segnale, da tutte le parti
repentinamente i nostri occupano le alture. Subito i Germani e i
cavalieri, avendo visto le insegne della legione, combattono con estremo
ardore. Le coorti si lanciano immediatamente all'attacco da ogni lato:
tutti i nemici vengono uccisi o catturati, i nostri si impadroniscono di
un grande bottino. Nella battaglia cade prigioniero lo stesso Drappete.
[37
Caninio, dopo aver compiuto con grande successo la missione, quasi
senz'alcun ferito, ritorna ad assediare la città. Adesso che aveva
annientato il nemico esterno, per timore del quale prima non aveva potuto
dividere i presidi e stringere d'assedio gli abitanti con un'opera di
fortificazione, ordina di procedere ai lavori su tutta la linea. Il giorno
seguente giunge C. Fabio con tutte le truppe e assume il comando delle
operazioni d'assedio per un settore della città.
[38
Cesare, frattanto, lascia il questore M. Antonio tra i Bellovaci con
quindici coorti, per togliere ai Belgi la possibilità di scatenare altre
rivolte. Dal canto suo, visita gli altri popoli, impone nuovi ostaggi,
tranquillizza e rassicura la gente tutta in preda alla paura. Poi, giunge
nelle terre dei Carnuti, dove era scoppiata l'insurrezione, come Cesare ha
esposto nel precedente commentario. Siccome intuiva che i Carnuti, consci
della loro colpa, nutrivano forti apprensioni, al fine di liberare al più
presto la popolazione da ogni timore esige la punizione del responsabile
del crimine e istigatore della guerra, Gutuatro. Tutti, anche se non si
era mai messo nelle mani dei suoi concittadini, gli dettero rapidamente la
caccia con zelo, e fu condotto al nostro campo. Cesare, contro la propria
natura, è costretto a giustiziarlo per l'accorrere in massa dei soldati,
che in Gutuatro vedevano il responsabile di tutti i pericoli e le pene
patite in guerra; colpito a nerbate fino a perdere la conoscenza, fu poi
decapitato con la scure.
[39
Mentre era ancora dai Carnuti, grazie alle frequenti lettere di Caninio
viene informato delle novità di Drappete e Lucterio e dell'irriducibile
resistenza degli abitanti di Uxelloduno. Cesare, sebbene ne disprezzasse
lo scarso numero, giudicava di dover infliggere a tanta pervicacia una
dura lezione, perché la Gallia intera non pensasse che nella resistenza ai
Romani le era mancata non la forza, ma la costanza, oppure per evitare
che, seguendo l'esempio, gli altri popoli cercassero di rendersi liberi,
confidando sui vantaggi dei luoghi; inoltre, a tutti i Galli - ben lo
sapeva - era noto che gli restava una sola estate da passare in provincia,
e se per quel lasso di tempo riuscivano a resistere, non avrebbero più
dovuto temere alcun pericolo. Così, lascia il legato Q. Caleno con due
legioni e lo incarica di seguirlo a tappe normali; dal canto suo, si
dirige il più velocemente possibile alla volta di Caninio con tutta la
cavalleria.
[40
Dopo aver raggiunto Uxelloduno contro le aspettative di tutti, vede che la
città è già serrata dalle nostre fortificazioni e si rende conto che non
si può più recedere dall'assedio. Saputo dai fuggiaschi che in città
c'erano abbondanti scorte di grano, cercò di tagliare i rifornimenti
idrici. Un fiume scorreva in mezzo a una valle profonda, che attorniava
quasi tutto il monte su cui sorgeva Uxelloduno. La conformazione naturale
della zona impediva di deviarlo: scorreva, infatti, così vicino ai piedi
del monte, che non era assolutamente possibile scavare canali di
derivazione. Ma gli assediati, per raggiungere il fiume, dovevano
discendere una china disagevole e molto ripida: se i nostri li
ostacolavano, non sarebbero riusciti né ad arrivare al fiume, né a
ritirarsi per l'erta salita, senza il rischio di ferite o addirittura di
morte. Appena Cesare si rese conto di tale difficoltà dei nemici, appostò
arcieri e frombolieri e dispose anche macchine da lancio proprio nelle
zone di fronte ai sentieri più praticabili, impedendo agli abitanti di
attingere acqua dal fiume.
[41
Allora tutta la gente della città scese a prendere l'acqua in un solo
luogo, proprio ai piedi delle mura, dove sgorgava una grande fonte, in
corrispondenza della zona in cui, per un intervallo di circa trecento
piedi, il fiume non chiudeva il suo anello intorno al monte. Tutti
avrebbero voluto impedire agli assediati di avvicinarsi alla fonte, ma
solo Cesare ne vide il modo: proprio dirimpetto cominciò a spingere le
vinee sulle falde del monte e a costruire un terrapieno, a prezzo di
grandi fatiche e continui scontri. Gli assediati, infatti, correvano giù
dalle loro posizioni dominanti e dall'alto combattevano senza rischi e
colpivano molti dei nostri che continuavano ad avanzare con tenacia; i
nostri soldati, comunque, non si lasciano distogliere dal sospingere le
vinee e dal superare le difficoltà del terreno con faticosi lavori. Al
contempo, scavano gallerie sotterranee verso le vene e l'alveo della
sorgente, un'operazione che si poteva effettuare senza alcun rischio. né
sospetto da parte dei nemici. Viene costruito un terrapieno alto sessanta
piedi, su cui è posta una torre di dieci piani, che doveva non tanto
raggiungere l'altezza delle mura (un risultato impossibile con qualsiasi
tipo di costruzione), quanto sovrastare il luogo dove nasceva la sorgente.
Dalla torre le macchine da lancio scagliavano dardi verso l'accesso alla
fonte e gli abitanti non potevano rifornirsi senza pericolo. Così, non
solo il bestiame e i giumenti soffrivano la sete, ma anche la grande massa
dei nemici.
[42
Atterriti dal pericolo, gli abitanti riempiono barili di sego, pece,
assicelle, gli danno fuoco e li fanno rotolare sulle nostre costruzioni.
Nello stesso tempo attaccano risolutamente, in modo che la lotta
minacciosa distolga i Romani dall'estinguere l'incendio. Subito alte
fiamme si levano in mezzo alle nostre opere di difesa. Infatti, i barili,
dovunque rotolassero a precipizio lungo la china, bloccati dalle vinee e
dal terrapieno, appiccavano il fuoco agli ostacoli sul loro cammino.
Tuttavia, i nostri soldati, benché costretti a un genere di combattimento
pericoloso e in posizione sfavorevole, tenevano testa a tutte le avversità
con indomito coraggio. Lo scontro difatti si svolgeva in alto, davanti
agli occhi del nostro esercito; da entrambe le parti si levavano alte
grida. Così, quanto più uno era conosciuto per il suo coraggio, tanto più
si esponeva ai dardi dei nemici e alle fiamme, per rendere ancor più noto
e provato il suo valore.
[43
Cesare, vedendo che parecchi dei suoi venivano colpiti, ordina alle coorti
di scalare il monte da tutti i lati della città e di levare dappertutto
violenti clamori, simulando di dover occupare le mura. Gli abitanti,
terrorizzati dalla nostra manovra, inquieti su ciò che succedeva altrove,
richiamano i soldati che attaccavano le nostre costruzioni e li dispongono
sulle mura. Così, i nostri, chiusosi lo scontro, presto in parte domano,
in parte isolano l'incendio che si era propagato sulle nostre difese.
Eppure gli assediati continuavano testardamente la difesa e, pur avendo
perso per sete gran parte dei loro, rimanevano fermi nel loro proposito;
alla fine i nostri, con le gallerie, riuscirono a tagliare le vene della
sorgente e a deviare l'acqua. Il che inaridì all'improvviso una fonte
perenne e provocò negli abitanti la caduta di ogni speranza, al punto che
pensarono si trattasse non di opera umana, ma della volontà divina. Così,
costretti dalla necessità, si arresero.
[44
Cesare sapeva che a tutti era nota la sua mitezza e non temeva di apparire
un individuo crudele se avesse assunto provvedimenti piuttosto severi;
d'altronde, non vedeva sbocco ai suoi disegni, se in diverse zone i Galli
avessero continuato a prendere iniziative del genere. Ritenne opportuno,
allora, dissuadere gli altri con un castigo esemplare. Dunque, mozzò le
mani a chiunque avesse impugnato le armi, ma li mantenne in vita, per
lasciare più concreta testimonianza di come puniva i traditori. Drappete,
catturato da Caninio, come ho detto, o per l'umiliazione e il dolore delle
catene o per la paura di un supplizio ancor più atroce non toccò cibo per
un po' di giorni e così morì. Nello stesso tempo Lucterio, che era fuggito
dopo la battaglia, come ho scritto in precedenza, aveva affidato la
propria persona all'arverno Epasnacto (infatti, mutando luogo di
frequente, si metteva nelle mani di molti, poiché gli sembrava rischioso
dimorare troppo a lungo in qualsiasi posto, ben conscio di quanto doveva
essergli nemico Cesare). L'arverno Epasnacto, però, fedelissimo alleato
del popolo romano, senz'alcuna esitazione lo mette in catene e lo consegna
a Cesare.
[45
Labieno, nel frattempo, giunge a uno scontro di cavalleria nelle terre dei
Treveri, con successo; uccisi molti dei Treveri e dei Germani, che non
negavano a nessuno rinforzi contro i Romani, ridusse in suo potere, vivi,
i capi nemici, tra cui l'eduo Suro, che godeva di straordinaria fama
quanto a valore e nobiltà ed era il solo tra gli Edui a non aver ancora
deposto le armi.
[46
Appena ne è informato, Cesare, constatato che in tutte le parti della
Gallia le operazioni erano state condotte con successo, giudicando che
dopo la campagna estiva dell'anno precedente il paese era ormai vinto e
piegato, visto che non si era mai recato in Aquitania, ma l'aveva solo
parzialmente sconfitta grazie a P. Crasso, con due legioni si dirige in
quella regione della Gallia, per spendervi l'ultimo periodo della campagna
estiva. Come in tutti gli altri casi, porta a termine le operazioni con
rapidità e successo. Infatti, tutti i popoli dell'Aquitania inviarono a
Cesare emissari e gli consegnarono ostaggi. Quindi, con la scorta della
cavalleria parte per Narbona e incarica i legati di condurre l'esercito ai
quartieri d'inverno. Stanziò in Belgio quattro legioni con M. Antonio e i
legati C. Trebonio e P. Vatinio; due le trasferì nelle terre degli Edui,
di cui ben conosceva il prestigio in tutta la Gallia; presso i Turoni, al
confine coi Carnuti, ne collocò due per tenere a bada tutta quella regione
che si affacciava sull'Oceano; le due rimanenti le pose nei territori dei
Lemovici, non lontano dagli Arverni, per non lasciare sguarnita nessuna
parte della Gallia. Si trattenne in provincia pochi giorni, toccò
rapidamente tutti i centri giudiziari, venne informato dei conflitti
politici, attribuì premi ai benemeriti (del resto, per lui era assai
facile capire quali sentimenti ciascuno avesse nutrito durante
l'insurrezione di tutta la Gallia, a cui aveva potuto far fronte grazie
alla lealtà e al sostegno della suddetta provincia). Sistemate tali
faccende, rientrò presso le legioni stanziate in Belgio e svernò a
Nemetocenna.
[47
Qui lo avvertirono che l'atrebate Commio era venuto a battaglia con la sua
cavalleria. Quando Antonio era giunto agli accampamenti invernali, il
popolo degli Atrebati era rimasto fedele. Ma Commio, da quando era stato
ferito - l'ho ricordato in precedenza - era sempre a disposizione dei suoi
concittadini, pronto a ogni sollevazione, perché non mancasse, a chi
voleva la guerra, un fomentatore e un capo. Adesso, poiché il suo popolo
obbediva ai Romani, Commio viveva di scorrerie con i suoi cavalieri e,
infestando le strade, intercettava spesso le colonne di rifornimenti
dirette ai quartieri d'inverno dei Romani.
[48
Ad Antonio era stato assegnato il prefetto della cavalleria C. Voluseno
Quadrato, che svernava con lui. Antonio lo manda a inseguire la cavalleria
nemica. Voluseno, allo straordinario valore, accompagnava un odio feroce
nei confronti di Commio, perciò obbedì all'ordine ancor più volontieri.
Così, tendendo imboscate, attaccava con notevole frequenza i cavalieri
nemici e dava vita a scontri coronati da successo. In ultimo, mentre si
combatteva con particolare asprezza, Voluseno, con pochi dei suoi, insegue
Commio con eccessiva ostinazione, per la smania di catturarlo; e quello,
fuggendo a precipizio, costringe Voluseno ad allontanarsi troppo. Poi,
nemico com'era di Voluseno, all'improvviso fa appello alla fedeltà e
all'aiuto dei suoi, chiede loro di non lasciar invendicate le ferite che
gli erano state inferte a tradimento: volge il cavallo e, spingendosi
davanti a tutti, si lancia inaspettatamente contro il prefetto.
Altrettanto fanno i suoi cavalieri: costringono i pochi nostri a volgere
le spalle e li inseguono. Commio, pungolando ferocemente coi talloni il
cavallo, affianca il destriero di Quadrato e, lancia in resta, gli
trapassa con violenza la coscia. Vedendo il prefetto colpito, i nostri non
esitano a bloccarsi di colpo, volgono i cavalli e respingono il nemico.
Subito molti degli avversari, scombussolati dall'impetuoso assalto dei
nostri, vengono feriti; alcuni cadono sotto gli zoccoli dei cavalli mentre
cercavano la fuga, altri sono catturati. Il comandante nemico, grazie alla
velocità del suo cavallo, riesce a scamparla; in quella battaglia
vittoriosa, però, il prefetto romano rimase gravemente ferito, al punto
che sembrava dovesse morire, e fu riportato all'accampamento. Ma Commio,
vuoi, che sentisse placato il proprio rancore, vuoi per la perdita della
maggior parte dei suoi, invia una legazione ad Antonio: sarebbe rimasto
dove gli avesse ordinato e avrebbe obbedito a ogni comando, sancendo la
promessa con l'invio di ostaggi; di una sola cosa lo pregava, che, in
ragione del suo timore, gli fosse concesso di non comparire al cospetto di
nessun romano. Antonio, giudicando che la richiesta nasceva da una giusta
paura, accordò il permesso e accolse gli ostaggi.
So che Cesare ha composto singoli commentari per ciascun anno, ma non ho
ritenuto il caso di fare altrettanto, perché l'anno seguente, durante il
consolato di L. Paolo e C. Marcello, non si verificarono in Gallia imprese
di rilievo. Tuttavia, perché si sappia in quali zone rimasero in
quell'anno Cesare e l'esercito, ho deciso di scrivere poche pagine e di
unirle al presente commentario.
[49
Cesare, mentre svernava in Belgio, mirava a un unico scopo: tener legate
all'alleanza le varie genti e non fornire a nessuno speranze o motivi di
guerra. Infatti, niente gli pareva meno auspicabile, alla vigilia della
sua uscita di carica, che trovarsi costretto ad affrontare un conflitto;
altrimenti, al momento della sua partenza con l'esercito, si sarebbe
lasciato alle spalle una guerra che tutta la Gallia avrebbe intrapreso con
entusiasmo, liberata dal pericolo della sua presenza. Così, distribuendo
titoli onorifici ai vari popoli, accordando grandissime ricompense ai loro
principi, non imponendo nuovi oneri, la Gallia, prostrata da tante
sconfitte, riuscì con facilità a tenerla in pace, garantendo più lieve
l'assoggettamento.
[50
Alla fine dell'inverno, contro la sua abitudine, si diresse a marce
forzate in Italia, per rivolgersi ai municipi e alle colonie, a cui aveva
raccomandato la candidatura al sacerdozio di M. Antonio, suo questore. Da
un lato, ben volentieri faceva valere tutto il suo prestigio per un uomo a
lui così legato, che poco prima aveva mandato a presentare la sua
candidatura; dall'altro voleva colpire duramente il potente partito di
quei pochi che, con una sconfitta elettorale di M. Antonio, desideravano
minare l'autorità di Cesare, allo scadere della sua carica. E anche se
durante il viaggio, prima di giungere in Italia, aveva saputo che M.
Antonio era stato eletto augure, stimò di avere, nondimeno, un buon motivo
per visitare i municipi e le colonie, perché voleva ringraziarli di aver
accordato ad Antonio il loro favore con un'affluenza davvero massiccia.
Allo stesso tempo voleva raccomandare la propria candidatura per il
consolato dell'anno successivo, visto che i suoi avversari con insolenza
menavano vanto sia per l'elezione di L. Lentulo e C. Marcello, creati
consoli, al solo scopo di spogliare Cesare di ogni carica e dignità, sia
di aver sottratto il consolato a Ser. Galba, che, nonostante godesse di
maggior credito e avesse raccolto più voti, era stato escluso per i suoi
vincoli di parentela con Cesare e la lunga militanza come suo legato.
[51
L'arrivo di Cesare fu accolto con incredibili onoranze e manifestazioni
d'affetto da parte dei municipi e delle colonie. Era la prima volta,
infatti, che giungeva dopo la famosa sollevazione generale della Gallia.
Di tutto ciò che si poteva escogitare, niente fu tralasciato per ornare le
porte, le vie e tutti i luoghi in cui Cesare doveva passare. Tutta la
popolazione, insieme ai bambini, gli si faceva incontro, dappertutto
venivano immolate vittime, le piazze e i templi erano pieni di mense
imbandite: si poteva pregustare la gioia di un trionfo davvero
attesissimo. Così grande era la magnificenza dispiegata dai ricchi,
l'entusiasmo manifestato dai poveri.
[52
Dopo aver percorso tutte le regioni della Gallia togata, con estrema
rapidità Cesare rientrò a Nemetocenna presso l'esercito; richiamate nelle
terre dei Treveri le legioni che erano nei campi invernali, le raggiunse e
passò in rassegna le truppe. Pose T. Labieno a capo della Gallia togata,
per guadagnare un maggior favore alla sua candidatura al consolato.
Spostava l'esercito di tanto, quanto gli pareva utile mutare i luoghi per
ragioni igieniche. In quel periodo gli giungeva ripetutamente voce che i
suoi avversari facevano pressioni su Labieno e veniva avvertito che, per
le manovre di pochi, si cercava di sottrargli parte delle truppe mediante
un intervento del senato. Tuttavia, non prestò fede alle voci su Labieno,
né si lasciò indurre ad atti che contrastassero con l'autorità del senato.
Era convinto, infatti, che se vi fosse stata una libera votazione dei
senatori, la sua causa avrebbe prevalso con facilità. E C. Curione,
tribuno della plebe, avendo preso a difendere le ragioni e l'onore di
Cesare, aveva più volte detto al senato che, se il timore delle armi di
Cesare infastidiva qualcuno, il potere assoluto e gli armamenti di Pompeo
incutevano al foro non meno terrore, e aveva proposto che entrambi
deponessero le armi e congedassero i loro eserciti: la città, così,
sarebbe ritornata libera e indipendente. E non si limitò a proporlo, ma
prese, lui, l'iniziativa di una votazione per spostamento: a essa si
opposero i consoli e gli amici di Pompeo e tirarono in lungo la cosa fino
a che l'assemblea non si sciolse.
[53
Era una prova lampante dell'unanimità del senato e coincideva con quanto
era accaduto in precedenza. L'anno prima, infatti, M. Marcello aveva
cercato di scalzare Cesare dalla sua carica e, contro una legge di Pompeo
e Crasso, aveva tenuto al senato una relazione sulle province di Cesare,
prima della scadenza del mandato. Dopo la discussione, Marcello, che
ricercava ogni prestigio politico dalla sua ostilità contro Cesare, aveva
messo ai voti la sua proposta, ma il senato, compatto, l'aveva respinta.
L'insuccesso non aveva demoralizzato i nemici di Cesare, anzi li incitava
a prepararsi a misure più gravi, con cui costringere il senato ad
approvare ciò che loro volevano.
[54
Il senato, in seguito, decise che per la guerra contro i Parti Cn. Pompeo
e C. Cesare inviassero una legione a testa; ma è chiaro che le due legioni
sono sottratte a uno solo. Cn. Pompeo, infatti, diede, come proveniente
dalle sue, la prima legione, da lui inviata a Cesare dopo averla arruolata
nella provincia di Cesare stesso. Quest'ultimo, tuttavia, benché non ci
fossero dubbi sulle intenzioni dei suoi avversari, restituì la legione a
Pompeo e, a proprio titolo, rispettando la delibera del senato, invia la
quindicesima, dislocata in Gallia cisalpina. Al posto di questa, invia in
Italia la tredicesima legione, a protezione dei posti di difesa evacuati
dalla quindicesima. Assegna all'esercito i quartieri d'inverno: situa C.
Trebonio in Belgio con quattro legioni e con altrettante invia C. Fabio
nelle terre degli Edui. Pensava che, così, la Gallia sarebbe stata
veramente sotto controllo, se le truppe avessero tenuto a bada i Belgi,
che erano i più valorosi, e gli Edui, che godevano di grandissimo
prestigio. Dal canto suo, parte per l'Italia.
[55
Appena vi giunge, viene a sapere che, per iniziativa del console C.
Marcello, le due legioni da lui fornite per la guerra contro i Parti, come
da ordine del senato, erano invece state assegnate a Cn. Pompeo e
trattenute in Italia. L'accaduto non lasciava dubbi su che cosa stessero
tramando contro di lui, ma Cesare decise di sopportare tutto, finché gli
restava qualche speranza di risolvere la questione in termini di diritto
piuttosto che con le armi. Si diresse... |
© 2000-2020 LMB
|